«Ita res accedent lumina rebus» (I, 1117), ‘così le cose accenderanno la luce su altre cose’1.. Un radicale immanentismo -che esclude presenze trascendenti, forze incomprensibili, demoni terrorizzanti- permette a Lucrezio di descrivere il mondo in maniera profonda e plausibile. Un mondo composto di primi principi -gli atomi-; della struttura infinita nella quale si muovono -il vuoto-; dello spaziotempo che l’unione di atomi e vuoto produce. I sei libri del De rerum natura hanno questo fondamento fisico/razionale, sul quale è costruita l’analisi del microcosmo (libri I e II), del corpomente (libri III e IV), del macrocosmo (V e VI).
Gli atomi sono l’elemento fondamentale della materia che non ha inizio né fine poiché «nil posse creari de nihilo» (I, 155-156), nulla dal nulla si genera «aeternaque materies est» (I, 245) e la materia è eterna. Aggregazione e disgregazione degli atomi costituiscono ciò che noi definiamo nascita e morte. «Spatium sine fine modoquest» (II, 92), lo spazio senza fine e misura, l’universo eterno e infinito, esiste come movimento continuo, senza pause né posa, il quale fa sì che «semper in assiduo motu res quaeque geruntur» (I, 995), sempre in continuo moto si svolgono tutte le cose.
Come Spinoza, Lucrezio ritiene che l’idea di una o più divinità personali sia nata dall’ignoranza e dalla paura, poiché gli umani «vedono prodursi in terra e in cielo molti fenomeni / di cui in nessun modo possono scorgere le cause, / e credono che si producono per volere divino. / Pertanto, quando avremo veduto che nulla si può creare / dal nulla, allora di qui penetreremo più sicuramente / ciò che cerchiamo e donde si possa creare ogni cosa / e in qual modo tutte le cose avvengano senza interventi di dèi» (I, 151-158). E come Spinoza Lucrezio ritiene che teleologismo e antropocentrismo siano degli errori tanto diffusi quanto esiziali: «Ma quando immaginano / che gli dèi abbiano disposto tutte le cose per causa degli uomini, / sotto ogni aspetto si vede che molto s’allontanano dalla verità» (II, 174-176). La prospettiva teleologica nasconde infatti a se stessa che la materia è in sé perfetta, poiché è in ogni istante ciò che deve essere secondo le leggi che la muovono, ma riferita agli umani e in generale ai viventi essa è intrisa di dolore, di imperfezione, di limite. Lucrezio parla esplicitamente di ‘colpa’: «nequaquam nobis divinitus esse creatam / naturam mundi: tanta stat praedita culpa» (II, 180-181), la natura del mondo non è stata creata dal volere divino per noi: di così grande difetto essa è dotata. Due versi, questi, che ritornano quasi identici anche nel libro V, 198-199: «nequaquam nobis divinitus esse paratam / naturam rerum: tanta stat praedita culpa».
La materia perfetta e insieme intrisa di limite si volge senza posa nello spazio eterno, generando il divenire infinito di tutti gli enti, eventi e processi, poiché «lapides quoque vinci cernis ab aevo» (V, 306), ‘anche le pietre sono vinte dal tempo / che le alte torri cadono in rovina e le rocce si sgretolano, / che i templi e le statue degli dèi rovinati si fendono, / e il santo nume non può differire i termini del fato, / né lottare contro le leggi della natura’ (V, 306-310).
Lucrezio enuncia un vero e proprio trionfo del tempo in quanto «mutat enim mundi naturam totius aetas, / ex alioque alias status excipere omnia debet, / nec manet ulla sui simili res: omnia migrant, / omnia commutat natura et vertere cogit / […] Sic igitur mundi naturam totius aetas» (V, 828-834), ‘Il tempo infatti muta la natura di tutto il mondo, / e in tutte le cose a uno stato deve subentrarne un altro, / né alcunché resta simile a se stesso: tutte le cose passano, / tutte la natura le trasmuta e le costringe a trasformarsi […] / Così dunque il tempo muta la natura di tutto il mondo’. Così il volgere del tempo trasforma l’identità degli enti, «sic unumquicquid paulatim protratti aetas / in medium ratioque in luminis erigiti oras» (V, 1454-1455), ‘così gradatamente il tempo rivela ogni cosa / e la ragione la innalza alle plaghe della luce’.
Perfetto come la materia è il divino poiché per Lucrezio la materia è il divino. Un’equazione che appare chiara pur se espressa in un linguaggio metaforico e poetico. «Infatti è necessario che ogni natura divina goda di per sé vita immortale con somma pace, / remota dalle nostre cose e immensamente distaccata. / Ché immune da ogni dolore, immune da pericoli, / in sé possente di proprie risorse, per nulla bisognosa di noi, / né dalle benemerenze è avvinta, né è toccata dall’ira» (I, 44-49; versi che si ripetono identici in II, 646-651). Quale migliore descrizione è possibile formulare della materia e della sua perfezione libera da ogni sensibilità, malattia, angoscia, bisogno, risentimento, dolore?
Aver applicato a tale perfezione i criteri umani ha prodotto le religioni generatrici del male, come all’inizio del poema Lucrezio afferma a proposito del sacrificio di Ifigenia agli dèi da parte del padre Agamennone, e come potremmo aggiungere con molta maggior forza e documentazione a proposito dei mali che i monoteismi a dismisura producono: «Tantum religio potuit suadere malorum» (I, 101).
Il timore del divino, il divino come terrore, costituisce uno dei più gravi elementi di sofferenza della condizione umana, che Lucrezio analizza senza infingimenti e illusioni. Ciò che afferma a proposito della terribile e magnifica descrizione della peste di Atene del 430 può infatti valere per ogni momento dell’umana avventura: «perturbata animi mens in maerore metuque» (VI, 1183), ‘la mente sconvolta, immersa nella tristezza e nel timore’ si consuma «in tenebris vitae quantisque periclis» (II, 15), in tenebre e assai grandi pericoli.
«Quidve mali foret in rebus mortalibu’ passim» (VI, 29), quanto male -davvero- è sparso tra le vite e gli eventi mortali. A uno di essi Lucrezio dedica pagine e versi di formidabile forza: l’amore. Esattamente come in Proust, l’oggetto amoroso appare miraggio riflesso ombra, se non vero e proprio inganno. E appare anche come tensione e umiliazione costanti nel trascorrere la vita in attesa del cenno di un’altra persona, «alterius sub nutu degitur aetas» (IV, 1122), concordando in questo con Céline: «Piroettare, scalpitare… fare il bello, sulle vostre zampe anteriori, su un piede, l’altro, per avere l’elemosina di un sorriso…»2.
La fenomenologia lucreziana dell’amore è assai chiara e nei suoi versi si esprime con molta forza: «Questa è Venere per noi; e di qui viene il nome di amore, / di qui quella goccia della dolcezza di Venere stillò / prima nel cuore, e le susseguì il gelido affanno. / Infatti se è assente l’oggetto del tuo amore, son tuttavia presenti / le sue immagini, e il dolce nome non abbandona le tue orecchie. / Ma conviene fuggire quelle immagini e respingere via da sé / ciò che alimenta l’amore e volgere la mente ad altro oggetto / e spandere in altri corpi, quali che siano, l’umore raccolto, / e non trattenerlo essendo rivolto una volta per sempre all’amore / d’una persona sola, e così riservare a sé stesso affanno e sicuro dolore. / Giacché la piaga s’inacerbisce e incacrenisce, a nutrirla, / e di giorno in giorno la follia aumenta e la sofferenza s’aggrava, / se non scacci con nuove piaghe le prime ferite, e non le curi / vagando con Venere vagabonda mentre sono ancora fresche, / o trovi modo di rivolgere altrove i moti dell’animo. / Né dei frutti di Venere è privo colui che evita l’amore, / ma piuttosto coglie le gioie che sono senza pena. / Giacché certo agli assennati ne viene un piacere più puro / che ai malati d’amore» (IV, 1058-1076). Sì, «haec Venus est nobis»: questo è l’amore per noi, un simulacro con il quale «Venus ludit amantis», Venere illude gli amanti (IV, 1101), nell’impossibilità -che Roland Barthes ha efficacemente descritto- del possesso dell’Altro: «Nec penetrare et agire in corpus corpore toto» (IV, 1111), non è possibile infatti ‘penetrare e perdersi nell’altro corpo con tutto il corpo’.
All’amore come riflesso della tenerezza di chi ama, Lucrezio oppone il gusto e il godimento erotico senza eccessivi coinvolgimenti sentimentali. Se «questo infatti fanno per lo più gli uomini ciechi di passione, / e attribuiscono alle amate pregi ch’esse non posseggono davvero» (IV, 1153-1154), è meglio dedicarsi alla «gioia senza pena» di «un piacere più puro» (IV, 1074-1075), dentro il quale i corpi possano godere e la psiche non risultarne troppo turbata.
Alle paure trascendenti e immanenti, alle sconvolgenti passioni, all’inevitabilità della fine di ogni cosa, l’epicureo Lucrezio oppone la serenità della materia, la dolcezza del nulla. «E come nel tempo passato non sentimmo alcuna afflizione […] / così quando noi non saremo più, quando sarà avvenuto il distacco / del corpo e dell’anima, che uniti compongono il nostro essere, / certo a noi, che allora non saremo più, non potrà affatto / accadere alcunché, nulla potrà colpire i nostri sensi, / neppure se la terra si confonderà col mare e il mare col cielo» (III, 832; 838-842); non può infatti diventare infelice chi non esiste, «nec miserum fieri qui non est posse» (III, 867), né può dispiacersi se sia nato o non nato «mortalem vitam mors cum inmortalis ademit», ‘quando la vita mortale gli è stata tolta dalla morte immortale’ (III, 869). È quanto afferma anche il filosofo David Benatar quando sostiene che mentre «è doveroso evitare di mettere al mondo persone sofferenti, non c’è alcun dovere di dare vita a persone felici. […] Noi pensiamo che non vi sia alcun dovere di mettere al mondo persone felici perché, mentre il loro piacere sarebbe un bene per loro, la sua assenza non sarebbe per loro un male (dato che nessuno ne sarebbe privato)»3 .
«Quidve mali fuerat nobis non esse creatis?» (V, 174), che male sarebbe stato per noi non essere nati? Questa domanda essenziale, semplice e profonda mostra per intero la saggezza (φρόνησις) e la sapienza (σοφία) del romano così radicalmente greco che si chiama Lucrezio.
Note
1. Tito Lucrezio Caro, De rerum natura, introduzione, testo criticamente riveduto, traduzione e commento di Francesco Giancotti, Garzanti 2018.
2. Céline, Nord, in Trilogia del Nord, trad. di Giuseppe Guglielmi, Einaudi 2010, p. 463
3. David Benatar, Meglio non essere mai nati. Il dolore di venire al mondo, [Better Never to Have Been: the Harm of Coming into Existence, 2006], trad. di Alberto Cristofori, Carbonio Editore 2018, p. 43.
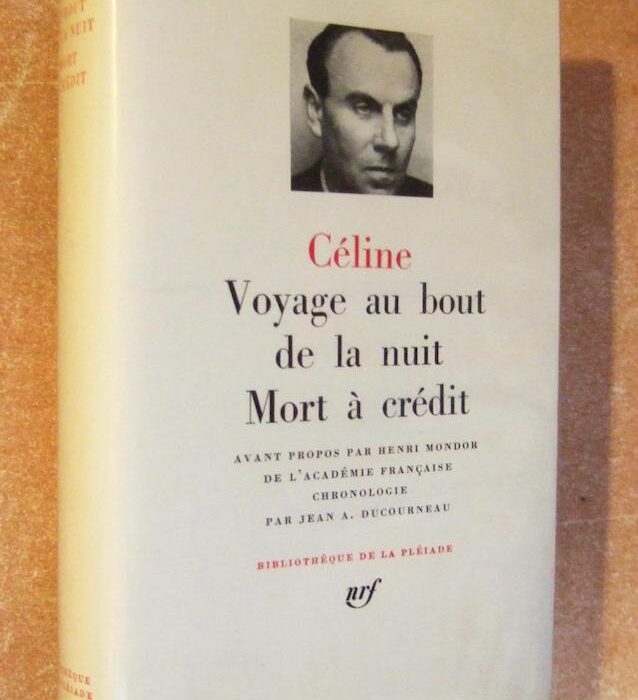








 Durante la presentazione della mostra al Museo delle Culture, Steve McCurry ha riferito di aver visto crudeli combattimenti tra cani e altre specie di animali in Afghanistan, di aver assistito al rogo di animali vivi da parte di soldati negli zoo durante la guerra del Golfo. Ma di quei combattimenti nelle sue foto non c’è traccia. Non c’è traccia di animali diventati torce, non c’è traccia dei
Durante la presentazione della mostra al Museo delle Culture, Steve McCurry ha riferito di aver visto crudeli combattimenti tra cani e altre specie di animali in Afghanistan, di aver assistito al rogo di animali vivi da parte di soldati negli zoo durante la guerra del Golfo. Ma di quei combattimenti nelle sue foto non c’è traccia. Non c’è traccia di animali diventati torce, non c’è traccia dei  Ma Steve McCurry rende ugualmente testimonianza all’animale con la sua magnifica arte fotografica. Da queste immagini infatti il silenzio dell’animale emerge come una parola potente, enigmatica, ancestrale, cosmica. Lo sguardo animale descrive il mondo, il limite del quale è intriso, il sempre che diviene e che va, sino alla fine, sino a «quelle profondità spumose dove più niente esiste…», come scrisse Céline a conclusione del suo ultimo romanzo, la cui dedica suona: «
Ma Steve McCurry rende ugualmente testimonianza all’animale con la sua magnifica arte fotografica. Da queste immagini infatti il silenzio dell’animale emerge come una parola potente, enigmatica, ancestrale, cosmica. Lo sguardo animale descrive il mondo, il limite del quale è intriso, il sempre che diviene e che va, sino alla fine, sino a «quelle profondità spumose dove più niente esiste…», come scrisse Céline a conclusione del suo ultimo romanzo, la cui dedica suona: «

