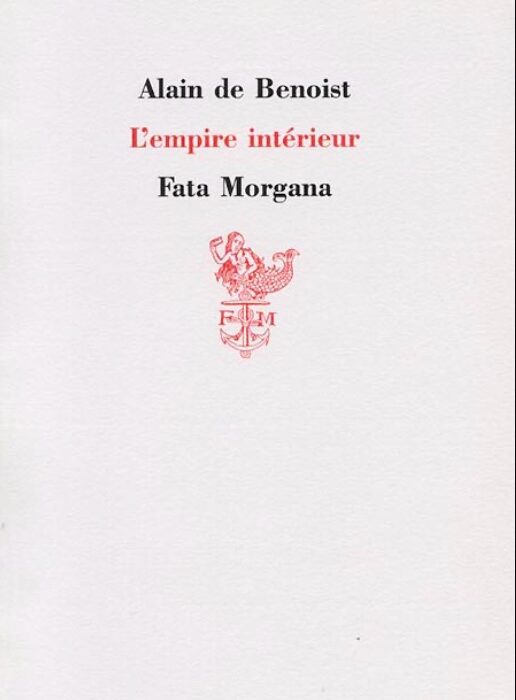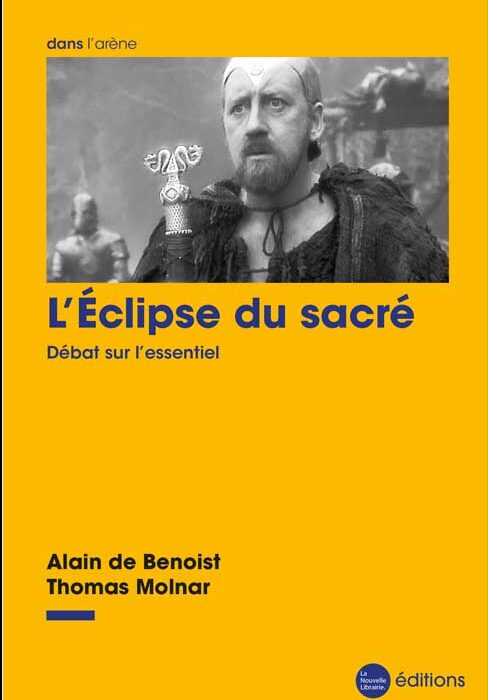
Cristianesimo, tempo, sacralità
Alain de Benoist – Thomas Molnar
L’eclisse del sacro
(L’éclipse du sacré, La Table Ronde 1986)
Traduzione e saggio introduttivo di Giuseppe Del Ninno
Edizioni Settecolori, 1992
Pagine XVIII-225
Questo confronto tra un cattolico ultratradizionalista e un intellettuale senza dogmi risulta emblematico e straniante. Emblematico della incommensurabilità tra una prospettiva aperta all’intero e al molteplice, come quella di de Benoist, e una invece rigidamente chiusa in un recinto di sicurezza e di grettezza, in un confine tranquillo e assai delimitato. Straniante per l’evidente differenza di livello in cui si pongono i due discorsi.
Thomas Molnar vede nel cattolicesimo il baluardo contro ogni male. Ma non il cattolicesimo come di fatto è oggi bensì un cattolicesimo rimpianto. Molnar si pronuncia infatti in modo deciso contro la Chiesa conciliare e contro Paolo VI, «impegnat[i] in un processo di autodistruzione» (p. 29) e in una vera e propria «campagna di oppressione nei confronti dei credenti» (43). Di tale autodistruzione è parte la riduzione della Chiesa cattolica a un’agenzia filantropica e sociale, come è già accaduto alle chiese protestanti, i cui luoghi di culto sono infatti vuoti. E questo è vero. Meno accettabile, anche se del tutto coerente, è l’esplicito rifiuto delle libertà in nome della verità, poiché secondo Molnar «vi sono interessi che non sono in concorrenza con altri, ma li schiacciano, in nome del pluralismo. E per essi non c’è posto in una società ben ordinata» (79-80). Il grande nemico ripetutamente indicato da Molnar è lo Gnosticismo, come è sempre stato per la Grande Chiesa.
C’è un solo elemento nel quale le opinioni dei due interlocutori sembrano concordare: il riconoscimento che il cristianesimo sta all’origine della desacralizzazione. «Il cristianesimo, dovunque penetri – e in primo luogo nel mondo greco-romano – procede ad uno svuotamento (e de-mitizzazione) del cosmo panteista, pagano» (21) scrive Molnar. E de Benoist conferma: «La scomparsa del sacro va messa direttamente in rapporto con l’espandersi di una religione giudeo-cristiana caratterizzata dall’identificazione dell’essere con Dio, dalla dissociazione dell’essere dal mondo e dal ruolo particolare assegnato alla ragione» (115).
Per il resto le posizioni risultano inconciliabili per la fondamentale ragione che i due autori partono da concezioni del sacro assai diverse tra di loro. Per de Benoist lo statuto del sacro è da distinguere con molta cura rispetto a quello della religione: «Se, in effetti, ogni religione implica il sacro (ma non un dio), non è vero il contrario. Divino e sacro, sacro e religioso non sono sinonimi» (87). Gli dèi, il divino, abitano dentro il sacro poiché gli dèi e il divino abitano dentro il mondo, sono una sua parte. Non si dà quindi né un’illogica creazione dal nulla (nihil ex nihilo) né un dualismo ontologico tra il cosmo e il divino. Dualismo che invece è la vera cifra del monoteismo biblico, il quale si origina e si conclude nella separazione assoluta tra un’entità che crea e un’entità che viene creata. Essendo il cosmo creato, esso non ha nulla di sacro.
È da qui che si genera la visione del mondo ebraica e cristiana, da questa natura totalmente altra del divino che, proprio per non svanire nella distanza e nell’insignificanza, ha poi bisogno di postulare un ulteriore elemento che per le civiltà politeistiche risulta bizzarro: il diventare ‘perfettamente uomo’ di qualcosa che all’origine è ‘perfettamente dio’. Soltanto dove umano e divino vengono pensati come inconciliabili può essere poi postulato un dogma come l’incarnazione. Dove invece umano e divino sono parte di un insieme che li (r)accoglie senza confonderli né separarli, un simile postulato non può nascere, non ha ragione di nascere.
Il politeismo tiene uniti identità e differenza. Il monoteismo elimina la differenza a favore di un’identità rigida e insieme contraddittoria, nella quale l’elemento umano è nello stesso tempo del tutto diverso rispetto al divino e superiore a ogni altro nell’ambito mondano. Segnale efficace e pervasivo di tale struttura è la centralità di due diversi strumenti percettivi, di due differenti sensi. Il monoteismo ebraico privilegia l’udito, il politeismo greco privilegia il vedere. E questo significa che «la vista fa posare lo sguardo sullo spettacolo del mondo, dove l’unità si lascia cogliere soltanto come riunificazione di una pluralità sempre cangiante. L’udito rinvia più direttamente all’invisibile, ponendo, al di fuori di ogni mediazione, all’ascolto di una parola che si pretende unica» (120-121).
Identità escludente, antropocentrismo, desacralizzazione e devastazione costituiscono dunque un solo processo poiché «essendo desacralizzato, [il mondo] diventa oggetto inanimato, materia integralmente assumibile e praticabile da parte dell’uomo» (131). Ulteriore conseguenza di un radicale antropocentrismo è la riduzione dell’elemento cosmico a quello etico, la superfetazione della morale. Questa moralizzazione dell’intero priva la vita della sua innocenza, della sua lievità, in quanto «la serenità (Gelassenheit) che gli derivava dal sentimento di un’appartenenza all’essere che si dispiegava nella sua pienezza è svanita. La credenza in un ‘altro mondo’ bisogna ormai pagarla al prezzo della propria colpevolezza» (132).
Rispetto a tali pericoli, la filosofia di Martin Heidegger costituisce anche la rimemorazione di ciò che è invece possibile pensare e conseguire se si evita di privilegiare una parte, compreso il dio, rispetto all’intero, con cui coincide il sacro. La ‘differenza ontologica’ appare in questa luce come la possibilità di «pensare l’essere dell’ente nella sua differenza dall’ente: compito fondamentale di un pensiero fedele che, nel suo stesso disegno, si ordina necessariamente intorno alla coscienza di quel che è il sacro» (113).
Dal sacro riceve luce lo statuto del tempo e, viceversa, la temporalità permette di avere rispetto della sacralità di un mondo che è sempre diveniente/diverso e sempre costante/identico. La ciclicità ‘pagana’ non vuol dire infatti immutabilità o irrilevanza del tempo ma, al contrario, è una conferma della sua centralità. Il tempo ciclico, infatti, «non è sterile ripetizione, ma regolare ridispiegamento degli esseri e delle cose» (103); l’eterno ritorno non rende sacro l’immutabile ma afferma invece la possibilità di ogni forma del mutamento e del movimento, compresa la forma del ritorno. Tutto infatti può tornare nel preciso senso che «risalire alle origini significa riaffermare la possibilità di un nuovo inizio» (224).
Il fondamento e la spiegazione di tali dinamiche di identità/differenza stanno nel fatto che «al principio del tempo storico vi è la differenza ontologica fra l’essere e l’ente; tale differenza è l’Evento (Ereignis) che instaura tutta la storia. In tal modo, il principio storico viene introdotto nel cuore dell’ontologia. […] Il tempo è il senso dell’essere. L’essere diviene storicamente» (204-205).
L’oblio dell’essere è esattamente l’oblio della sua temporalità, della struttura che raccoglie l’ora, il già e il non ancora nella pienezza del divenire che è anche il divenire che splende adesso e che sempre ritorna, il καιρός.