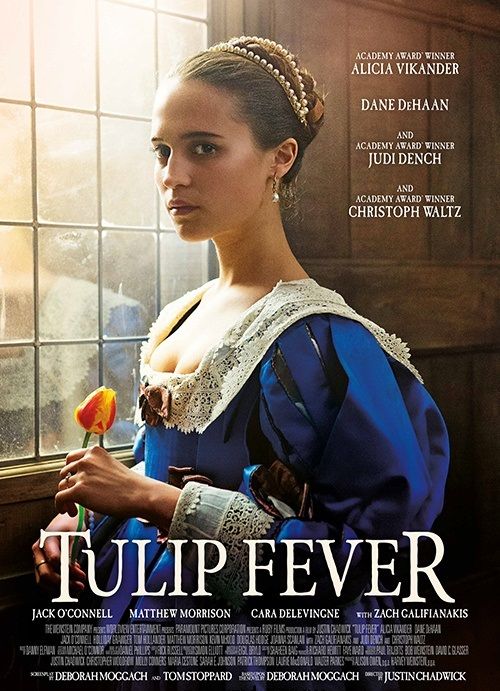[Il testo è più ampio rispetto a quelli che di solito pubblico in questa sede. Ma la questione è talmente complessa e delicata da dover essere affrontata nella molteplicità dei suoi aspetti. Per una lettura più comoda, ho preparato anche una versione pdf del testo]
«Wer Menschheit sagt, will betrügen», ‘chi dice umanità vuole ingannare’, non è una massima di Carl Schmitt bensì di uno dei fondatori dell’anarchismo moderno: Pierre-Joseph Proudhon. Schmitt la cita e la fa propria. Questo non deve stupire, visto che in entrambi i casi si tratta di menti capaci di comprendere la complessità delle strutture sociali e del loro divenire. La fecondità dell’avvertimento di Proudhon è confermata da quanto accade nei Social Network (e in tutto il resto della comunicazione contemporanea), dentro i quali problemi complessi e difficili come quello delle migrazioni dall’Africa all’Europa vengono affrontati con grave superficialità -per non dire in modi sempre più beceri, umorali e volgari- sia sul versante degli ‘accoglienti’ sia su quello dei ‘respingenti’. Si tratta invece di un tema fondamentale che va compreso con gli strumenti che la storia e le scienze sociali offrono.
Un argomento difficilmente eludibile sul tema dei migranti è quello marxiano dell’esercito industriale di riserva, concetto classico e sempre attuale. È infatti chiaro che un’apertura indiscriminata ai migranti è ben vista dal padronato, che può utilizzare persone disposte a lavorare per pochi euro all’ora e senza nessuna garanzia. La sinistra accogliente favorisce in questo modo pratiche di schiavizzazione.
Alcuni dati sono utili a comprendere la dimensione internazionale della questione, certamente non limitabile alle vicende del Mediterraneo. Ad esempio, in Australia ottenere la cittadinanza è molto difficile ed è di fatto riservata ai ‘migranti culturali’, intesi come professori, giornalisti, intellettuali. In Giappone delle 19.628 domande presentate nell’anno 2017, soltanto 20 furono accettate. Avete letto bene, venti. Per venire all’Europa, il governo spagnolo -che pure un anno fa accolse in modo spettacolare 600 migranti a Valencia– minaccia ora le ONG di multe sino a 900.000 euro se i salvataggi si verificheranno fuori dalla «zona di search and rescue (Sar) di responsabilità nazionale», azioni che dovranno svolgersi «comunque sempre sotto il coordinamento delle autorità»1.
Alcune delle principali ragioni e forme del fenomeno migratorio sono analizzate da un sociologo progressista e politicamente corretto come Stephen Smith, docente di Studi africani alla Duke University (USA), per molto tempo collaboratore dei quotidiani francesi Libération e Le Monde, corrispondente dall’Africa (dove ha vissuto a lungo) per numerose agenzie, autore de La ruée vers l’Europe. La jeune Afrique en route pour le Vieux Continent (Grasset, Paris 2018) che significa La corsa verso l’Europa e non il ben diverso Fuga in Europa, con il quale Einaudi ha deciso di tradurre il titolo.
Questo studioso rileva come in Africa esista una middle class suddivisa in due fasce. I membri della prima -costituita da 150 milioni di persone, pari al 13% della popolazione africana- «dispongono attualmente di un reddito quotidiano tra i 5 e i 20 dollari, incalzati da oltre 200 milioni di altri, il cui reddito giornaliero oscilla tra i 2 e i 5 dollari. Insomma: un numero in rapida crescita di africani è in ‘presa diretta’ con il resto del mondo e dispone dei mezzi necessari per andare in cerca di fortuna all’estero»2. Si tratta di un elemento chiave in quanto «la prima condizione» per progettare l’abbandono del proprio Paese «è il superamento di una soglia di prosperità minima» poiché «attualmente, in relazione al luogo di partenza e al precorso previsto», la cifra necessaria al perseguimento di tale obiettivo «oscilla fra i 1500 e i 2000 euro, ossia almeno il doppio del reddito annuo in un paese subsahariano» (83-84).
Quella che arriva dall’Africa in Europa è quindi una collettività, scrive Smith, «sincronizzata con il resto del mondo, al quale è ormai ‘connessa’ tramite i canali televisivi satellitari e i cellulari – la metà dei paesi [a sud del Sahara] ha accesso al 4G, che consente streaming e download di video e di grandi quantità di dati; ma anche mediante Internet, via cavi e sottomarini di fibra ottica» (XIII). Gli altri, vale a dire la grande parte della popolazione africana, «non hanno i mezzi per migrare. Non ci pensano neppure. Sono perennemente occupati a mettere insieme il pranzo con la cena, e quindi non hanno il tempo di mettersi al passo con l’andamento del mondo e, meno ancora, di parteciparvi» (87).
Solo una minoranza fugge da persecuzioni e guerre, tanto è vero che nel periodo di massima virulenza delle guerre in Africa, gli anni Novanta del Novecento, l’arrivo di migranti era incomparabilmente minore rispetto a quello che si sta verificando negli anni Dieci del XXI secolo. Ragionando in termini sociologici e storici e non sentimentali e morali -come va sempre fatto di fronte a fenomeni di tale portata– Smith ne deduce che «sarebbe tuttavia aberrante riconoscere in blocco lo status di vittima a chi fugge davanti alle difficoltà e magari non a chi le affronta» (86).
Riflettendo sui 1500 dollari mediatamente necessari per raggiungere la Libia dalla Nigeria, il vescovo cattolico di Kafanchan, Joseph Bagobiri, osserva che «se ognuna di queste persone avesse investito questa somma in modo creativo in Nigeria in imprese realizzabili, sarebbero diventati datori di lavoro. Invece sono finiti soggiogati alla schiavitù e ad altre forme di trattamento inumano da parte dei libici. […] In questo Paese vi sono ricchezze e risorse immense. I nigeriani non dovrebbero diventare mendicanti lasciando la Nigeria alla ricerca di una ricchezza illusoria all’estero»; un altro vescovo, Julius Adelakun, invita i nigeriani a non sprecare il proprio danaro, offrendolo ai mercanti di vite umane, e utilizzarlo invece allo scopo di «sviluppare il nostro paese per renderlo attraente e favorevole alla vita, in modo che siano i cittadini stranieri a voler venire da noi»3. Un simile autolesionismo che uccide le persone e impoverisce il Paese d’origine ha molte spiegazioni, due tra queste sono: la visione distorta che si ha dell’Europa come luogo di ricchezza assicurata; i finanziamenti dei quali godono le ONG cosiddette ‘umanitarie’ allo scopo di raccogliere quanta più possibile forza lavoro a basso costo da immettere nelle economie europee.
Anche il progetto sintetizzato nella formula «aiutiamoli a casa loro» ha poco senso. Si tratta infatti di un obiettivo contraddittorio sia in via di diritto sia di fatto. Smith lo definisce un vero e proprio paradosso:
«I paesi del Nord sovvenzionano i paesi del Sud sotto forma di aiuto allo sviluppo, affinché i deprivati possano migliorare le loro condizioni di vita e, sottinteso, restino a casa loro. In questo modo, i paesi ricchi si danno la zappa sui piedi. Infatti, almeno in un primo momento, premiano la migrazione aiutando alcuni paesi poveri a raggiungere un certo livello di prosperità grazie al quale i loro abitanti dispongono dei mezzi economici per partire e insediarsi all’estero. È l’aporia del ‘cosviluppo’, che mira a trattenere i poveri a casa loro mentre nello stesso tempo ne finanzia il sradicamento. Non c’è soluzione, perché bisogna pur aiutare i più poveri, chi ne ha più bisogno…» (86).
Chi invece sostiene l’accoglienza più o meno universale, dovrebbe riflettere su altri dati di fatto, da Smith esposti con grande chiarezza:
«Nel 2017, tra gennaio e la fine di agosto, hanno attraversato il Mediterraneo 126.000 migranti, di cui 2428 dichiarati dispersi, cioè l’1,92%; dato leggermente inferiore alla mortalità post-operatoria di un intervento di chirurgia cardiaca nell’Europa occidentale (2%). Nonostante il rischio sia, per fortuna, limitato, ci si chiede perché non smetta di aumentare nonostante gli occhi del mondo siano puntati sul Mediterraneo e i soccorsi dovrebbero essere sempre più efficienti. La risposta è che le organizzazioni umanitarie rasentano la perfezione! In effetti, le imbarcazioni di soccorso si avvicinano sempre di più alle acque territoriali libiche e, in caso di pericolo di naufragio, non esitano a entrarvi per prestare soccorso ai migranti. Dal canto loro, i trafficanti stipano un numero sempre maggiore di migranti in imbarcazioni sempre più precarie. […] In cambio di una riduzione tariffaria, un passeggero è incaricato della ‘navigazione’ e di lanciare l’Sos non appena entri in acque internazionali: a tal fine gli viene consegnata una bussola e un telefono satellitare del tipo Thuraya. […] Lasciando i migranti alla deriva…per essere prima o poi soccorsi dalle navi delle organizzazioni umanitarie che sanno fare molto bene il loro mestiere, con l’inconveniente, però, che i migranti, sapendo di essere soccorsi, badano assai poco all’efficienza delle imbarcazioni messe a disposizione dai trafficanti. […] Occorre, tuttavia, arrendersi all’evidenza: per arrivare in Europa i migranti africani corrono un rischio calcolato simile ai rischi che corrono abitualmente nella vita che cercano di lasciarsi alle spalle» (107-108).
Di fronte a tali eventi e dinamiche, Smith afferma lucidamente che è necessario «de-moralizzare il dibattito» sull’emigrazione. I sentimentalismi costituiscono infatti in casi come questi i migliori alleati della violenza degli schiavisti e di quella dei razzisti. Anche lo scrittore Emmanuel Carrère sostiene la necessità di non trasformare la questione migratoria «in un eterno affare Dreyfus»4. Come ha insegnato Max Weber, l’etica impolitica della convinzione deve sempre confrontarsi con l’etica politica della responsabilità, la quale deve fare i conti con «tutte le conseguenze prevedibili dei propri atti, al di là del narcisismo morale» (Smith, p. 146). Cercando di delineare le possibili conseguenze di quanto sta accadendo tra Europa e Africa, Smith individua per il prossimo futuro cinque scenari.
Il primo è l’Eurafrica, che «consacrerebbe l’ ‘americanizzazione’ dell’Europa» (145) e implicherebbe «la fine della sicurezza sociale. […] Lo Stato sociale non s’adatta alle porte aperte, donde l’assenza storica di una sicurezza sociale degna del nome negli Stati Uniti, paese d’immigrazione per eccellenza. Insomma, sopravviverà in Europa unicamente lo Stato di diritto, il vecchio Leviatano di Hobbes -che dovrà darsi un gran daffare per impedire la ‘guerra di tutti contro tutti’ in una società senza un minimo di codice comune» (146-47).
Il secondo scenario è la fortezza Europa, alimentato anche dalle reazioni che suscita «una stampa che si preoccupa più della fiamma del proprio umanitarismo che delle sue conseguenze sulla collettività»; Smith ammette che «la fortezza Europa è forse meno indifendibile di quanto non sembrasse. […] Ciò nondimeno, se si tiene conto della sollevazione di massa prevista da questo libro, qualsiasi tentativo esclusivamente sicuritario è votato al fallimento» (148-149).
Il terzo scenario è la deriva mafiosa, una vera e propria «tratta migratoria» il cui rischio è «che i trafficanti africani facciano combutta o entrino in guerra con il crimine organizzato in Europa» (149); una conferma sta nel fatto che l’80% delle donne soccorse nel Mediterraneo «erano oggetto di un traffico a fini di sfruttamento sessuale. […] Gli intrecci fra prossenetismo e ‘passatori’, troppo spesso presentati come individui soccorrevoli che praticano una forma di commercio solidale, non è che la parte visibile di un’attività criminale assai più importante» (150).
Un quarto scenario è il ritorno al protettorato, per il quale in cambio di privilegi e danaro ai ceti dirigenti, alcuni Paesi africani accetterebbero una «sovranità limitata in maniera proporzionale alle esigenze di difesa dell’Europa» (151).
Il quinto e ultimo scenario è secondo Smith il più probabile e consiste «in una politica raffazzonata» che «consisterebbe nel mettere assieme tutte le opzioni che precedono, senza mai realizzarle sino in fondo: insomma, ‘fare un po’ di tutto ma senza esagerare’» (151).
A decidere quale di questi scenari prevarrà non saranno probabilmente gli europei ma gli stessi africani. In questi casi, infatti, il numero diventa decisivo.
Nell’affrontare per quello che possono la questione, gli europei dovrebbero ragionare sine ira et studio sulla natura e sulle conseguenze del liberalismo capitalistico che prima ha prodotto l’imperialismo in Africa e poi, di rimbalzo, la corsa impetuosa di molti africani verso l’Europa. Uno dei fondamenti teorici del liberalismo, infatti, è la distruzione di corpi intermedi tra il singolo essere umano e l’umanità in quanto tale. In questo senso il liberalismo è l’opposto della democrazia, la quale pone al centro dello scenario sociale non l’individuo ma le citoyen, il cittadino, vale a dire una persona radicata in un contesto collettivo consolidato, frutto di condizioni geografico–economiche ben precise e di eventi storici condivisi. Ed è sempre in questo senso che la sovranità del popolo è cosa ben diversa dalla difesa dei diritti dell’uomo.
Uomo è infatti un concetto astratto, per i Greci ad esempio del tutto marginale. Al centro della vita collettiva si pone invece l’abitante della πόλις, con i suoi diritti e con i suoi obblighi. Per la democrazia i territori, le culture, le organizzazioni collettive non costituiscono soltanto la somma di individui isolati e tra loro irrelati ma sono il risultato della contiguità spaziale e della comunanza temporale. Si è prima di tutto abitanti di un certo luogo e soltanto per questo si può diventare cittadini del mondo. È qui che il concetto di border mostra la propria funzione di delimitazione della dismisura, di κατέχον rispetto alla dissoluzione.
La critica superficiale e pregiudiziale al concetto di frontiera , che pervade innumerevoli pagine della Rete e gli articoli di molta stampa, è dunque anch’essa una forma di ignoranza spettacolare, nel molteplice senso di questo aggettivo. Nella storia del XXI secolo il contrario di frontiera non è chiusura, il contrario della frontiera è il mercato, è il capitale, che sin dall’inizio ha avuto come fondamento la massima liberista «Laissez faire, laissez passer».
Applicare questo principio in modo assoluto e irrazionale, come tende a fare il liberismo contemporaneo significa, tra le altre conseguenze, scrive Smith, «fare i conti senza l’ospite», vale a dire fare i conti senza coloro che nel territorio europeo risiedono da secoli e che cominciano a sentirsi stranieri nel proprio Paese (passeggiare ad esempio in via Padova a Milano mi ha dato esattamente questa impressione) o persino ‘invasi’. «L’arrivo di stranieri può importunare, la loro presenza può disturbare. Pretendere che non sia così mi sembra una petizione di principio idealistica e pericolosa» (112). Affrontare una simile realtà in termini psicologici o addirittura moralistici è sterile, per non dire anche pericoloso. De-moralizzare il problema è necessario anche perché
«né lo straniero, né l’ospite sono a priori ‘buoni’ o ‘cattivi’, ‘simpatetici’ o ‘egoisti’. Vengono a trovarsi, insieme, in una situazione che occorre cercar di capire al pari delle circostanze, ovviamente differenti per l’uno e per l’altro. La mancata assistenza a un persona in pericolo è un reato, a condizione di potere prestare aiuto senza esporsi a pericoli (ultra posse nemo obligatur). […] La preoccupazione dell’equità internazionale non può confondersi con l’apertura delle frontiere a titolo di perequazione planetaria. Non è incoerente essere favorevoli all’equità internazionale e contrari alla totale apertura delle frontiere» (112-113).
Della giustizia è parte fondamentale anche la difesa di se stessi, in caso contrario si tratta non di solidarietà ma di autodistruzione. Se è doloroso ma inevitabile che una potenza meglio armata e determinata ne sottometta o distrugga un’altra, è assai meno comprensibile che i soggetti sottomessi collaborino attivamente alla propria distruzione. L’Impero Romano, ad esempio, non venne certo cancellato dai cosiddetti barbari ma si dissolse per ragioni interne, alle quali le popolazioni del nord e dell’est aggiunsero soltanto la propria presenza, invocata da molti cristiani come purificatrice della decadenza latina. «La verità è che i barbari hanno beneficiato della complicità, attiva o passiva, della massa della popolazione romana. […] La civiltà romana si è suicidata»5.
Qualcosa di analogo sta avvenendo nell’Europa contemporanea, uscita sconfitta e miserabile dalle due guerre mondiali del Novecento, vale a dire dalla più distruttiva guerra civile della storia moderna. L’Europa sta infatti implodendo su se stessa per una manifesta incapacità di gestire il proprio presente, affidato al capitalismo globalista sotto la guida statunitense e ai flussi religiosi provenienti dal mondo islamico. Invece di nutrire ed esercitare prudenza rispetto a queste complesse dinamiche, la più parte degli europei si divide tra i sostenitori di un’accoglienza totale e indiscriminata e i difensori di una pregiudiziale chiusura. Posizioni entrambe inadeguate a comprendere ciò che sta avvenendo. Gli accoglienti, in particolare, praticano comportamenti dettati dal sentimentalismo umanistico e romantico e dall’universalismo cristiano. Due posizioni antropologiche assai rischiose e che contribuiranno alla fine dell’Europa come sinora è stata conosciuta.
Il futuro degli europei è sempre meno in mano agli europei anche a causa del fatto che «la gioventù africana si precipiterà nel vecchio continente, perché è nell’ordine delle cose. […] Secondo le previsioni dell’Onu (United Nations Populations Division 2000, p. 90), l’arrivo di 80 milioni di migranti nel corso di cinquant’anni porterebbe a una popolazione immigrata di prima e seconda generazione corrispondente al 26% di quella presente nell’Unione Europea […]. Oggi vivono nell’Unione Europea (compreso il Regno Unito) 510 milioni di europei a fronte di 1,3 miliardi di africani sul continente vicino. Entro trentacinque anni, questo rapporto sarà di 450 milioni di europei a fronte di 2,5 miliardi di africani, ossia il quintuplo» (Smith, pp. XII–XIV).
Sottovalutare la demografia è scientificamente insensato6. Il rapporto tra gli umani e l’ambiente si fonda infatti, come quello di qualsiasi altra specie, soprattutto sul dato quantitativo. Il numero e la giovinezza dei popoli africani molto probabilmente prevarranno. E alla fine sarà giusto così, di fronte al pervicace cupio dissolvi che sempre più caratterizza l’Europa.
Note
1. il Fatto Quotidiano, 6.7.2019
2. Stephen Smith, Fuga in Europa. La giovane Africa verso il vecchio continente, trad. di P. Arlorio, Einaudi, Torino 2018, pp. XII–XIV. Sulla giovinezza dell’Africa si legga l’intero secondo capitolo del libro, dal significativo titolo L’isola-continente di Peter Pan, pp. 29-53. I riferimenti ai numeri di pagina delle citazioni da questo volume saranno indicati nel corpo del testo, tra parentesi.
3. Africa/Nigeria – “Le somme pagate ai trafficanti per finire schiavi in Libia avrebbero potuto creare posti di lavoro in Nigeria”, nota dell’agenzia di stampa cattolica Fides, 15.12.2017.
4. Emmanuel Carrére, A Calais, trad. di L. Di Lella e M.L. Vanorio, Adelphi, Milano 2016, p. 16.
5. Jacques Le Goff, La civiltà dell’Occidente medievale, trad. di A. Menitoni, Einaudi, Torino 1983, pp. 22–23.
6, Lo mostra con ricchezza di argomenti anche Olivier Rey nel suo Dismisura (il significativo titolo originale è Une question de taille [Éditions Stocks, Paris 2014], «un problema di dimensione») trad. di G. Giaccio, Controcorrente, Napoli 2016.