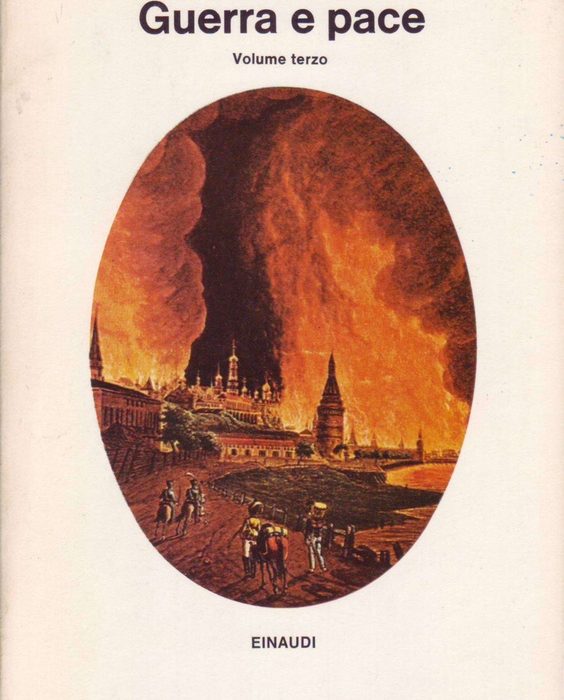Non conosco l’autore del testo che pubblico qui sotto né la rivista sulla quale è uscito.
Ma importa poco. Chiunque siano Gabriele Giorgi e la rivista Cambiailmondo, quella che segue mi sembra un’analisi assai lucida, informata e intelligente della guerra in corso tra da una parte la NATO/USA e dall’altra la Federazione Russa, con vittima la popolazione ucraina. Vittima in primo luogo del governo di quel Paese, pesantemente inquinato da elementi e ideologie neonaziste e guidato da un attore cocainomane e completamente sottomesso alla NATO. Un governo che ha un analogo, pur se con modalità diverse, nel governo italiano, guidato da un soggetto che Francesco Cossiga definì «vile affarista» e che tale in effetti si sta rivelando.
Di fronte alla rovina dell’Italia e dell’Europa, a vantaggio degli USA e per difendere il governo fantoccio dell’Ucraina, ci sarebbero le condizioni per processare i governi in quanto colpevoli di «alto tradimento» degli interessi e della sicurezza dei loro cittadini.
È quello che propone anche questo testo, il quale denuncia la grave crisi economica, i rischi bellici, la miseria politica di un governo definito «Gran Consiglio del Draghismo», del quale fanno parte tutti i partiti presenti in Parlamento, dalla Lega di Salvini al Partito Democratico di Letta e con il sostanziale sostegno anche di Fratelli d’Italia. La formula indica una plausibile analogia con il Gran Consiglio del Fascismo.
Segnalo quindi l’articolo di Giorgi e ne consiglio vivamente la lettura.
=============
Il popolo italiano deve decidere se accetta o no l’entrata in guerra
di Gabriele Giorgi
Fonte: Cambiailmondo, 24.6.2022
L’ora delle decisioni irrevocabili si sta rapidamente avvicinando. Anzi è già stata presa. Resta da stabilire la data della comunicazione ufficiale. Non a Piazza Venezia, ma a reti unificate, appoggiata da un’azione sui social già iniziata mesi fa, che si farà pressante verso la fine dell’estate. Dichiarazione al popolo e, solo in seconda istanza, al Parlamento, visto che da tempo, si governa per decreti e l’urgenza è diventata la prassi consueta, analogamente a quanto avviene per le condannabili autocrazie che ci apprestiamo a sconfiggere.
Per chi, tra le elìtes istituzionali, si oppone all’entrata in guerra, vi è una sola possibilità: lavorare alla caduta del Gran Consiglio del Draghismo, dichiarare la neutralità e la sospensione dell’adesione alla Nato, seguendo le indicazioni della maggioranza del popolo italiano che ha capito da tempo l’obiettivo del variegato movimento guerrafondaio: una nuova, lunga stagione di oppressione dei lavoratori e lavoratrici, dipendenti o autonomi, dei precari, dei giovani, degli studenti, dei pensionati, che deve durare decenni; per salvaguardare gli interessi, ma soprattutto il potere, dei rappresentanti della grande impresa, di grandi banche, del capitale finanziario e speculativo, di tutti coloro che per sopravvivere devono continuare ad avere la possibilità di salassare i produttori reali.
La secessione del ministro degli esteri Di Maio – con la contemporanea convergenza di Fratelli d’Italia a sostegno di Draghi – è stata la mossa preventiva per ovviare al potenziale inconveniente della caduta del Gran Consiglio. Ne seguiranno altre. Si tenta cioè di chiudere ogni via parlamentare “legittima” al possibile posizionamento del paese contro la partecipazione diretta alla guerra in Europa e ad una terza guerra mondiale pienamente dispiegata.
Sono i seguiti di quanto deciso un mese prima dell’invasione russa dell’Ucraina, in occasione della rielezione di Mattarella alla Presidenza della Repubblica, quando si è riusciti a bloccare ogni opzione che non fosse di piena garanzia per gli anglosassoni e per il loro prediletto giocattolo, la Nato.
È immaginabile che, in vista del voto di marzo 2023, in considerazione del succedersi degli eventi, si stiano valutando diverse altre possibilità di contenimento di pericolosi orientamenti che tentino di mettere in forse l’applicazione pedissequa del canovaccio già scritto; fino al possibile rinvio della campagna elettorale e delle elezioni o al varo di un governo provvisorio di salute pubblica che gestisca l’emergenza energetica, inflazionistica e bellica (causate ovviamente dai cattivi russi).
È già evidente che abbiamo solo due/tre mesi di autonomia energetica, dopodiché la riduzione o la chiusura del flusso di gas dalla Russia provocherà la sospensione di altrettante fabbriche nei settori produttivi più esposti all’aumento dei prezzi, disoccupazione di ingenti masse di lavoratori, razionamento energetico nelle case, aumento vertiginoso dell’inflazione con parallela svalutazione dei redditi da lavoro e dei profitti delle piccole imprese (quelle che resteranno in campo) e della perdita di competitività generale di un sistema paese orientato all’export sui mercati internazionali.
Si tratta di uno scenario che prevede solo due opportunità: la guerra appunto, oppure una generale revisione da attuare in più passaggi, il primo dei quali non può che essere quello di uscire dalla logica di guerra. Poi si vedrà.
Come mostrato dai risultati delle elezioni politiche in Francia, la questione non riguarda solo noi. E gli effetti accennati coglieranno in pieno, assieme all’Italia, anche la Germania. Il vagone ferroviario del treno da Varsavia a Kiev, che ospitava Draghi, Macron e Schulz, da questo punto di vista, è l’immagine storica di un fallimento. La soluzione che i tre hanno proposto e che oggi è stata confermata dall’UE, di accettazione della candidatura dell’Ucraina, è una mossa incerta per prendere tempo in attesa di vedere come si evolvono le cose e per verificare la possibilità di un parziale sganciamento di Kiev dai solidi fili manovrati da Washington e Londra.
Ma l’inserimento nell’agenda dell’adesione anche della Moldavia (e già si preannuncia della Georgia) e la chiusura del transito ferroviario tra Bielorussia e l’enclave russa di Kalinigrad, a sole 48 ore dalla missione dei tre leader a Kiev, mostra che gli angloamericani e i loro non pochi sodali nella UE, hanno rilanciato in modo drastico facendo risalire la tensione ai livelli più alti.
Ammesso che Francia, Germania e Italia tentino convintamente di giocare una carta parzialmente autonoma negli scenari di guerra, essa è tardiva e contraddetta dai fatti. Sarebbe peraltro strano che due paesi che ospitano le più grandi basi Nato in Europa e nel mondo (e una in chiaro declino) possano essere in grado di mutare in extremis un’agenda euroatlantica alla quale si lavora da oltre un decennio.
Le redini dello scontro sono saldamente in mano a Usa/Uk e Russia. Entrambi giocano il loro gioco sul campo ucraino e allo stesso tempo in Europa, che costituiscono un unico anche se diversificato obiettivo: per la Russia si tratta di capire se l’Europa o parte di essa può tornare a costituire in tempi medi, un partner, dopo l’imposizione della chiusura del Nord Stream-2. Per gli anglosassoni si tratta di evitare definitivamente e per un tempo molto lungo che ciò possa accadere, pena la loro crescente marginalizzazione e perdita di influenza nello scenario globale.
La compenetrazione e il comando delle elìtes neoliberiste delle economie euroatlantiche non lascia molto spazio a dubbi: per Francia, Germania e Italia non c’è, dentro il quadro istituzionale e politico attuale, nessuna convincente opportunità; chi ha provato a perseguire questo disegno sembra esserne uscito sconfitto. La narrazione mediatica della immaginaria mediazione di Draghi appare in questo contesto, financo ridicola: essa si sarebbe dispiegata a partire dall’incontro con Biden fino al viaggio in treno a Kiev; ma Draghi ha dovuto ricordare e ricorda in ogni occasione che la decisione finale su quale pace sia possibile, spetta a Kiev, cioè a Biden e Johnson.
Dunque, a parte l’escamotage di un attivismo di propaganda, le porte sono chiuse e tutti lo sanno. A Di Maio deve essere stato chiarito in diversi briefing sollecitando una sua opzione esplicita a garanzia di un suo futuro politico.
Gli eventi vanno inesorabilmente verso il diretto coinvolgimento dell’Europa nel conflitto, via Lituania, Polonia, Nato; questa è la sola condizione, per gli angloamericani, di poter saggiare, da lontano e senza gravi rischi, se la Russia può essere messa in ginocchio o fortemente indebolita e, insieme, l’occasione di uno stress-test sul progetto Brics di ricomposizione multipolare dell’ordine mondiale, prima di avventurarsi nello scontro diretto con la Cina.
Gli altri attori non resteranno certamente con le mani in mano, aspettando che si concluda definitivamente quel nuovo secolo americano inaugurato nel 2001.
Per evitare la fine dell’Europa (o quella anticipata del mondo), non abbiamo altre opportunità che non siano quelli della caduta dei gran consigli nel continente. Uno di questi, niente affatto secondario, è quello italiano.