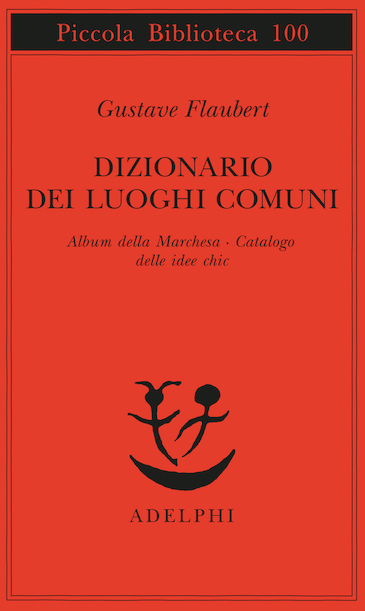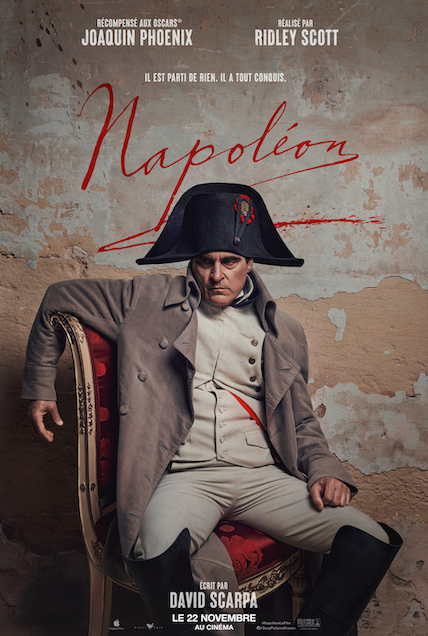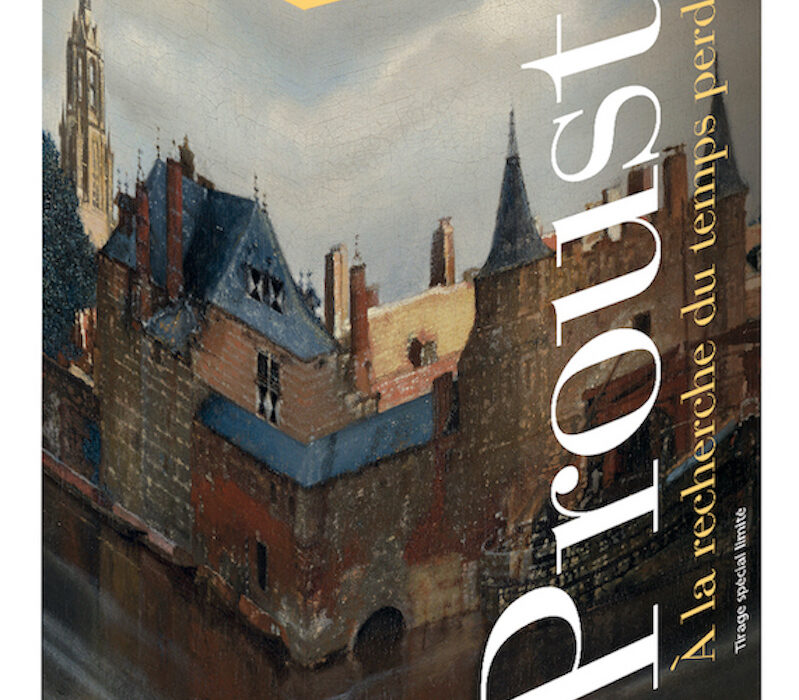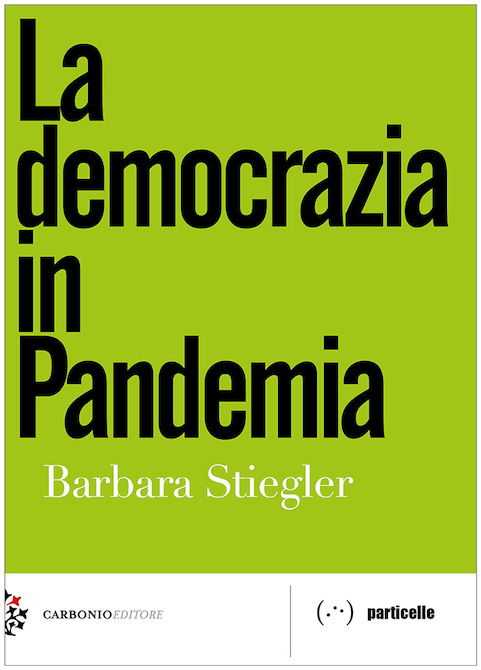De Nittis. Pittore della vita moderna
Palazzo Reale – Milano
A cura di Fernando Mazzocca e Paola Zatti
Sino al 30 giugno 2024
La Francia del Secondo Impero e della Terza Repubblica è stata dipinta soprattutto da due italiani: Giovanni Boldini e Giuseppe De Nittis. A essi si è aggiunto il più profondo e completo artista capace di dipingere con le parole, Marcel Proust. E in effetti i quadri che De Nittis creò vivendo a lungo a Parigi, lui mediterraneo proveniente dalla Puglia, costituiscono anche la raffigurazione per immagini dell’umanità parigina che il Narratore della Recherche descrive in ogni sinuosa sfumatura e nella limpidezza sociologica della potenza di due classi che si divisero ancora a lungo la ricchezza e il prestigio, l’alta borghesia e l’aristocrazia ben presente nonostante i giacobini, nonostante Bonaparte.
De Nittis ama ciò che dipinge come se fosse creatura sua. Non soltanto la moglie e modella Léontine Gruvelle ma anche le signore che passeggiavano nel Bois de Boulogne; che assistevano alle corse dei cavalli a Auteuil e a Longchamp; che camminavano veloci o spensierate per le strade di Parigi.

Il modo con il quale De Nittis vede i luoghi e gli umani coglie una realtà sempre in divenire e suggerita dallo scorcio nel quale ci si trova, da una prospettiva necessariamente parziale ma insieme totalizzante. Il suo è quindi un punto di vista fotografico che mediante pastelli, acquarelli e oli (eccelleva in tutte le tecniche) ferma sulla tela la mondanità, la luce, la forma, la frenesia, la meditazione.
Anche i ritratti dedicati a Londra fotografano una città al confine tra la miseria e la potenza. Le opere mediterranee, l’Ofanto, Napoli, Pompei, il Vesuvio, sono immerse in una luce antica e in un’energia sempre nuova.

Ovunque i corpi disegnati da De Nittis non hanno pose somatiche né psichiche ma sono specialmente figure sociali, forme amate del tempo individuale e collettivo. I dipinti en plein air costituiscono delle mescolanze assai belle tra Giovanni Fattori e Claude Monet. Ma De Nittis non è un macchiaiolo né un impressionista, non è un pittore di genere né un paesaggista. De Nittis è il sogno del XIX secolo.
Ed è un uomo libero, che amava la Francia e Parigi come la sua casa ma che mantenne anche la lucidità che lo spinse a lasciare la metropoli con queste parole: «Prima di tutto ce ne andremo da Parigi, dove la vita mi soffoca: Parigi distrugge tutti. E se poi, un bel giorno, mi dovessi ritrovare simile agli altri, immeschinito dall’ambizione, dalla stanchezza, dalla collera?». Si trasferì dunque nella campagna di Saint-Germain-en-Laye, dove morì all’improvviso il 21 agosto 1884. Parigi lo accolse ancora una volta al Père Lachaise, dove la sua tomba reca un epitaffio dettato da Alexandre Dumas figlio: «Qui giace il pittore Giuseppe De Nittis morto a trentotto anni. In piena giovinezza. In pieno amore. In piena gloria. Come gli eroi e i semidei».
La mostra al Palazzo Reale di Milano permette di seguire, apprendere e gustare con empatia l’arte di questo autentico europeo.