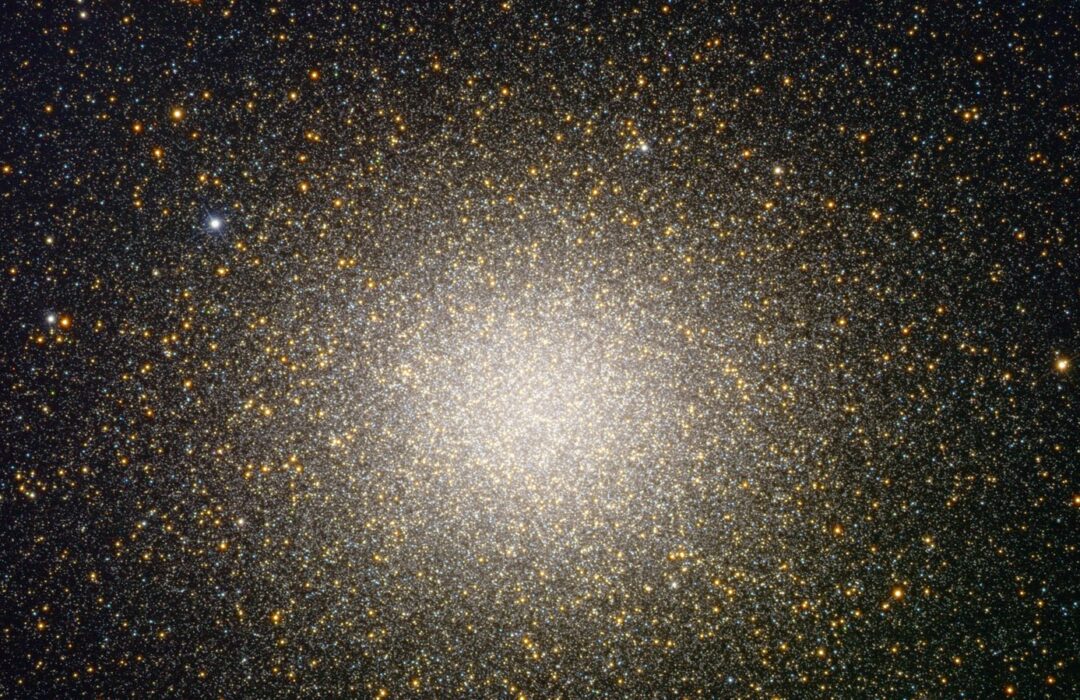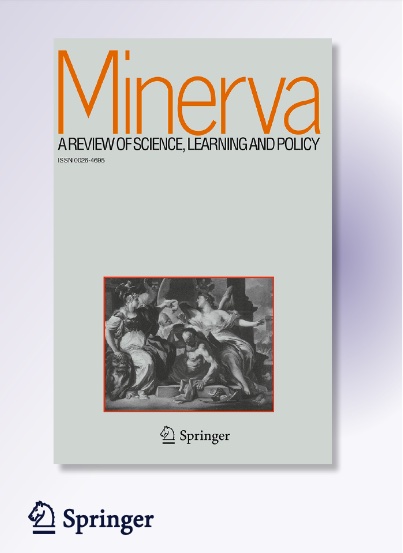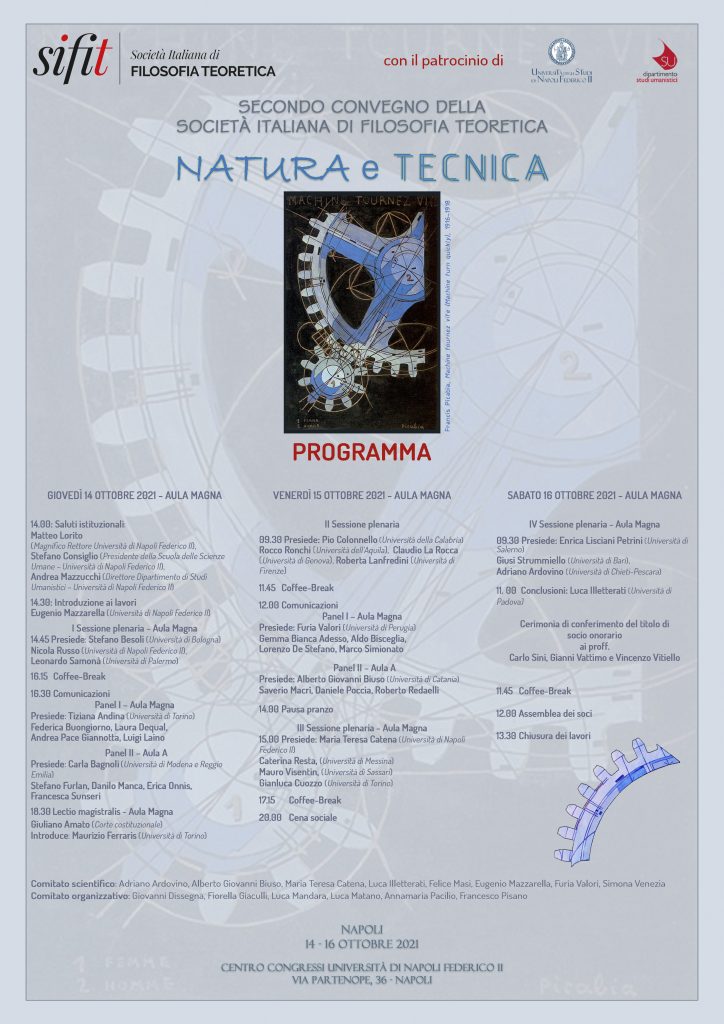Tra gli articoli scientifici più chiari e più fecondi che abbia letto di recente, consiglio un saggio appena pubblicato su Minerva. A Review of Science, Learning and Policy, rivista «devoted to the study of ideas, traditions, cultures, and institutions in science, higher education, and research. It is equally focused on historical as well as present practices and on local as well as global issues. Moreover, the journal does not represent one single school of thought, but rather welcomes diversity within the rules of rational discourse».
Questi i riferimenti:
Shir-Raz, Y., Elisha, E., Martin, B. et al.
Censorship and Suppression of Covid-19 Heterodoxy: Tactics and Counter-Tactics. Minerva (novembre 2022; https://doi.org/10.1007/s11024-022-09479-4).
E questo il link: Censorship and Suppression of Covid-19 Heterodoxy
Inserisco qui anche la versione pdf del saggio (con alcune mie sottolineature ed evidenziazioni).
Traduco parte dell’Abstract, che riporto per intero più sotto:
«L’emergere del COVID-19 ha generato numerose controversie. Allo scopo di neutralizzare ciò che è sembrata una minaccia da parte di medici e scienziati che criticano la posizione ufficiale delle autorità sanitarie governative e intergovernative, alcuni sostenitori dell’ortodossia hanno agito per censurare coloro che promuovono opinioni dissenzienti.
Lo scopo di questo studio è indagare le esperienze e le risposte di medici e ricercatori altamente qualificati di diversi Paesi che sono stati oggetto di repressione e/o di censura a causa delle loro pubblicazioni e dichiarazioni relative al COVID-19.
I risultati dell’indagine indicano il ruolo centrale svolto dai mezzi di informazione, in particolare dalle società che gestiscono l’informazione della Rete.
Nel tentativo di mettere a tacere le voci alternative, è stata ampiamente utilizzata la censura, alla quale si sono aggiunte modalità di repressione che hanno danneggiato la reputazione e la carriera di medici e scienziati dissenzienti. E questo indipendentemente dal loro status accademico o medico e indipendentemente dalla fama scientifica che avevano prima di esprimere una posizione contraria all’ortodossia.
Invece di una discussione aperta ed equanime, la censura e la repressione del dissenso scientifico hanno implicazioni dannose e di vasta portata per la medicina, per la scienza e per la salute pubblica».
«The emergence of COVID-19 has led to numerous controversies over COVID-related knowledge and policy. To counter the perceived threat from doctors and scientists who challenge the official position of governmental and intergovernmental health authorities, some supporters of this orthodoxy have moved to censor those who promote dissenting views. The aim of the present study is to explore the experiences and responses of highly accomplished doctors and research scientists from different countries who have been targets of suppression and/or censorship following their publications and statements in relation to COVID-19 that challenge official views. Our findings point to the central role played by media organizations, and especially by information technology companies, in attempting to stifle debate over COVID-19 policy and measures. In the effort to silence alternative voices, widespread use was made not only of censorship, but of tactics of suppression that damaged the reputations and careers of dissenting doctors and scientists, regardless of their academic or medical status and regardless of their stature prior to expressing a contrary position. In place of open and fair discussion, censorship and suppression of scientific dissent has deleterious and far-reaching implications for medicine, science, and public health».
La ricerca di Yaffa Shir-Raz, Ety Elisha, Brian Martin, Natti Ronel & Josh Guetzkow si colloca in ambito sia epistemologico sia politico, mostrando i legami tra tali campi, studiati con particolare profondità da filosofi come Kuhn e Feyerabend.
A tali riferimenti ‘alti’ aggiungo la più ordinaria ma significativa esperienza quotidiana degli ultimi tre anni. C’è infatti chi invoca, anche dai decisori politici, vecchie censure e «nuovi paradigmi» «allo scopo di adeguare i libri di testo per scuole e università alla lotta contro il patriarcato e la guerra». C’è chi cerca di mettere insieme «pacifismo» e «invio di armi a Kiev». E ha anche l’abitudine poco pacifista di insultare con vari epiteti chi non la pensa come lui.
Leggendo il testo di Minerva mi sono venuti in mente due ‘colleghƏ’ a* qual* qualche tempo fa ho sentito dire che «persino mie amiche laureate dicono di avere dubbi sulla quarta dose, che io farò subito, anche perché ho più di 60 anni», al che l’altro risponde «tanti non si fidano dell’autorità ma allora di chi possiamo fidarci?», infine la prima conferma: «non capisco perché le autorità dovrebbero danneggiare dei cittadini».
Rispetto a simili personaggi, io credo che sia più degna, più libera e naturale, persino più intelligente, l’esistenza di due miei vicini di casa e di quartiere a Catania: un pescatore analfabeta che chiama «nivuri» tutti gli immigrati e ‘u zu Cicciu Fimminaru’ (nome di fantasia), che si gode la vita come piccolo fuorilegge e seduttore. Tutti costoro guardano la televisione ma evidentemente nei meno acculturati il suo veleno sembra rimanere più in superficie.
In ogni caso, queste esperienze quotidiane sono forme nelle quali l’esistenza disvela se stessa, illuminando da un lato la natura e i limiti della conoscenza e dall’altro la potenza di stili naturali per nulla politicamente corretti. Al di là di tutte le censure c’è la vita e le sue passioni.