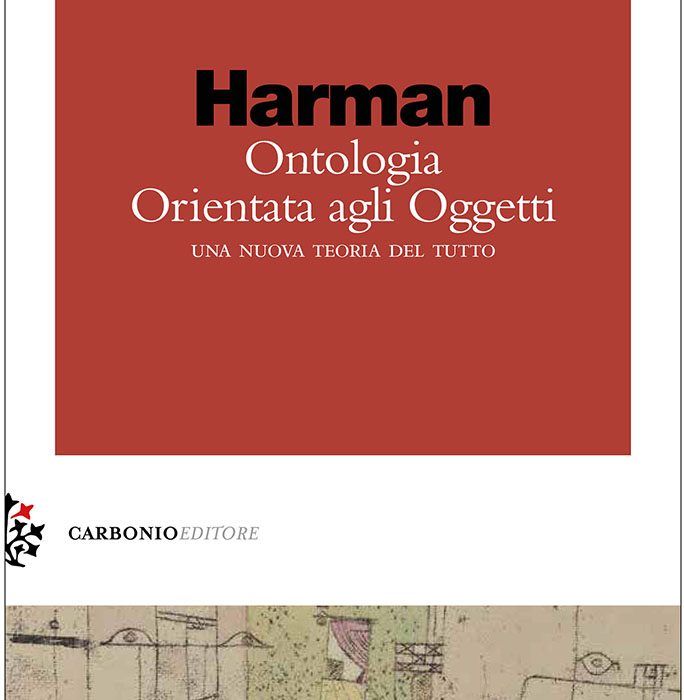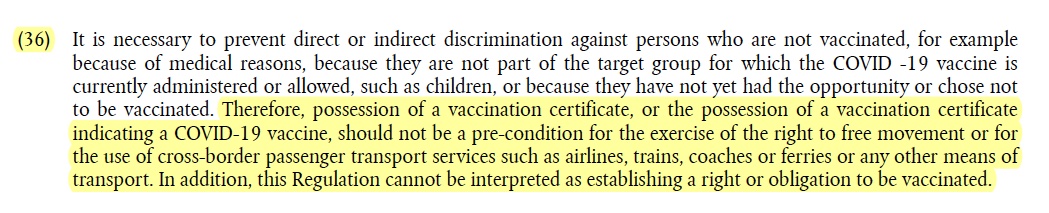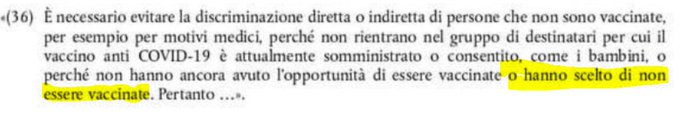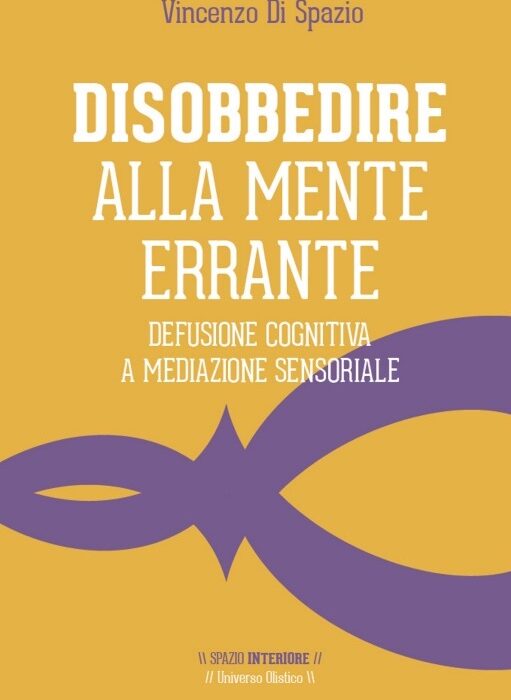Wolfgang Sofsky
Saggio sulla violenza
(Traktat über die Gewalt, Fischer Verlag, 1996)
Trad. di B. Trapani e L. Lamberti
Einaudi, 1998
Pagine 196
Perché la violenza dell’uomo contro altri uomini, contro le cose, contro la natura è così costante nel tempo, così presente nei contesti storici più diversi, così pervasiva della condizione umana? A una domanda tanto diretta e centrale molte etiche e antropologie della modernità rispondono con le varie forme del riduzionismo storico. Per esse, infatti, il male è qualcosa di contingente, nato nel tempo storico e quindi nel tempo storico superabile. Il libro di Wolfgang Sofsky ha il merito di dimostrare che invece «la violenza è il destino della nostra specie. Ciò che cambia sono le forme, i luoghi e i tempi, l’efficienza tecnica, la cornice istituzionale e lo scopo legittimante» (p. 193).
Se vogliamo capire, dobbiamo partire dalla corporeità che tutti ci accomuna, al di là delle differenze nello spazio, nel tempo, nella ricchezza e nell’intelligenza. La società si fonda sui corpi e sul loro bisogno di nutrirsi e di difendersi. Un’antropologia davvero materialistica non può non riconoscere che «il corpo non è una parte dell’uomo, bensì il centro della sua costituzione» (53). Il corpo è sempre sottoposto al rischio di diventare vittima della violenza altrui ma può trasformarsi esso stesso in un’arma volta a distruggere gli altri. In effetti, chi volesse eliminare tutte le armi dal mondo non dovrebbe svuotarlo solo di ogni oggetto ma dovrebbe trasfigurare l’uomo stesso in un ente incorporeo.
L’insieme dei corpi uniti alla difesa forma la società. Essa nasce insieme ai tabù, ai divieti, alle leggi tese a salvaguardare la comunità umana, a impedire la violenza della condizione di natura: «la società è una misura preventiva di reciproca difesa» (5). E tuttavia la società genera un ordine che implica anch’esso l’utilizzo sistematico della violenza: «la violenza crea caos e l’ordine crea violenza. Questo dilemma è irrisolvibile» (5). Il potere nato per limitare la violenza la innalza invece a livelli assoluti. Sta anche qui il vicolo cieco della storia umana.
L’insieme delle tecniche giuridiche, etiche, sociali, religiose tese a tenere la violenza sotto controllo è ciò che chiamiamo cultura/civiltà (Kultur). E tuttavia in nome di valori come lo stato, la sicurezza, il dio, la violenza si moltiplica, si radicalizza, giustifica se stessa come strumento del Bene, dell’Unità, della Giustizia. Dove dominano dei valori assoluti altrettanto assoluta si fa la violenza. La difesa del Valore sacrifica le Vite, le immola a un principio più importante, le immola all’Etica.
L’assolutizzazione dei valori genera l’utopia. In suo nome e per suo conto la violenza si scatena senza più alcun freno. Nulla può opporsi alla speranza della Perfezione. Ogni sacrificio dell’oggi è benedetto in nome della gioia di domani. Gli epigoni secolari dei preti fanno della storia lo spazio dell’assoluto e in nome del Bene sono disposti a uccidere un numero sterminato di vittime. «Il terrore rivoluzionario accade nel segno della virtù, della ragione o della giustizia. Il totalitarismo moderno propaga la completa uguaglianza sociale o l’omogeneità razziale e inevitabilmente sfocia nello sterminio dell’uomo. Il sogno dell’assoluto partorisce violenza assoluta» (191). Ogni progetto rivoluzionario che è riuscito a prendere il potere ha esasperato la violenza, conferendole una dimensione salvifica tesa ad annullare ogni possibile critica.
Corporeità, società/Stato, Kultur e utopia sono intessuti di violenza. Una tale pervasività non può essere compresa né spiegata con motivazioni soltanto economicistiche, sociologiche, contingenti: «nonostante tutti gli sforzi morali, tutte le fatiche per domare la brutalità il male è eterno. Gli strati più primitivi dell’anima sono ciò che è realmente immortale» (194).
La violenza, infatti, soddisfa alcuni dei desideri più specifici e profondi dell’essere umano. Ciò che di solito viene letto come espressione di patologie individuali, di fanatismo collettivo, di arretratezza storica, di lotta ideologica -la crudeltà infanticida di Gilles de Rais, le torture delle Inquisizioni cattoliche o staliniste, i pogrom, le lotte fra gladiatori, i massacri di civili durante le guerre, gli autodafé e molto altro- ha alla sua radice l’illusione di onnipotenza che nasce dal dare la morte, dal sopravvivere agli altri. Ecco perché «la crudeltà non ha un fine. Non ha alcun altro senso oltre se stessa» (41); il suo senso, infatti, è la perpetuazione dell’atto di dominio con il quale il sopravvissuto gioisce dell’esserci ancora, esulta del potere assoluto che gli conferisce il dare la morte. Ed è qui che l’intuizione freudiana, l’Unbehagen della Kultur mostra la sua fecondità euristica: «la cultura è lo sforzo vano di superare la morte. Essa ha la medesima radice della violenza assoluta: la megalomania della sopravvivenza […] Il mostruoso sogno di dominare la morte partorisce solo mostri. La violenza è inerente alla Civiltà [Kultur, qui mal tradotto con “cultura”]: è completamente plasmata dalla morte e dalla violenza» (185 e 188).
Soltanto un’antropologia negativa può comprendere davvero cosa si muove dietro le quinte del teatro della storia, può smascherare quella «superstizione dell’ottimismo» (184) che in nome di speranze assolute ha fatto del Novecento il secolo dello sterminio: «il ventesimo secolo infine non sperimentò solo un immenso progresso delle tecniche belliche, ma anche il costante incremento dell’uso della tortura, nelle guerre grandi e piccole, nelle camere di tortura delle dittature e dei regimi di occupazione, nei campi di concentramento del totalitarismo […] Alla fine della civilizzazione l’impeto creativo della crudeltà è giunto a un momentaneo apice» (71) . E dunque la spocchia di «vivere in un’età di progresso dei costumi è indice non solo di presunzione, ma anche di cecità storica; appartiene alla mitologia della civiltà moderna. La cronaca delle guerre e dei crimini di massa già da tempo ha smentito questa falsa credenza» (192).
Insieme a ogni ottimismo storico-teologico, Sofsky respinge le interpretazioni salvifiche del dolore, tese ad attribuirgli un valore del tutto fantastico e consolatorio. I racconti di violenza e di tormento fisico che scandiscono questo libro -a volte davvero duro- mostrano che «il dolore è il dolore. Non è un segno, né trasmette alcun messaggio. Non rimanda a nulla. Non è nient’altro che il più grande di tutti i mali» (56).
La natura umana è intrisa di violenza; il pactum unionis/subjectionis creato per limitarne i danni utilizza sistematicamente la medesima violenza. La civiltà è quindi plasmata da crudeltà, intessuta di morte. Vie d’uscita da questo circolo non sembrano esserci se è vero che proprio perché «non è guidato dagli istinti, poiché è un essere dotato di intelletto», l’uomo «è in grado di comportarsi peggio della più malvagia delle bestie» (194).
Una conclusione desolata ma non gratuita, fondata com’è su una miriade di testimonianze, esempi, racconti e soprattutto sulla capacità di individuare in esse alcune costanti antropologiche. Una delle principali fonti di Sofsky è, infatti, la visione dell’umano e della storia di Elias Canetti -soprattutto quell’unicum della cultura del Novecento che è Masse und Macht– con le sue intuizioni del corpo-massa, della muta, dell’uccidere come forma più elementare del sopravvivere, del potere come spina infitta nelle carni dell’uomo, quel Canetti che una splendida mostra al Beaubourg ha potuto definire «l’ennemi de la mort».
Se le risposte sembrano mancare, questo libro ha il merito di porre con estrema chiarezza alcune domande essenziali per capire ciò che siamo davvero. Il suo limite più consistente è un altro e sta nel permanere di un pregiudizio antropocentrico che sembra limitare la violenza alla specie umana. In realtà il divorare e il distruggere sono presenti ovunque ci sia animalità, ovunque si dia una vita consapevole. Perché il male è il βίος.