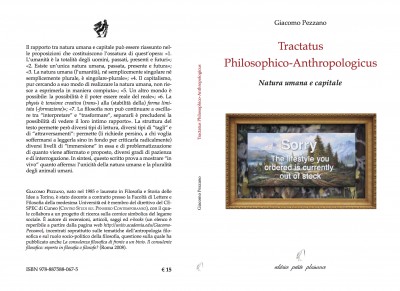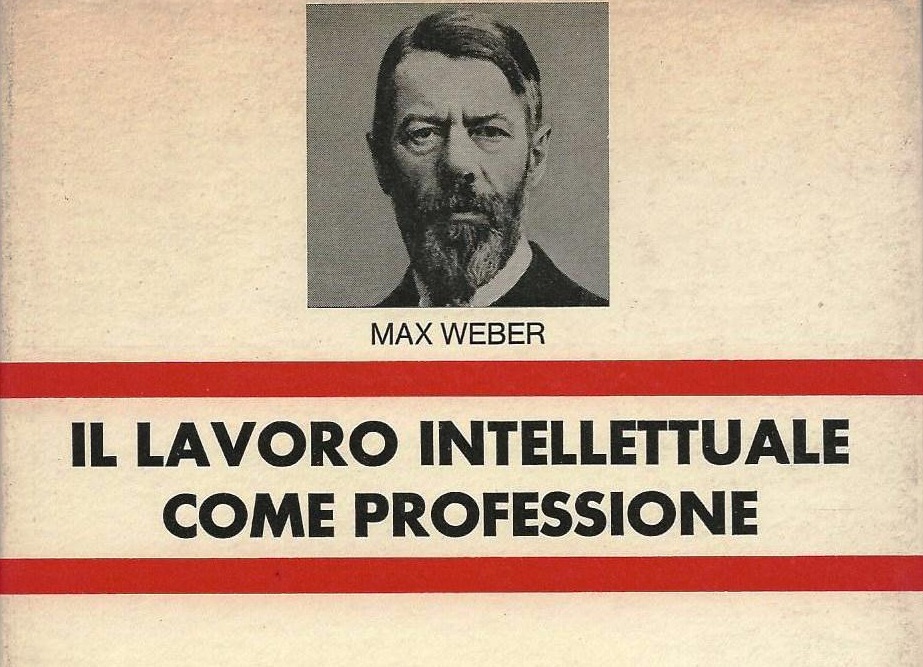(Wissenschaft als Beruf – Politik als Beruf, 1918)
di Max Weber
Traduzione di Antonio Giolitti
Einaudi, Torino 1994
Pagine XLII-121
In due conferenze tenute nel 1918 all’Università di Monaco, Max Weber raccoglie il senso delle sue riflessioni e della sua dottrina. Affrontando il problema della scienza e della politica come Beruf, vocazione e professione, Weber enuncia alcuni dei temi chiave del suo pensiero: le modalità attraverso le quali si seleziona una classe dirigente; lo Stato quale organismo che «esige per sé (con successo) il monopolio della forza fisica legittima» (pag. 48); i tre tipi di potere e le loro caratteristiche: tradizione, carisma, norma; etica della convinzione ed etica della responsabilità; scienza contemporanea e specializzazione; razionalità e disincantamento del mondo.
Chi senta di possedere il dono (Gabe) della scienza e voglia coltivarlo con serietà e fecondità deve prima di tutto distinguere fra le proprie personali opinioni e le acquisizioni scientifiche che raggiunge e anteporre sempre le seconde alle prime. Quando poi lo studioso sia anche un insegnante, è suo specifico dovere non utilizzare l’inevitabile prestigio rispetto agli allievi per farsi propagandista di un’idea dalla cattedra, poiché«tra le pareti dell’aula d’insegnamento una sola virtù ha valore: la semplice probità intellettuale» (42). Pur nella lucida consapevolezza che «nessuna scienza è assolutamente priva di presupposti» (39), lo studioso deve mirare alla verità raggiungibile nel suo tempo e rispetto all’oggetto di indagine. Ciò diventa possibile solo tramite il duro lavoro che non da ispirazioni improvvise si aspetta chissà quali rivelazioni ma dalla costanza dell’impegno quotidiano. Un tale rigore consente poi a chi insegna di esporre tutti quei fatti “imbarazzanti” dai quali scaturiscono le domande e quindi il sapere.
Una simile etica della ricerca consente a Weber di osservare la realtà storica e politica senza pregiudizi e di poter formulare quindi delle valutazioni spregiudicate e a volte persino profetiche. Fra queste ultime sono di particolare rilievo quelle dedicate alle conseguenze di una pace punitiva verso la Germania (previsioni analoghe a quelle di Lloyd George e Keynes) e alla dinamica della Rivoluzione sovietica. Lo sferzante giudizio sull’Ottobre come «un carnevale che si ammanta del nome altisonante di ‘rivoluzione’» (101) è giustificato in primo luogo dalla constatazione che i bolscevichi vanno restaurando gran parte delle istituzioni borghesi contro cui sono insorti, al semplice e vitale scopo di far funzionare lo stato e l’economia, e poi dalla acuta conoscenza della dinamica di tutte le rivoluzioni.
Il realismo di Weber consiste in due principali elementi: la consapevolezza che in politica il mezzo decisivo è la forza e la conseguente, netta, distinzione fra politica e religione. Weber descrive in maniera accurata i meccanismi del potere in luoghi diversi e in differenti epoche, dallo spoil system statunitense alle clientele dei partiti europei con le loro distribuzioni di impieghi e prebende. Se l’esercizio del potere è un fine in se stesso, «per godere del senso di prestigio che ne deriva» (49), «non si dà aberrazione dell’attività politica più deleteria dello sfoggio pacchiano del potere e del vanaglorioso compiacersi nel sentimento della potenza, o, in generale, di ogni culto del potere semplicemente come tale» (103). Si direbbe che Weber abbia previsto quali forme di degenerazione dell’attività politica si sarebbero presentate in Italia nei nostri anni. In quanto attività esclusivamente mondana, la politica necessita della violenza e del compromesso. Chi dunque «anela alla salute della propria anima e alla salvezza di quella altrui, non le cerca attraverso la politica» (117).
Da questi presupposti realistici scaturisce quello che è stato definito il cesarismo quale unico antidoto alle degenerazioni della società di massa. In realtà Weber ritiene che le forme della democrazia contemporanea siano già di per sé «una dittatura fondata sullo sfruttamento della natura sentimentale delle masse» (89). In tale condizione una democrazia senza capi carismatici si consegna al dominio dei politici di professione, privi di progetti e di capacità che non siano quelli del mero utilizzo personale del potere. La fiducia weberiana verso il carisma è certo eccessiva e ambigua, ciò non toglie che la descrizione delle democrazie di massa come regimi partitocratici in mano a notabili rimanga esatta.
Il più intimo pensiero di Weber emerge nelle righe conclusive di queste conferenze, laddove lo studioso sostiene -con un’energia che maschera l’amarezza di fondo- come abbia vocazione per la politica solo chi di fronte alla volgarità e stupidità degli uomini non si ritiri disgustato, voglia ancora offrire un progetto e un itinerario e dica a se stesso: «Non importa, continuiamo!» (121). In tale affermazione convergono il rigore etico, il realismo antropologico, l’ottimismo della volontà che ispirano dalla prima all’ultima frase questo testo. Che Weber si sia alla fine ritirato dall’attività politica dopo una fase di intenso impegno non rappresenta un suo privato fallimento ma la conferma dell’impossibilità di fatto -da parte di chi indaga criticamente sulla realtà- di accostarsi all’insipienza delle masse. Lo stesso fallimento di Platone.

 la si noti anche nella foto qui accanto) è lo scarto che permette il futuro nella fedeltà alla grande bellezza del passato.
la si noti anche nella foto qui accanto) è lo scarto che permette il futuro nella fedeltà alla grande bellezza del passato.