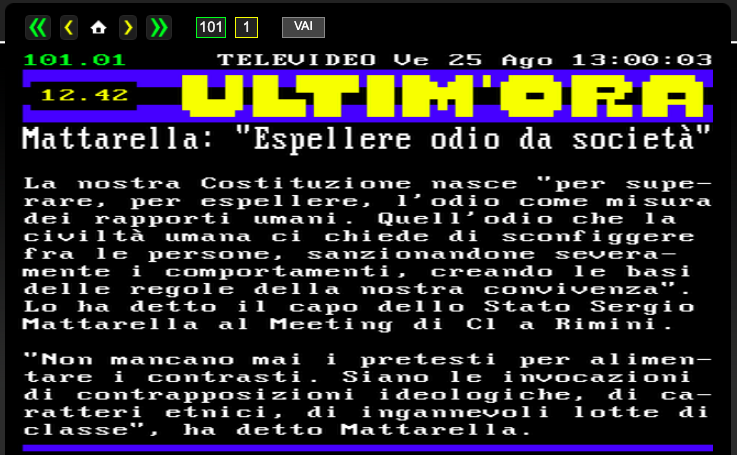Illusioni perdute
(Illusions Perdues)
di Xavier Giannoli
Francia, 2021
Con: Benjamin Voisin (Lucien), Cécile De France (Louise), Xavier Dolan (Nathan), Vincent Lacoste (Etienne Lousteau), Salomé Dewaels (Coralie), Gérard Depardieu (Dauriat), Jeanne Balibar (Marquise d’Espard)
Trailer del film
Per Marcel Proust il miglior romanzo di Balzac è Illusions Perdues. La continuità tra questo libro e la Recherche è evidente nella narrazione dei fasti delle aristocrazie, nell’importanza dei titoli nobiliari, nel rapporto complesso con le borghesie in ascesa. E soprattutto nella profonda consapevolezza che dentro il turbine delle ambizioni, degli amori e delle passioni, tutto è Havèl havalím, vanità delle vanità o -come traduce Guido Ceronetti- «fumo di fumi / dice Qohélet / Polvere di polveri / tutto fumo / polvere» (Qohélet o l’Ecclesiaste, Einaudi 1988, 1,2, p. 3).
Balzac non è soltanto un romanziere ma è anche uno dei più attenti sismografi del suo tempo (e del nostro), un autentico sociologo che ha la piena consapevolezza di come dopo l’Ottantanove e Napoleone, la storia stia rapidamente inclinando verso il dominio di qualcosa che gli umani utilizzano da millenni -ciò che Marx chiama l’«equivalente generale», il denaro- ma che adesso assume le forme nuove dell’informazione, della stampa, dei giornali, dei capitali. E infatti Lucien de Rubempré (nome musicalissimo) arriva a Parigi dalla provincia come protetto e innamorato di una nobildonna delle sue terre. Che però a Parigi non può più frequentarlo. La ferita è profonda. La disperazione si volge in volontà di affermarsi in ciò che Lucien meglio sa fare: scrivere. Ma il ragazzo scrive poesie, un genere che nessuno più compra, che nessuno più vende. La sua intelligenza si pone dunque al servizio dei giornali che esaltano o stroncano spettacoli teatrali, opere musicali, romanzi, attori, carriere, politici, uomini pubblici. Esaltano o stroncano in relazione a chi paga meglio, a chi ricambia con favori di carriera, di potere, di denaro. Agiscono dunque allo stesso modo del personaggio che con la sua claque vende applausi e fischi nei teatri, determinando il trionfo o la rovina di attori e impresari.
Balzac è del tutto consapevole che «necesse est enim ut veniant scandala, ‘è inevitabile che avvengano scandali, ma guai all’uomo a causa del quale lo scandalo accade!’» (Mt, 18,7 e Lc., 17,1). Gli scandali, le ‘polemiche’ sono necessari agli ambiziosi per farsi conoscere, alla stampa per vendere, al pubblico per guardare dal buco della serratura le vite degli altri. Balzac è del tutto consapevole persino del potere della pubblicità, che comincia a riempire i giornali e per la quale le aziende pagano bene, riempiendo di sé la ‘carta stampata’. L’obiettivo dell’informazione è dunque vendere in modo da poter aumentare le tariffe delle ‘inserzioni pubblicitarie’.
Un piano inclinato che conduce le aziende, gli affaristi, le banche, ad acquistare direttamente i giornali, le informazioni, le notizie e i giornalisti. Basti pensare che, in Italia, la Repubblica e La Stampa appartengono entrambi al gruppo Agnelli e Il Corriere della Sera è di proprietà di Urbano Cairo, ottimo sodale degli Agnelli. Gli scandali, le ‘polemiche’ sono necessari agli ambiziosi per farsi conoscere, ai siti e agli influencer per vendere, al pubblico di Internet per guardare dal buco della serratura le vite degli altri.
Ossessiva è in Balzac, e nel bel film che Xavier Giannoli ne ha tratto, la presenza del denaro, della cartamoneta, dei capitali. Il Narratore a un certo punto dice che «può darsi persino che un banchiere diventi un politico». In Italia e in Francia, ma non solo, i banchieri del XXI secolo sono direttamente diventati capi del governo. I quali negli ultimi due anni hanno letteralmente comprato l’informazione relativa all’epidemia Sars-COV-2 elargendo centinaia di milioni a giornali, televisioni, radio in cambio dell’inserimento di pubblicità governativa travestita da notizia dei telegiornali e degli articoli di giornale, come è consuetudine da parte di molte aziende ma come è evidentemente assai grave da parte dei governi su questioni quali la salute.
Le illusions perdues dei cittadini camminano parallele ai conti correnti dei giornalisti. Chi è più sciocco, il bugiardo o colui che al bugiardo crede?