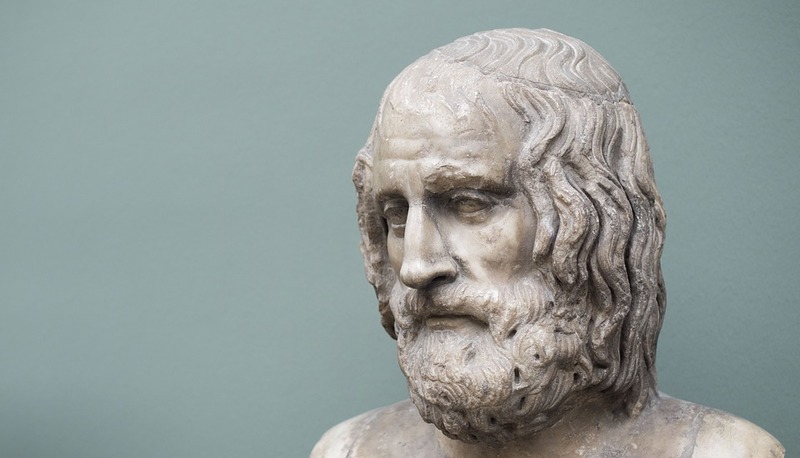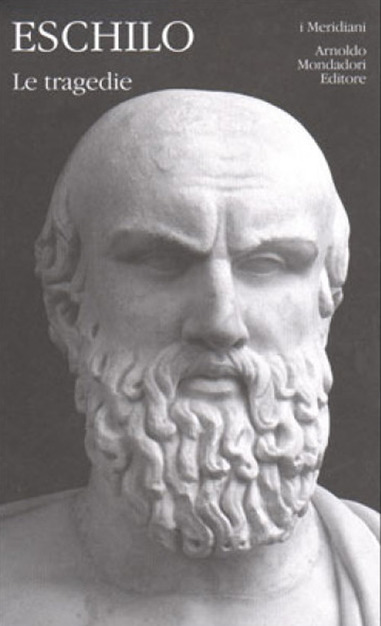
La distruzione della flotta persiana a Salamina da parte degli Elleni è dovuta alla ὕβρiς di Serse, dimentico del nomos terrestre, della prudenza con la quale suo padre Dario aveva rinunciato al tentativo di domare il Bosforo per sottomettere l’Europa all’Asia. Una prudente sapienza che nasceva dal rispetto per «θεόθεν γὰρ κατὰ Μοῖρ᾽ ἐκράτησεν / τὸ παλαιόν; un destino che forte vigeva in antico»1 e che i mortali, tutti, debbono sempre avere davanti nel loro scosceso cammino dentro il morire che si chiama vita. Ate, infatti, «βροτὸν εἰς ἄρκυας Ἄτα, / τόθεν οὐκ ἔστιν ὕπερ θνατον ἐξαλύξαι φυγειν; spinge il mortale dentro la rete ben tesa: da là all’uomo è preclusa ogni fuga, ogni scampo» (vv. 99-100, pp. 22-23).
Storica è dunque la prima tragedia che ci sia rimasta dei Greci? Sì, a condizione di non intendere la storia soltanto come un insieme di avvenimenti accaduti e narrati. La storia dei Persiani è infatti costruita su una antropologia sacra, su una teologia che riconosce al di là di ogni volontà umana (volontà che è una delle maggiori illusioni della cultura venuta dopo i Greci e i Romani) la presenza e la potenza di Ἀνάγκη: «ὅμως δ᾽ ἀνάγκη πημονὰς βροτοῖς φέρειν / θεῶν διδόντων; Necessità [che] costringe i mortali a sopportare sciagure» (vv. 293-294, pp. 36-37).
Ἀνάγκη che salva sempre «πόλιν Παλλάδος θεᾶς; la città della Pallade dea!» (v. 347, p. 40-41) e rispetta coloro che fanno di sé un modo di σωφροσύνη, una forma della misura dolente dell’esserci, evitando per quanto possibile la ὕβρις della quale il persiano Serse è una incarnazione evidente, plastica sino alla disperazione. Contro la tracotanza dissacrante del proprio figlio, il fantasma di Dario pronuncia parole che sono greche sino al midollo, lui che è uno dei più grandi sovrani tra i barbari. L’ironia della tragedia, in particolare di questa tragedia, sta anche nel parlare dei barbari così vicino -identico- alla Stimmung dei Greci.
Sentiamolo dunque questo fantasma di saggezza e di canto: «ὡς οὐχ ὑπέρφευ θνητὸν ὄντα χρὴ φρονεῖν. / ὕβρις γὰρ ἐξανθοῦσ᾽ ἐκάρπωσεν στάχυν / ἄτης; non deve chi è mortale esser troppo superbo. La superbia dopo il fiore dà frutto: ed è spiga di rovina da cui si miete messe di pianto» (vv. 820-822, pp. 72-73). Da barbaro sapiente, da greco, Dario esorta tuttavia i suoi antichi sudditi, che vede prostrati sino a un pianto che sembra non conoscere fine; li invita a gustare ancora il frutto di gioia che ogni giorno può aprire agli eventi: «ὑμεῖς δέ, πρέσβεις, χαίρετ᾽, ἐν κακοῖς ὅμως / ψυχῇ διδόντες ἡδονὴν καθ᾽ ἡμέραν, / ὡς τοῖς θανοῦσι πλοῦτος οὐδὲν ὠφελεῖ; E voi, vecchi, fatevi animo: anche nella sventura dovete concedere al vostro cuore un po’ di gioia ogni giorno. Questo serve, e non altra ricchezza, a chi è destinato alla morte!» (vv. 840-842, pp. 74-75).
I Greci i quali «οὔτινος δοῦλοι κέκληνται φωτὸς οὐδ᾽ ὑπήκοοι; si vantano di non essere schiavi di nessun uomo, sudditi di nessuno» (v. 242, pp. 32-33) hanno ridotto il Grande Re, il Padrone dei persiani, il Signore dell’Asia, alla condizione di uno straccione che con vesti lacere si presenta e non parla, grida soltanto, canta la propria definitiva sciagura mentre ad attenderlo «κακοφάτιδα βοάν, κακομέλετον ἰὰν; è un urlo di morte, un canto di sciagura» (v. 936, pp. 78-79).
Questo avvenne venticinque secoli fa e tali eventi hanno per millenni garantito l’Europa dalla forma totalitaria della politica. Sino a quando al culmine della modernità che non crede nella sacralità del mondo e della materia si è installata e continua a dominare la ὕβρις. Ma tutto si paga, anche nella forma di un minuscolo virus.
Nota
1. Eschilo, Persiani (Πέρσαι, 472 a.e.v.), versi 102-103, pagine 20-21, in Le tragedie, traduzione, introduzioni e commento di Monica Centanni, Mondadori, Milano 20133, pagine LXXXII-1245.
Le successive citazioni saranno indicate nel testo con i numeri dei versi seguiti da quelli della pagina dell’edizione Centanni/Meridiani.