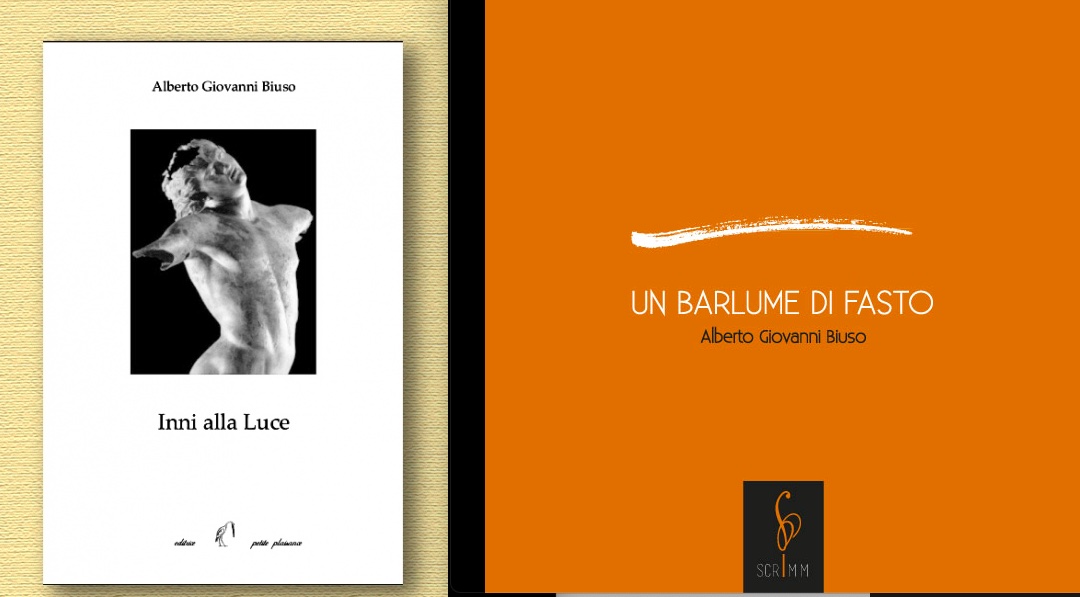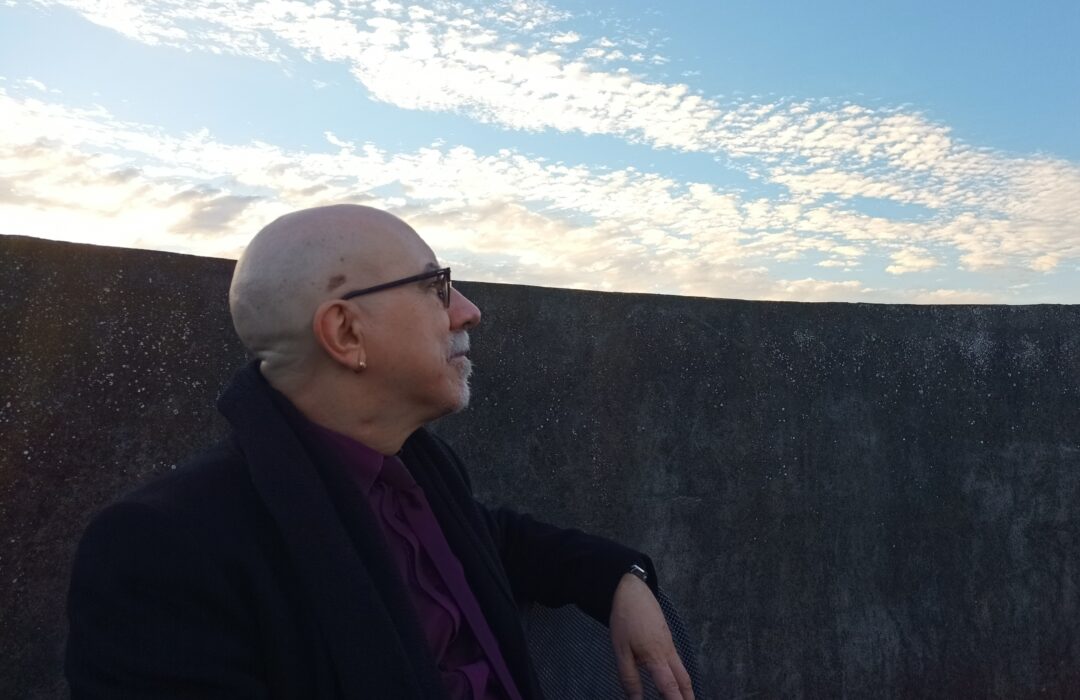Il mio profilo migliore
(Celle que vous croyez)
di Sayf Nebbou
Francia, 2019
Con: Juliette Binoche (Claire Millaud), Nicole Garcia (Catherine Bormans), François Civil (Alex Chelly)
Trailer del film
Il titolo originale di questo film suona un poco pirandelliano, quasi un Come tu mi vuoi, la decisione e il bisogno di apparire all’altro come vorremmo che l’altro ci vedesse, nel nostro profilo migliore. Il titolo italiano in questo caso restituisce parte del significato dell’opera, dato che il profilo al quale fa riferimento è quello dei Social Network. Claire Millaud è infatti una bella docente universitaria cinquantenne, lasciata dal marito, con due figli adolescenti, con un amante che non la ascolta mai ed è interessato soltanto al sesso. Questo amante ha un giovane collaboratore, Alex, un fotografo del quale Claire vede il profilo su facebook e quasi per gioco e per contattarlo si inventa l’identità fasulla di una bella ventiquattrenne. Messaggio dopo messaggio, parole dopo parole, e poi telefonata dopo telefonata, Claire e Alex iniziano una relazione virtuale che nella prima parte del film viene raccontata dalla donna alla propria analista e nella seconda parte si dipana in vari ‘colpi di scena’ e in finali su finali nei quali il confine tra reale e virtuale si assottiglia sempre più. Anche la scena di chiusura sembra preludere a sviluppi forse ovvi, forse patologici, forse inquietanti.
Due mi sembrano i temi centrali di Celle que vous croyez.
Il primo è la potenza, le modalità, le opportunità e i rischi della comunicazione tramite cellulare telefonico, dello scambio vissuto solo virtualmente, ‘da remoto’. Gli umani non riescono a inventare nessun dispositivo che non risulti intrinsecamente ambiguo, per la semplice ragione che ambigui sono loro stessi: πολλὰ τὰ δεινὰ κοὐδὲν ἀνθρώπου δεινότερον πέλει, afferma il verso 332 dell’Antigone di Sofocle: “molti enti ed eventi ammirevoli e terribili ci sono al mondo ma nulla appare più ammirevole e terribile dell’umano”. E tale terribilità fa riferimento in Sofocle proprio alla natura tecnica dell’animale umano. Lo stasimo sofocleo si conclude con l’affermazione che un simile commensale non sarebbe il benvenuto a tavola.
Le possibilità, offerte dalle tecnologie digitali, di intrecciare relazioni e comunicazioni in ogni istante e con chiunque, si mescolano dunque alla possibilità che tali relazioni e comunicazioni siano fasulle, diventino patologiche, costituiscano un rischio anche assai grave. E questo conferma che l’enfasi sul «remoto», della quale il corpo sociale è stato vittima e carnefice in occasione dell’epidemia Covid19, è un’altra forma di distruzione dei legami umani più sani.
Il secondo elemento del film, ovviamente legato al primo, è la solitudine, è l’innamorarsi, sono le passioni umane. E su questo mi limito a rinviare ad alcuni brevi testi che ho dedicato all’argomento:
Frammenti di un discorso amoroso (2009); Innamoramento ed evoluzione (2012 ); Amore / Vendetta (2016); Lezione sull’amore (2017); Roth (2018); L’Altro (2018); Nella spuma potente del cosmo (2019;); Gender (2021).
Nel primo di tali testi scrivevo che l’Altro è una figura del desiderio, del nostro e di quello diffuso nel corpo collettivo, nella filogenesi della specie. L’amato è per l’innamorato l’imprendibile che rimane desiderio – e dunque è la pienezza dell’assenza. Pur sapendo che non raggiungerò mai l’amorosa quiete delle tue braccia, in cui spasimi e drammi saranno appagati e redenti, io continuo a spogliarmi di ogni cosa, continuo a barattare la mia forza con l’istante del tuo sguardo, a rinunciare al mio sorriso per il tuo. Teso verso l’impossibile, il mio discorso è un soliloquio.
L’Altro, infatti, non esiste. Il linguaggio avvolge l’umano sin dal suo apparire, è l’umano nella concretezza del suo agire, esistere, comprendere, comunicare, pensare. L’innamorarsi è una delle pratiche linguistiche che della parola sanno esprimere l’intera potenza nel racconto che la mente narra a se stessa.
Che l’Altro sia una figura linguistica è esattamente ciò che il film mostra.