
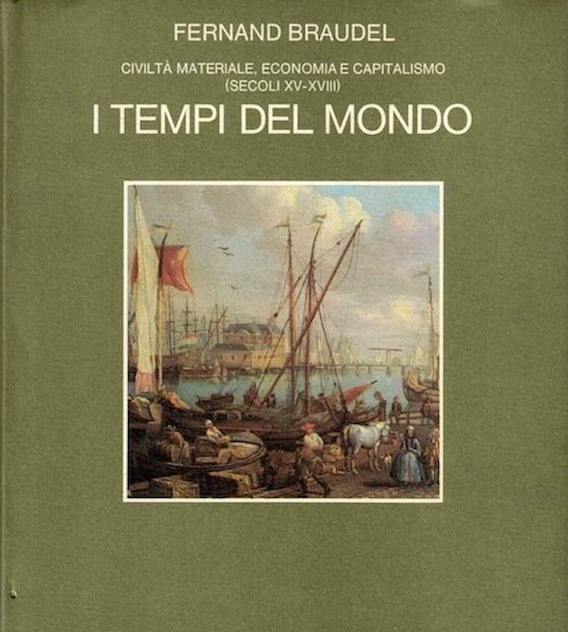
Sorvegliare e punire nel XXI secolo
Aldous, 5 aprile 2024
Pagine 1-2
La dottrina brezneviana dei «Paesi a sovranità limitata» è ampiamente descrittiva dell’Europa contemporanea. E questo anche perché una delle dinamiche più caratteristiche del primo quarto del XXI secolo è il progressivo indebolimento degli Stati e dei loro apparati politici, i quali mettono le proprie strutture amministrative e le riserve economiche al servizio dei poteri globali e multinazionali.
A offrire totale sostegno politico alle dinamiche liberticide è ‘la sinistra neoliberale’ che dà il titolo alla traduzione italiana di un libro di Sahra Wagenknecht, dirigente per alcuni anni del partito tedesco Die Linke (La Sinistra), libro che nell’originale porta la più efficace denominazione Die Selbstgerechten, che si può tradurre come ‘gli arroganti, gli ipocriti, i presuntuosi, gli autocompiaciuti’, plastica descrizione dell’idealtipo politico-antropologico che transita dall’internazionalismo ‘comunista’, ripudiato con orrore, all’internazionalismo ultraliberista di un capitalismo (da sempre) senza patria e senza identità, nel quale trionfa l’ontologia flussica e indeterminata di un essere umano che privandosi dell’identità nega anche la differenza, un umano esistente soltanto come luogo di passaggio puramente volontaristico e privo di radici territoriali, culturali, biologiche.

Alberto Capece è un giornalista che sul sito il Semplicissimus pubblica con regolarità delle analisi sintetiche, documentate e molto chiare sulla politica internazionale e qualche volta anche sulla politica italiana. Inoltro spesso oppure segnalo tali articoli come ‘commenti’ a qualche testo del mio sito. L’articolo di Capece pubblicato lo scorso 27 marzo mi sembra particolarmente rilevante e lo riprendo qui per intero.
===========
Lunedì mattina [25 marzo 2024], quando le responsabilità ucraine nell’attentato al Crocus sono cominciate ad emergere con evidenza, armi ipersoniche russe hanno distrutto un quartier generale dei servizi di intelligence di Kiev e della Nato pochi secondi dopo l’attivazione dell’allarme aereo. Le difese aeree occidentali, tanto vantate, hanno completamente fallito, come del resto era accaduto in numerose occasioni anche se in questo caso la posta era più alta. Questa non è una notazione secondaria perché vuol dire che la Russia ha distrutto il mito della superiorità dell’Occidente nell’applicazione della forza. Ecco la chiave storica con cui giudicare gli eventi che stiamo vivendo prendendo le parole da un saggio di Samuel P. Huntington scritto poco meno di trent’anni fa, Lo scontro di civiltà e il rifacimento dell’ordine mondiale: «L’Occidente ha vinto il mondo non per la superiorità delle sue idee, dei suoi valori o della sua religione (a cui si convertirono pochi membri di altre civiltà), ma piuttosto per la sua superiorità nell’applicare la violenza organizzata. Gli occidentali spesso dimenticano questo fatto; i non occidentali non lo fanno mai».
Il colonialismo occidentale iniziò nel XVI secolo con la scoperta delle Americhe (che fra le altre cose costituì la rovina economica per l’Italia che fino ad allora era stata l’area più ricca dell’Europa) e terminò, con poche eccezioni, a metà del XX secolo. Questa forma di dominio è stata resa possibile dallo sviluppo delle tecnologie e dalla rapida crescita della popolazione, ma dalla seconda guerra mondiale in poi l’ Occidente è passato ad un nuovo modello di governo del mondo: dopo le immense stragi perpetrate praticamente ovunque sul pianeta si è cominciato a parlare di valori umani e diritti umani e di alcune regole che presumibilmente avrebbero consentito a tutti di goderne. Però questa facciata non ha retto bene: l’Occidente, e in particolare gli Stati Uniti, hanno abusato dell’ ‘ordine basato sulle regole’ aggirando il diritto internazionale ogni volta che non si adattava ai propri interessi. Ha continuato ad applicare la ‘violenza organizzata’ in tutte le circostanze e in ognuna di queste ha costruito delle regole diverse: Jugoslavia, Afghanistan e Iraq hanno dimostrato che l’Occidente avrebbe sostenuto qualunque regola gli potesse far comodo per giustificare le sue guerre. La recente vicenda del Niger che vorrebbe legarsi alla Russia e non agli Usa dimostra chiaramente che Washington sostiene la guerra contro la Russia per ragioni diverse dal diritto dell’Ucraina di scegliere i propri partner e di aderire alla Nato e che questo diritto esiste solo se la scelta cade sugli Usa.
Il conflitto in Ucraina è solo l’ultima ma più evidente dimostrazione che l’‘ordine basato sulle regole’ non esiste più, anche ammesso che sia esistito in qualche occasione: negli ultimi decenni, gli Stati Uniti hanno continuamente messo Mosca nella posizione di accettare il fatto compiuto dell’espansione della Nato a scapito degli interessi di sicurezza russi, oppure di resistere e subire le conseguenze di un crescente ostracismo economico e politico. Ma a un certo punto qualcosa si è rotto e l’accettazione russa dei ricatti occidentali è cessata, Mosca si è sottratta dall’ostracismo occidentale, cambiando così l’intero equilibrio di potere non solo in Europa, ma nel mondo.
Ora, è la Russia che mette l’Occidente di fronte a un dilemma: può assistere al totale disfacimento dell’Ucraina, oppure può intensificare gli sforzi fino ad arrivare al conflitto nucleare. Questo perché qualsiasi cosa al di fuori della vittoria totale dell’Ucraina è un’implicita ammissione che l’ordine economico e politico sta irreversibilmente cambiando. E Washington non vuole ammetterlo. Avendo perso le sue due principali fonti di potere, l’ordine basato su regole come strumento diciamo così di potere morbido e la sua superiorità militare come potere duro, l’Occidente o per meglio dire i clan di potere che lo controllano, ha bisogno di un nuovo strumento di deterrenza, un nuovo strumento che gli permetta di fare i propri interessi contro la volontà di altre potenze.
Lo ha scoperto esercitando la massima ferocia possibile. La guerra a Gaza, sostenuta dall’Occidente, è una dimostrazione che esso è disposto a superare ogni limite. Che è disposto a commettere un genocidio. Che farà di tutto per evitare che le organizzazioni internazionali intervengano per impedirlo. I clan che detengono il potere sovrano in Occidente, sono ritornati all’antica violenza perché non riuscendo più a costituire un punto di riferimento vogliono almeno essere temuti. Naturalmente a spese degli inermi perché quando trovano qualcuno che gli resiste, diventano isterici dalla paura.

Grecia / Europa
Aldous, 10 febbraio 2024
Pagine 1-2
L’articolo analizza le dinamiche di dissoluzione della cultura e della politica europee come emergono dall’Unione Europea, dall’Euro e dalla Nato. L’esempio più chiaro e drammatico delle conseguenze delle decisioni prese nell’ambito di tali strutture politiche, economiche e militari è il sacrificio della nazione e del popolo greco. Un sacrificio sull’altare dei mercati e della finanza che è la più emblematica e tragica conferma della rinuncia dell’Europa alla propria identità e alle libertà dalle quali è nata.
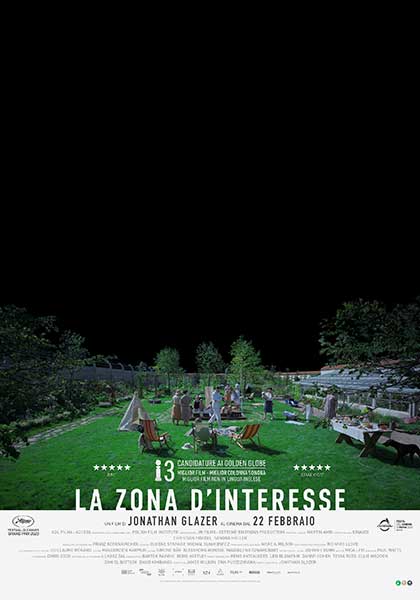
La zona d’interesse
(The Zone of Interest)
di Jonathan Glazer
Gran Bretagna, Polonia, USA, 2023
Con: Christian Friedel (Rudolf Höss), Sandra Hüller (Hedwig Hense Höss)
Trailer del film
La zona di interesse è quella tra il campo nazionalsocialista di Auschwitz in Polonia e la villa dove abitano il primo comandante del campo, Rudolf Höss, e i suoi familiari. Insieme alla moglie, ai cinque figli e alla numerosa servitù, Höss conduce la vita di un affettuoso padre di famiglia, nonostante gli impegni del campo: organizza gite sui prati e sul vicino fiume (dove si svolge la scena iniziale, dopo un lungo buio sullo schermo), trascorre qualche minuto con le amiche della moglie in visita, apprezza e segue i tanti miglioramenti che la coniuge apporta alla casa e al suo ampio giardino. Rifornisce anche la famiglia di beni (abiti e gioielli) sottratti ai prigionieri, comportamento punito dalle regole delle SS e che probabilmente è la ragione dell’ordine di trasferimento che riceve e che la moglie – innamorata della villa di Auschwitz e dei suoi dintorni – rifiuta, lasciandolo partire da solo. Per giustificarne ufficialmente il trasferimento, a Höss viene attribuito un incarico di supervisione di tutti i campi di concentramento. La scena finale lo vede di notte da solo uscire dal grande edificio dell’Amministrazione a Oranienburg, vicino Berlino. Vomita più volte e, dopo un breve inserto nel quale vediamo l’attuale Museo di Auschwitz, guarda gli spettatori e va via.
La distanza, la freddezza, l’assenza di primi piani, i colori saturi e intensissimi (quasi da pubblicità o da fumetto), la presenza di numerosi simbolismi anche onirici caratterizzano un film di notevole suggestione e significato, il cui argomento principe non è Auschwitz ma è ciò che possiamo definire come paradigma Eichmann, dalla nota risposta del responsabile dei campi nazionalsocialisti: «Ero un funzionario, ho fatto solo il mio dovere».
Anche Rudolf Höss è un funzionario, convinto – si legge nella voce di Wikipedia a lui dedicata (come tante altre voci per molti versi carente ma in questo caso accettabile) – di avere «un compito che egli, in qualità di soldato in tempo di guerra, sosteneva di non poter rifiutare». Compito di un buon funzionario è infatti quello di portare a termine nel modo più integrale ed efficiente gli incarichi che l’Amministrazione gli affida. Questo, dal punto di vista del paradigma Eichmann, è un dovere che non può turbare il funzionario stesso, la sua vita privata, la famiglia, qualunque sia il compito, poiché se i funzionari discutessero gli ordini ricevuti, e le Leggi sulle quali tali ordini si basano, l’Amministrazione cesserebbe di esistere. Questa innocenza e buona coscienza si allarga poi non soltanto alla famiglia ma anche al più ampio contesto sociale e antropologico che pure è consapevole dell’orrore, o almeno ne è a conoscenza, ma ritiene che per arrivare a tanto ci siano delle ragioni, anche delle ottime ragioni, delle ragioni di salvaguardia del corpo collettivo (quello tedesco o italiano, ad esempio), delle ragioni etiche.
Il paradigma Eichmann va quindi molto oltre gli anni 1942-1945 in Germania, dalla conferenza di Wannsee alla sconfitta militare. Va molto oltre gli anni 1933-1945, quelli del regime nazionalsocialista. Il paradigma Eichmann è tuttora attivo, funzionante, giustificato ed efficiente. Tre esempi recenti.
In questi mesi in Palestina – nella striscia di Gaza e in Cisgiordania – è in atto un genocidio palese e terrificante. L’organizzazione Save the Children afferma che a oggi (febbraio 2024) «circa 12.400 bambini sono morti e altre migliaia rimangono dispersi. Inoltre, in Cisgiordania sono stati uccisi 100 bambini palestinesi. L’organizzazione ha, inoltre, riferito a gennaio che, in media, circa 10 bambini al giorno hanno perso una o entrambe le gambe nell’enclave palestinese da quando è iniziata l’offensiva israeliana. Molte di queste amputazioni sono state eseguite senza anestesia» (Fonte: Gaza, numero senza precedenti di bambini uccisi e mutilati). E tuttavia la zona d’interesse dell’Occidente non soltanto continua serena la propria vita ma giustifica l’olocausto palestinese con tutti gli argomenti o i silenzi possibili, fornendogli anche supporto militare, finanziario e soprattutto politico.
Secondo esempio. Un intero Paese d’Europa, l’Ucraina, viene progressivamente annientato allo scopo di fermare le tendenze multipolari in atto da tempo nella politica mondiale, la tendenza a un ridimensionamento dell’unilateralismo e del dominio americano. Tendenza che gli Stati Uniti d’America – soprattutto il Partito Democratico e i suoi sostenitori nella finanza – non accettano in alcun modo. Le vittime di quest’ultimo conflitto imperialista voluto dalla NATO sono appunto l’Ucraina e l’intera Europa, la cui economia è in forte declino a causa del divieto di commerciare con la Russia (consiglio su questo tema la lucida analisi condotta da Leonardo Mazzei su Sollevazione del 13.2.2024: Terza guerra mondiale). E tuttavia i governi e molti cittadini europei, vittime di questa guerra che va a solo vantaggio degli USA, sono attivi sostenitori della potenza che li sta utilizzando per i propri scopi geopolitici. L’esecutivo italiano in carica, guidato da Giorgia Meloni, è all’avanguardia di tale sostegno al governo fantoccio di Kiev, come lo fu il governo Draghi.
Il terzo esempio concerne l’epidemia Covid19, sulla quale ho scritto molto (anche un libro: Disvelamento. Nella luce di un virus) e aggiungo quindi solo poche parole. Parole che riguardano due categorie: i responsabili dell’Università di Catania e alcuni dei suoi impiegati. I primi hanno sospeso dalle funzioni e dallo stipendio un professore che da più di vent’anni cerca di dare tutto ciò che può in termini scientifici e relazionali agli studenti a lui affidati. Sospensione che è durata un paio di settimane perché l’Amministrazione centrale (il governo italiano pro tempore) decise di attenuare le punizioni comminate ai cittadini non vaccinati ma i cui effetti di perdita di lavoro e di risorse di vita hanno toccato altri docenti e lavoratori per periodi assai più lunghi. I secondi – gli impiegati di Unict – hanno agito con molto e convinto zelo per impedirmi l’ingresso fisico nel Dipartimento al quale appartengo.
Si tratta di un esempio molto meno tragico dei due precedenti ma che ha la stessa duplice radice. La prima è la comfort zone nella quale i complici di un male si sentono sollevati da ogni responsabilità perché hanno semplicemente «eseguito gli ordini» e perché ritengono dogmaticamente e acriticamente che un governo (soprattutto se della loro ‘parte politica’) non può non fare gli interessi dei suoi cittadini e quindi bisogna ubbidirgli. Di questa comfort zone il film di Glazer è un’espressione davvero evidente e assai efficace. La seconda radice è la motivazione burocratico-amministrativa: ‘non abbiamo nulla contro il Prof. Biuso [o contro qualunque altro cittadino] ma abbiamo la responsabilità amministrativa e dobbiamo dare corso alle norme volute del governo’.
Rudolf Höss e Adolf Eichmann diedero nei processi la stessa risposta. Due persone anch’esse responsabili, scrupolose e persino etiche, come si vede anche dalla lettera che Höss inviò al figlio Klaus prima di essere giustiziato mediante impiccagione il 16 aprile 1947:
«Mio caro Klaus! Tu sei il più grande. Stai per affacciarti sul mondo. Ora devi trovare la tua strada nella vita. Hai delle buone capacità. Usale! Conserva il tuo buon cuore. Diventa una persona che si lascia guidare soprattutto da un’umanità calda e sensibile. Impara a pensare e giudicare autonomamente. Non accettare acriticamente e come incontestabilmente vero ciò che ti viene rappresentato. Impara dalla mia vita. Il più grave errore della mia vita è stato credere fedelmente a tutto ciò che veniva “dall’alto” senza osare d’avere il minimo dubbio circa la verità che mi veniva presentata. Cammina attraverso la vita con gli occhi aperti. Non diventare unilaterale: esamina i pro e i contro di tutte le cose. In ogni tua impresa non lasciare parlare solo la tua ragione, ma ascolta soprattutto la voce del tuo cuore. Mio caro ragazzo, ora molte cose non ti saranno del tutto comprensibili. Eppure ricordati sempre di queste mie ultime esortazioni».
I cittadini che giustificano il genocidio palestinese, quelli che sostengono gli USA contro l’Europa, i funzionari e gli impiegati che mi hanno sospeso dalle funzioni e dallo stipendio potrebbero riflettere sulle parole del loro modello e collega Rudolf Höss: «Il più grave errore della mia vita è stato credere fedelmente a tutto ciò che veniva “dall’alto” senza osare d’avere il minimo dubbio circa la verità che mi veniva presentata».
La zona d’interesse mostra come spesso il bene stia nel disobbedire e il male consista nell’essere parte attiva o passiva dell’Amministrazione.

Transizioni
Aldous, 27 gennaio 2024
Pagine 1-2
A partire dal caso della città dove abito, Milano, ho cercato in questo articolo di analizzare il significato, le contraddizioni e la forte spinta transumanista di alcune recenti tendenze alla “transizione”: transizione digitale, transizione ecologica, transizione di genere.
Tali transizioni sono fondate su un moralismo estremo che intende sostituire (per usare le categorie platoniche) il Vero con il Buono, dove che cosa sia Buono è naturalmente stabilito da chi ha il potere e le risorse economiche per convincere le masse degli spettatori.
Tutto questo è espressione di una posizione storico-politica ancora più ampia: l’occidentalismo. Esso consiste nella certezza che i valori dell’Occidente anglosassone (e non dell’Europa) siano valori universali, indiscutibili e santi. Un occidentalismo molto aggressivo, manicheo e sostanzialmente suicida visto che l’Occidente rappresenta una minoranza sul pianeta, sia dal punto di vista economico sia da quello demografico e in relazione alle risorse naturali.
Il rischio per un’Europa asservita all’ideologia occidentalista è di cadere nella spirale di una transizione verso la propria fine.
[L’articolo è uscito anche su Sinistrainrete]

Universalismo
Aldous, 5 gennaio 2024
Pagine 1-3
L’universalismo liberale dell’Occidente non si fa scrupoli ad agire in base a principi etnocentrici e razziali quando essi diventano funzionali alla sua politica di potenza. Conseguenza di tale universalismo etnocentrico è un sempre più esteso e capillare controllo delle opinioni critiche rispetto agli eventi (che si tratti di epidemia, di Ucraina, di Palestina), una sempre più chiara imposizione di slogan autoritari, un pericoloso tramonto della libertà di espressione.
In questo modo l’universalismo liberale si mostra in realtà per quello che è, una forma della volontà di potenza, un’espressione del rifiuto delle differenze e della molteplicità a favore di un’identità imperiale.
[L’articolo è uscito anche su Sinistrainrete]


