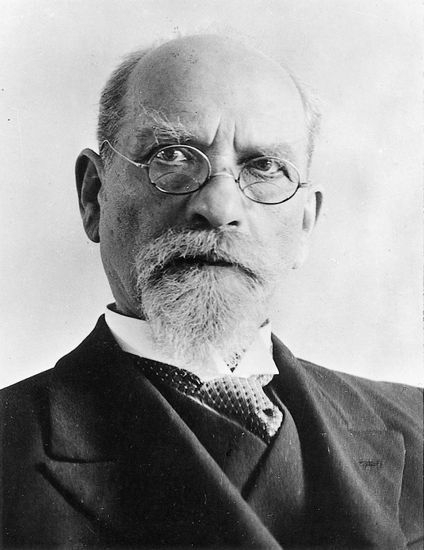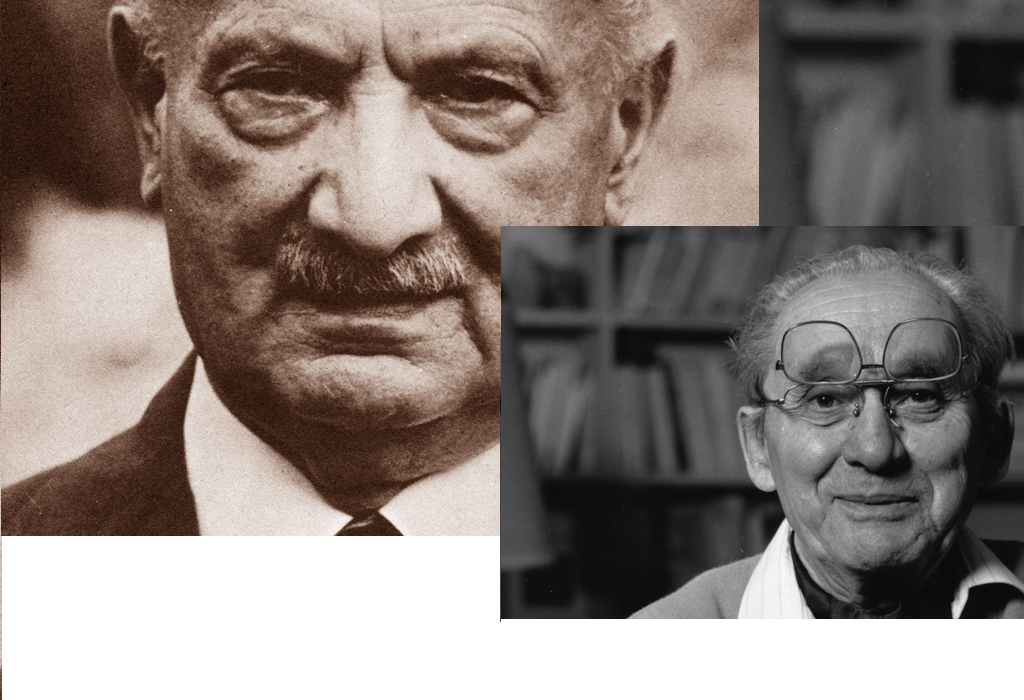Composto tra il 270 e il 272, probabilmente su invito di Plotino, il Κατὰ Χριστιανῶν di Porfirio (Contro i cristiani. Nella raccolta di Adolf von Harnack con tutti i nuovi frammenti in appendice [1916], a cura di Giuseppe Muscolino, Bompiani 2010, pagine 617) era un libro talmente efficace nei ragionamenti e nella forma da meritare la proscrizione già di Costantino prima del Concilio di Nicea (325) e poi nel 448 il rogo di tutte le copie, su decreto congiunto degli imperatori cristiani d’Oriente e d’Occidente Teodosio II e Valentiniano, i quali ordinano «che tutti quanti gli scritti di Porfirio, o di qualche altro, che egli scrisse spinto dalla sua follia contro il sacro culto dei cristiani, presso chiunque vengano trovate, siano gettate nel fuoco. Infatti tutti gli scritti che spingono Dio all’ira e offendono le anime (dei fedeli), non giungano alle orecchie; (così facendo) vogliamo venire in aiuto degli uomini» (Cod. Justin. I, 5, qui alle pp. 167-169). I roghi dei libri -dai cristiani ai nazionalsocialisti- hanno sempre avuto motivazioni morali. In questo caso «la ragione per la quale sappiamo così poco è che gli scritti di Porfirio erano ritenuti così potenti e spaventosi che furono completamente estirpati» (Catherine Nixey, Nel nome della Croce. La distruzione cristiana del mondo classico, Bollati Boringhieri 2018, p. 80). Il lavoro di Porfirio «fu immenso: almeno quindici libri, sappiamo che si trattava di un testo assai colto e che era, almeno per i cristiani, profondamente sconvolgente» (Ivi, p. 79).
Nel 1916 il filologo tedesco Adolf von Harnack pubblicò 121 frammenti sparsi, citati da altri autori -anche se non tutti di sicura attribuzione a Porfirio- che vennero da lui suddivisi in una parte di Testimonianze e poi in cinque sezioni tematiche dai titoli Critica del carattere e dell’affidabilità degli evangelisti e degli apostoli come principio della critica del cristianesimo, Critica del Vecchio Testamento, Critica degli atti e delle parole di Gesù, Dogmatica, Sulla Chiesa contemporanea.
Per comprendere il significato dirompente di quest’opera è essenziale fare un’epoché, mettere tra parentesi tutto ciò che conosciamo di Gesù, della sua figura, delle parole che vengono tramandate dai Vangeli, come se non ne sapessimo nulla. È difficilissimo, certo, ma se riuscissimo a farlo il risultato sarebbe quello indicato da Porfirio e che nessuna disperata dialettica di Girolamo, Agostino, Eusebio e altri polemisti cristiani riesce a nascondere. Quali risultati? Quelli che seguono, in gran parte confermati dalla critica biblica moderna e contemporanea.
I Vangeli non vennero redatti dai loro presunti autori -apostoli che conobbero Gesù- ma molti decenni dopo, da comunità cristiane. Essi consistono in gran parte in invenzioni e sono pieni di contraddizioni gli uni con gli altri: «Ognuno di loro infatti scrisse il racconto sulla passione non in modo concorde, ma in modo assolutamente differente» (testo n. 15; p. 203). Non soltanto la passione ma molte altre notizie sono contraddittorie, come ad esempio le genealogia di Maria e di Giuseppe. Gli stessi detti di Gesù sono tra di loro in contraddizione, come quando -ed è un solo esempio tra i tanti- a chi mugugnava perché una donna avesse cosparso il Maestro di preziosi profumi che si potevano vendere a favore dei poveri, Gesù rispose «di non essere con loro per sempre, lui che altrove assicura (i discepoli) dicendo loro: ‘Io sarò con voi fino alla fine del mondo’. Così, addolorato per l’episodio dell’olio profumato, negò che sarebbe stato con loro per sempre’» (61; 325).
In generale, quella dei nazareni è «una fede irrazionale e non sottoposta ad esame» (1; 185), come si vede con chiarezza dalla credenza in un Dio che può distruggere le leggi della logica, della fisica e del buon senso. Porfirio invita infatti a riflettere su «quanto sarebbe assolutamente illogico se il demiurgo lasciasse che il cielo, di cui nessuno potè pensare una bellezza più divina venisse distrutto, le stelle cadessero e la terra perisse, e invece facesse risorgere i corpi putrefatti e guasti degli uomini, alcuni di persone dall’aspetto curato, altri orribili prima di morire, sproporzionati e dall’aspetto terribilmente nauseante» (94; 387). Resurrezione dei corpi che rappresenta una delle maggiori assurdità che si possano immaginare: «Infatti spesso (è capitato) che molti morirono in mare e i (loro) corpi furono mangiati dai pesci, altri furono divorati dalle belve e dagli uccelli; com’è dunque possibile che i loro corpi tornino indietro?» (n. 94, 385).
Ma sono gli stessi cristiani a non credere per primi a tali assurdità. Tanto è vero che la loro presunta fede non è in grado né di spostare le montagne -eppure per farlo basterebbe, assicura il Maestro, avere ‘fede quanto un granello di senape’- né di guarire i malati né di assumere veleni mortali senza subirne alcun danno, come assicura sempre Gesù, per il quale proprio questi sono segni certi della fede. E tuttavia, commenta Porfirio, nessun cristiano e neppure alcun vescovo si è mai sottoposto a tale prova.
I cristiani divennero poi ben presto, come ammise lo stesso Girolamo, simili a degli esattori delle tasse, chiedendo con insistenza denaro a tutti. Tanto che furono frequenti i casi di donne -soprattutto ricche vedove- che furono convinte «a distribuire ai poveri tutta la ricchezza e le sostanze che (esse) avevano e, ridottesi all’indigenza, a mendicare; dalla libertà (economica) passarono ad una sconveniente e misera condizione di accattonaggio, dalla felicità piombarono in una condizione drammatica» (58; 321).
Chiede poi ragionevolmente Porfirio: «Perché colui che fu chiamato il Salvatore, si è nascosto per così tanti secoli» negando in questo modo la salvezza a milioni e milioni di persone vissute prima della sua comparsa in Palestina in un certo momento del tempo (82;1)? E perché Gesù dopo la presunta resurrezione apparve a pochissime e sconosciute persone «mentre aveva precisamente dichiarato al sommo sacerdote dei Giudei dicendo: ‘Vedrete il figlio dell’uomo seduto alla destra di Dio che viene sulle nuvole’. Se infatti fosse apparso a uomini illustri, tutti grazie a costoro, gli avrebbero creduto e nessuno dei giudici li avrebbe puniti come inventori di favole assurde; infatti non piace in alcun modo né a Dio, ma nemmeno ad un uomo intelligente che molte persone per causa sua siano esposte alle punizioni più terribili» (64; 329). Se davvero fosse stato il figlio dell’Altissimo, «Cristo avrebbe dovuto, durante la sua discesa, oppure dopo la sua morte o in altra occasione, apparire a gran parte della gente in modo impressionante (tramite miracoli, come Dio)» (sintesi di von Harnack dei frammenti 65 con nr. 48, 64; p 95).
In realtà questo rabbi un po’ troppo convinto della propria autorità ha generato una storia di massacri e di dolori, perpetrati dai suoi seguaci contro chi non condivideva un fanatismo simile a quello degli attuali esponenti dell’Isis, come molte testimonianze storiche confermano, al di là di Porfirio. Un solo caso: il massacro attuato nel 415 da una banda di criminali cristiani contro una donna sola, indifesa -Ipazia di Alessandra- su istigazione del vescovo Cirillo, poi proclamato santo e dottore della Chiesa. La verità è che Gesù il Nazareno è un uomo «per la cui venerazione e fede una moltitudine di uomini viene inumanamente uccisa, mentre la (sua) attesa risurrezione e venuta rimane ignota» (36; 245). Un uomo che chiede più volte al suo Dio di risparmiargli la morte e che al momento di spirare lo accusa di averlo abbandonato. Parole le quali «sono indegne non solo del figlio di Dio, ma anche di un uomo saggio che disprezza la morte» (62; 325).
Le risposte dei cristiani a queste semplici e sensate osservazioni consistono nell’insultare in vario modo chi le formula e nell’arrampicarsi sugli specchi, come fa Girolamo a proposito della questione delle montagne che si spostano: «In coincidenza dell’apparizione nel mondo della fede cristiana, si verificarono in gran numero eventi prodigiosi e straordinari, la maggior parte dei quali non sono stati riportati, in quanto superavano le capacità di comprensione degli uomini», continuando poi con il dire che le montagne da spostare sono una immagine del diavolo (nota del curatore, p. 459).
Ecco l’unica risposta che i dotti cristiani sono capaci di dare: interpretare i Vangeli e i detti di Gesù in chiave totalmente allegorica, salvo poi tornare alla lettera del testo quando a loro conviene. Ma l’allegoria è capace di dire tutto e il contrario di tutto, come -ad esempio- che in base al testo dell’Iliade Ettore raffigura il diavolo e Achille prefigura il Cristo vincitore.
È penoso che la ricca e sempre lucida cultura dei Greci sia stata costretta a confrontarsi con questo insieme di favole esagerate, neppure buone per dei bambini. E questo per ragioni in primo luogo politiche. L’imperatore Costantino, che per primo ordinò il rogo dei libri, abbracciò la fede cristiana anche per una motivazione semplicemente personale e giudiziaria. Infatti egli si era macchiato «del duplice delitto contro il primogenito Crispo e la moglie Fausta [che uccise facendola bollire in una vasca d’acqua], sospettati di aver avuto una relazione sentimentale» e, «non avendo ottenuto il perdono da nessuna religione presente nell’impero di allora per una simile nefandezza, si rivolge al cristianesimo», il quale lo assolve e lo accoglie tra i propri adepti (nota del curatore, pp. 514-515). Non solo: lo proclama «eguale agli apostoli» (Nixey, Nel nome della Croce, cit., p. 54).
Un nemico di Porfirio, Agostino di Ippona, è ancora abbastanza greco da riconoscerlo in ogni caso come «philosophus nobilis, magnus gentilium philosophus, doctissimus philosophorum quamvis Christianorum acerrimus inimicus» (De civitate Dei, XIX, 22, qui a p.162), filosofo nobile e dotto nonostante fosse acerrimo nemico dei cristiani.
Quei cristiani e quei padri della Chiesa a proposito dei quali Nietzsche può giustamente dire che «ci si ingannerebbe completamente se si supponesse un qualsiasi difetto d’intelligenza nelle guide del movimento cristiano -oh, se essi sono accorti, accorti fino alla santità, questi signori padri della Chiesa!», con la capacità che ebbero di assorbire la filosofia greca -affrancandosi così dalla natura settaria del cristianesimo delle origini- per metterla al servizio delle patetiche e pericolose invenzioni dottrinarie, etiche e politiche della fede dei nazareni (L’Anticristo, Adelphi, p. 256).
I cosiddetti padri della Chiesa sono stati fomentatori di crimini e hanno contribuito alla distruzione della razionalità platonica e aristotelica, da loro giudicata diabolica. Sia come vittime sia come carnefici, hanno dato ragione a Zarathustra, per il quale «il sangue è il peggior testimone della verità; il sangue avvelena anche la dottrina più pura e la trasforma in follia e odio dei cuori» (Così parlò Zarathustra, II parte, ‘Dei preti’). Porfirio e gli ultimi filosofi pagani sono rimasti indenni da tali follie, da tanto odio.