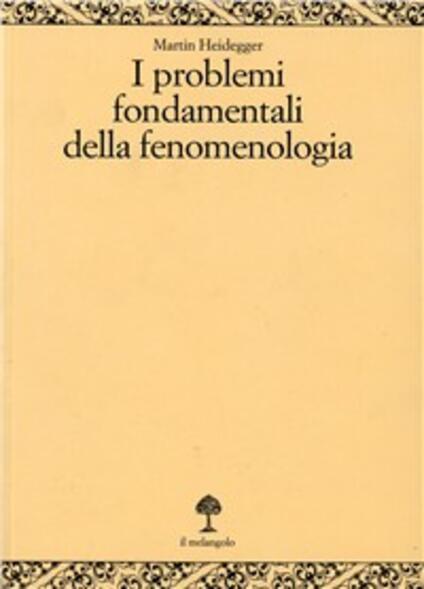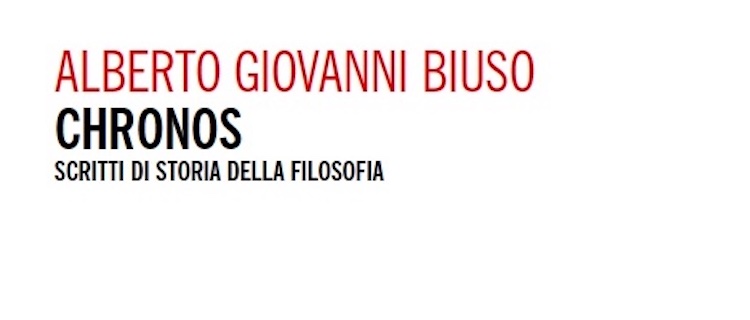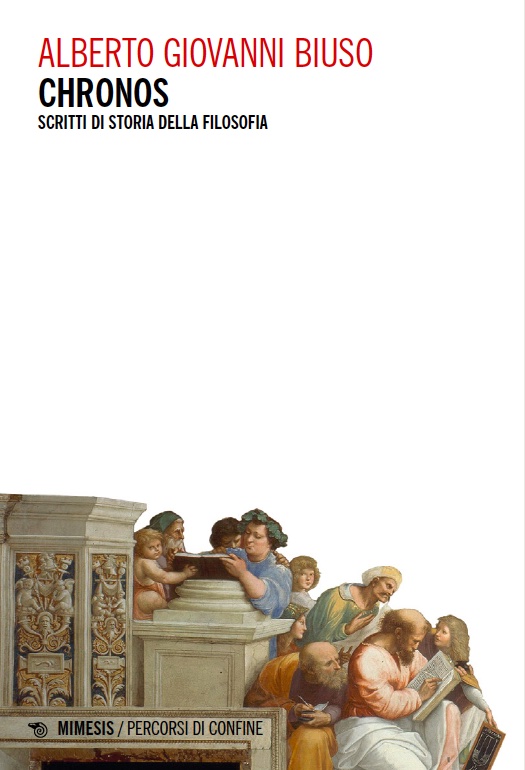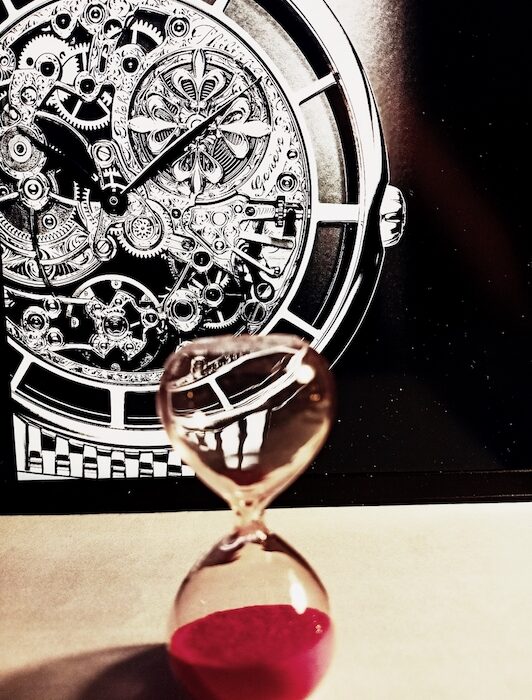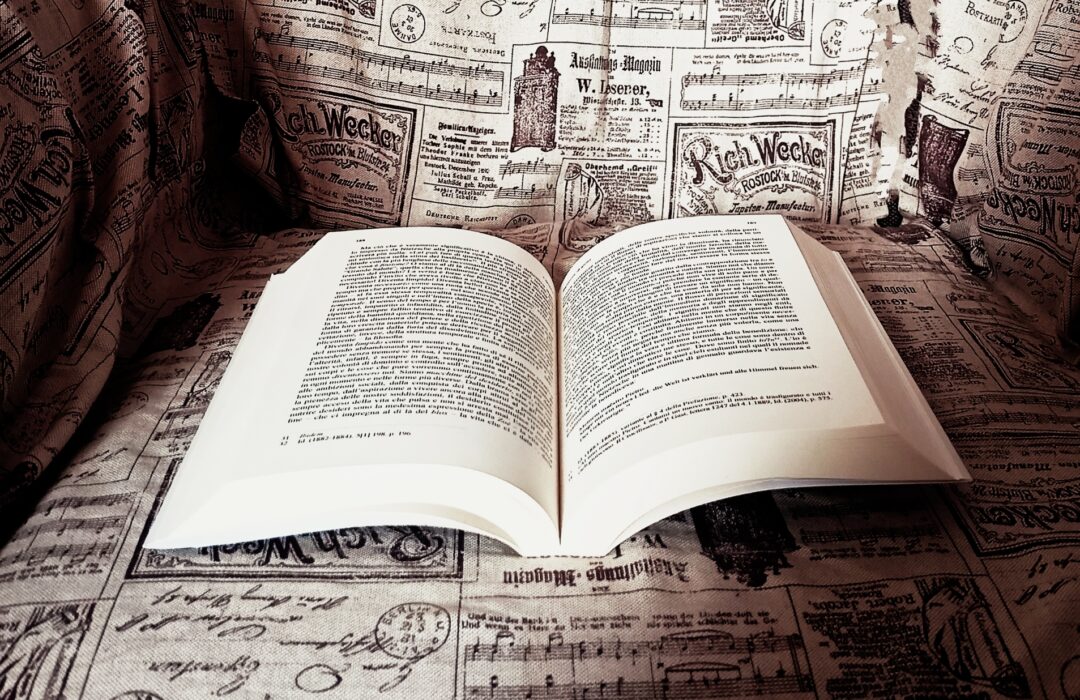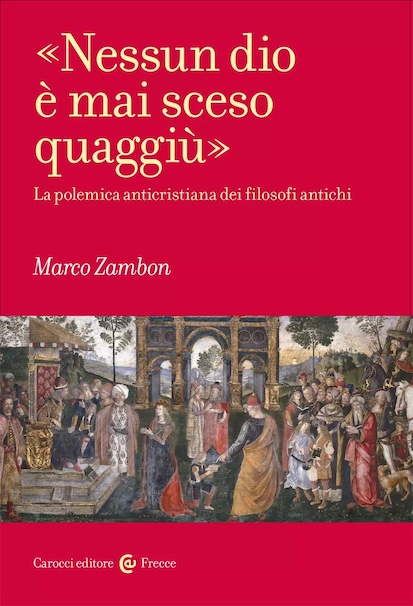
L’insieme degli scritti con i quali filosofi come Celso, Porfirio, Giuliano, Ierocle criticarono e confutarono la demens superstitio -‘l’irrazionale superstizione’– dei cristiani ci è noto quasi soltanto dalle citazioni, dalle polemiche, dalle refutazioni e manipolazioni dei cristiani stessi, poiché i testi originali furono distrutti e bruciati in modo sistematico dai loro avversari.
È questo il dato al centro della ricostruzione accurata, anche se a volte ripetitiva, che Marco Zambon in «Nessun dio è mai sceso quaggiù». La polemica anticristiana dei filosofi antichi (Carocci, 2019) conduce del tentativo attuato dai filosofi antichi, nell’età che va all’incirca da Marco Aurelio a Giustiniano (II-VI secolo), di mostrare l’incompatibilità tra il loro mondo e la fede dei cristiani.
Filosofia e fede cristiana sono inconciliabili per tre ragioni fondamentali.
La prima concerne lo statuto della verità, che per la filosofia è una ricerca sempre aperta, svolta a partire dalla convergenza tra ciò che si osserva del mondo – il dato empirico e quello fenomenologico – e la riflessione razionale che viene condotta su di esso. Per i cristiani, invece, la verità è un dato della rivelazione al quale si accede con la fede e che rimane sempre identico, incontestabile, fuori da ogni discussione e argomentazione.
La seconda ragione riguarda lo statuto del divino, che per la filosofia è plurale e molteplice, mentre per il cristianesimo e le altre religioni del Libro è un’identità monoteistica che respinge da sé ogni differenza.
La terza ragione si riferisce allo statuto dell’umano, il quale per la filosofia ha nel mondo una specificità che non diventa mai privilegio ontologico e superiorità assiologica. Privilegio e superiorità che conducono a immaginare un dio che diventa egli stesso uomo e che persino muore tra sofferenze atroci per salvare gli umani da lui stesso condannati. Il «carattere spiccatamente antropomorfo e l’irrazionalità del loro Dio […] indicavano la natura non filosofica della religione dei cristiani» (p. 257), alla quale Celso oppone un atteggiamento ancora una volta plurale e che oggi definiremmo animalista. Il filosofo infatti,
polemizzava contro l’antropocentrismo dei cristiani, partendo dal principio che ‘le cose tutte non sono state generate per gli uomini più che per gli animali privi di ragione’ (Cels. IV 74). Egli si sforzava, perciò, di mostrare la superiorità naturale degli animali rispetto all’uomo (dal momento che non hanno bisogno di coltivare la terra per nutrirsi, né servono loro strumenti per attaccare gli uomini e divorarli; Cels. IV 76, 78-79) e il fatto che anch’essi avessero una complessa organizzazione sociale, conoscessero le scienze, praticassero il culto degli dèi (Cels. IV 81. 83-85. 88. 98 (p. 315).
Ai tre elementi fondamentali concernenti la verità, il divino e l’umano, si aggiungeva l’inaccettabile rozzezza concettuale e stilistica del linguaggio biblico, della quale molti tra gli stessi apologeti cristiani erano consapevoli, costituendo anche «per loro un serio ostacolo e un motivo di imbarazzo» (p. 184), che cercavano di superare con una lettura radicalmente allegorica della Bibbia; lettura della quale il maggiore sostenitore fu Origene.
Questi elementi di dottrina si coniugavano con i comportamenti pratici dei cristiani, i quali in generale «negavano ogni dignità agli dèi visibili, gli astri, e però veneravano un cadavere» (p. 99) e lo strumento che era servito al suo supplizio, la croce. In particolare, poi, i monaci, descritti dai cronachisti dell’epoca ricordano l’abbigliamento, le pratiche e la violenza dagli attuali militanti dell’Isis, ai quali li accomuna la certezza di detenere l’unica verità e una fede salvifica. Eunopio, ad esempio, «dopo aver narrato la distruzione del serapeo di Alessandria, compiuta nel 391 sotto il patriarcato di Teofilo, ‘capo dei maledetti’ (V. soph. VI 11, 2), descrive in questi termini l’occupazione del sito da parte di monaci cristiani:
6 In seguito, introdussero in quei luoghi sacri i cosiddetti ‘monaci’; uomini, per quel che riguarda l’aspetto, ma, quanto alla loro vita, maiali, che apertamente tolleravano e compivano innumerevoli cose malvagie e indescrivibili. Eppure questa pareva loro pietà: disprezzare il divino. 7. Allora, infatti, aveva un potere tirannico chiunque indossasse un abito nero ed esercitasse in pubblico una condotta indegna
(Eunopio, V. soph. VI 11, 6-7; p. 100).
L’atteggiamento violento dei cristiani verso i loro avversari e verso i beni altrui si manifestava anche e appunto nella «violenza con la quale i monaci s’impadronivano delle terre dei contadini, dichiarandole sacre e saccheggiandole» (101).
La violenza appare talmente intrinseca alle fedi monoteistiche da esprimersi nella violenza anche verso se stessi, come risulta chiaro dalla questione delle persecuzioni verso i cristiani, le quali – tranne in pochi e circoscritti intervalli temporali – furono in realtà una invenzione degli apologeti e della storiografia cristiana.
Le leggi romane e i loro giudici furono infatti per lo più riluttanti a punire i cristiani. L’imperatore Traiano ordinò che essi non venissero cercati e non si desse seguito a denunce anonime nei loro confronti. Anche quando arrivavano a processo, le condizioni per andare assolti erano assai miti. Come molti altri, il proconsole Saturnino «chiedeva ai cristiani non di rinunciare alle proprie convinzioni, bensì di giurare ‘per il genio del nostro signore, l’imperatore’ e di offrire ‘suppliche per la sua salute’ [Act. Mart. Cil. 1-14]; una cosa che gli sembrava del tutto ragionevole, compatibile con una sana e semplice pietà religiosa e con i doveri di un cittadino romano» (72). La risposta dei cristiani era per lo più pervasa di una fede millenaristica che li rendeva certi della imminente fine del mondo e li induceva quindi a cercare essi stessi la condanna a morte. A confermarlo è un testimone del tutto affidabile, uno dei più tenaci difensori del cristianesimo, Tertulliano, il quale scrive che «mentre Arrio Antonino in Asia li perseguitava duramente, tutti i cristiani di quella città, radunatisi insieme, si presentarono al suo tribunale. Egli allora, dopo averne fatti portare alcuni a morte, disse agli altri: ‘Miserabili, se volete morire, avete i burroni oppure impiccatevi!’ (Tert. Ad Scap. V 1)» (p. 97).
In generale, «prima di Costantino, i cristiani non sono vissuti in uno stato di persecuzione generalizzata; anzi, hanno potuto contare per lo più su un’ampia tolleranza di fatto da parte delle autorità» (359). Una volta arrivati al potere, il loro atteggiamento verso quanti continuavano a rimanere fedeli all’antica religione fu invece molto violento: distruzione sistematica dei templi e degli altri luoghi di culto pagani, incendio delle biblioteche che conservavano libri e documenti di culture millenarie, omicidi individuali e stragi collettive (cfr. Catherine Nixey, Nel nome della croce. La distruzione cristiana del mondo classico, Bollati Boringhieri, 2018)
Violenza che divenne atto giuridico repressivo con l’editto emanato nel 380 a Tessalonica da Graziano, Valentiniano e Teodosio: «Ordiniamo che coloro che seguono questa legge siano compresi sotto il nome di cristiani cattolici, mentre tutti gli altri, considerandoli dissennati e folli, ordiniamo che sopportino l’infamia della loro dottrina eretica e le loro conventicole non ricevano il nome di Chiese; essi devono essere puniti anzitutto dalla vendetta divina, poi anche dalla pena comminata dalla nostra iniziativa, ispirata dalla volontà celeste (Cod. Theod. CVI 1,2 = CIC Cod. I, 1,1)» (p. 418). A questo editto si aggiunse la costituzione dell’8 novembre 392 con la quale Teodosio «vietava il culto pagano in qualsiasi forma su tutto il territorio dell’Impero (Cod. Theod. XVI 10, 10-12)» (p. 420). Violenza rivolta non soltanto ai pagani ma a chiunque non seguisse il credo cristiano come era stato stabilito nel 325 al Concilio di Nicea.
Quando Celso scrive che «‘nessun dio, o giudei e cristiani, e nessun figlio di dio è mai sceso, né potrebbe scendere quaggiù’ (Orig. Contra Celsum [Cels.] V 2)» (p. 13), questo significa anche che nessuna fede assoluta nella parola e negli insegnamenti di un uomo – tanto più se quest’uomo si presenta come un dio – può esimere il cammino umano dalla fatica del comprendere e del costruirsi. Diventare umani implica non l’accoglimento acritico «di un intervento proveniente dall’esterno, ma l’attuazione, faticosa e progressiva, della propria vera natura da parte di un’anima a ciò preparata» (296).
È anche per questo che la filosofia riemerge sempre dalle macerie delle certezze fideistiche, perché il bisogno e l’inquietudine della ricerca appartengono alla natura stessa dell’animale umano.