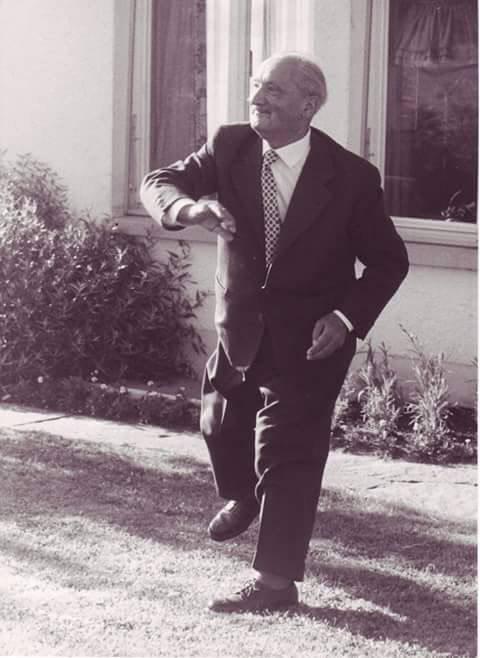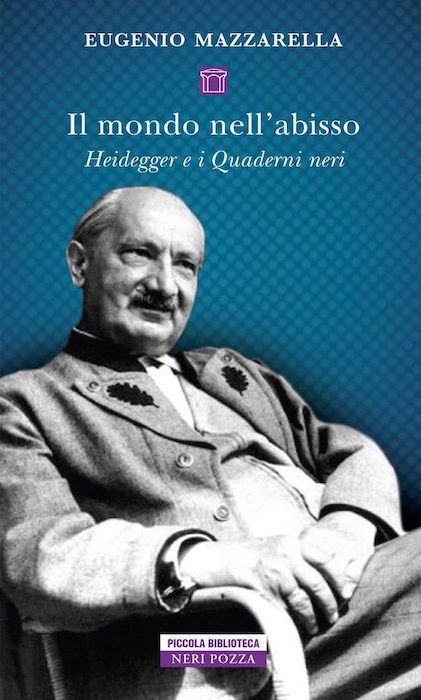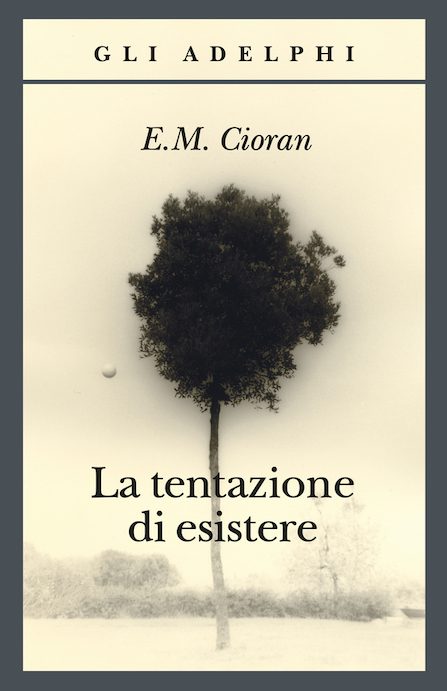
«Risorsa infinita, perpetua festa»
Emil M. Cioran
La tentazione di esistere
(La tentation d’exister, Gallimard 1956)
Trad. di Lauro Colasanti e Carlo Laurenti
Adelphi, 2022
Pagine 215
Segno di contraddizione, gioco di contraddizione, è la riflessione di Emil Cioran. A partire dal rimprovero mosso a chi abbandona la propria lingua d’origine – «Chi rinnega la propria lingua per adottarne un’altra, cambia d’identità, anzi di delusioni» (p. 57) – e l’averla appunto abbandonata. Proseguendo con un’articolata e ampia condanna dello scrivere scritta da chi ha fatto della scrittura la propria esistenza quotidiana. Per arrivare infine alla esatta denuncia rivolta alla filosofia moderna di aver instaurato «la superstizione dell’Io» (21) e imperniare poi l’intera propria meditazione su una soggettività angosciata, depressa, malinconica, triste; ammettendo, in riferimento agli individui e alle civiltà, di essere diventato «il fanatico di una carogna» (24).
E tuttavia la lucidità di Cioran va di slancio oltre le proprie debolezze e contraddizioni e coglie con sintetica efficacia alcuni dei momenti chiave del contemporaneo e della storia.
Il tradimento di molti intellettuali, ad esempio, che preferiscono le catene dell’illusione alle «peregrinazioni della Conoscenza» (37), che scelgono il conforto di una sinecura al compito della libertà. Intellettuali che, allo stesso modo delle masse ma con una responsabilità che le masse non hanno, si fanno corifei di una filosofia della storia nata dal convergere della Provvidenza cristiana e del Progresso borghese con le vittorie coloniali dei conquistadores. Intellettuali che, allo stesso modo delle masse ma con una responsabilità che le masse non hanno, si fanno in ogni loro riga e parola difensori del messianismo statunitense, di un’America che «si erge di fronte al mondo come un nulla impetuoso, come una fatalità priva di sostanza […] un mostro di superficialità» (33). Intellettuali che, allo stesso modo delle masse ma con una responsabilità che le masse non hanno, abbandonano lo spirito critico e scettico che ha caratterizzato la filosofia europea da Socrate in avanti per farsi portatori anch’essi, al modo dei preti, «di una verità semplice, di una risposta che li liberi dai propri interrogativi, di un vangelo, di una tomba» (38), come quella che ha trasformato la scienza in una prospettiva «minacciosa, fonte di spavento» (190) e – con la vicenda dell’epidemia Covid – in una pratica di violenza collettiva poiché «chi trema sogna di far tremare gli altri, chi vive nello spavento finisce nella ferocia» (173).
A fondamento di queste e altre tristezze sta anche per Cioran la fine del mondo pagano, così efficacemente richiamato: «Dove sono la nostra sensibilità innica, l’ebbrezza delle origini, l’alba dei nostri stupori? Gettiamoci ai piedi della Pizia, ritorniamo alle nostre antiche aspirazioni: filosofia dei momenti unici, sola filosofia» (154). La fine del paganesimo è stata causata e affrettata (è la stessa motivazione che ne dà Nietzsche) da una crisi interna di quel mondo che aveva perduto fiducia, ironia e sorriso – il sorriso dei κοῦροι – ma che fu comunque il cristianesimo a uccidere. Alla gioia e alla tragedia del mito greco il cristianesimo sostituì «una mitologia di schiavi» che, ad esempio nell’Apocalisse, si mostra come «vendetta, bile e avvenire malsano» (89) e nel latino cristiano trasforma la bella «lingua di Tacito» in una parlata «deformata, banalizzata, costretta a subire le farneticazioni sulla Trinità!» (118).
Radice del cristianesimo è naturalmente l’Antico Testamento, è Yahweh, un dio «attaccabrighe, rozzo, lunatico, verboso», che «poteva al massimo soddisfare le necessità di una tribù», un dio interpretato da Cioran in una chiave anche gnostica che ne fa «un usurpatore che subodorando il pericolo teme per il suo regno e terrorizza i suoi sudditi» (72). A diffondere il culto di questo demiurgo usurpatore fu Paolo di Tarso, la cui teologia è «un’orgia di antropomorfismo» (160).
Su Paolo, e sul suo prosecutore Lutero, Cioran riprende le analisi e anche il linguaggio di Nietzsche, descrivendo la patristica che da Paolo nacque come un mondo di nemici delle Muse, di «forsennati che ancora oggi ci ispirano un panico misto ad avversione. Il paganesimo li trattò con ironia, arma inoffensiva, troppo nobile per sottomettere un’orda restia alle sfumature. Il delicato che ragiona non può misurarsi con il beota che prega. Irrigidito nelle vette del disprezzo e del sorriso, soccomberà al primo assalto» (163). Per quanto riguarda Martin Lutero, «questo Rabelais dell’angoscia era più adatto di chiunque altro a rinvigorire un cristianesimo sempre più debilitato e slavato» (167).
A proposito del plesso ebraismo-cristianesimo, Cioran può contribuire a intendere più correttamente le pagine dei Taccuini neri di Heidegger dedicati al rapporto tra cultura ebraica e desertificazione. Si tratta infatti di un dato antropologico che ogni analisi priva di pregiudizi non può che confermare. Scrive infatti Cioran che non bisogna dimenticare che gli ebrei «furono cittadini del deserto, che lo custodiscono ancora in se stessi come loro spazio intimo, e lo perpetuano attraverso la storia» (73); e aggiunge una interessante osservazione etnologica sui ghetti disseminati in Europa, visitando i quali non si può «fare a meno di notare che la vegetazione ne era assente, che nulla vi fioriva, che tutto era secco e desolato: isolotto bizzarro, piccolo universo senza radici» (73). L’equiparazione tra ebraismo e desertificazione indica questo semplice dato storico, che soltanto malafede e pregiudizio possono trasformare in altro.
Tornando alle questioni metafisiche, l’elemento più debole del pensiero e dell’esperienza di Cioran è la sua avversione contro il tempo. Avversione però anch’essa contraddittoria poiché se da un lato lo scrittore auspica una cura di eternità che disintossichi dal divenire, ammette «tuttavia che noi siamo tempo, che produciamo tempo» (25).
Tempo che è l’altro nome del morire e del nulla e dunque della sostanza di cui siamo fatti. La morte è insieme una «situazione limite» e un «dato immediato» (205). Il Nulla, che Cioran scrive appunto in maiuscolo, è la confortevole situazione del «non essere niente – risorsa infinita, perpetua festa» (197) che libera dalla tentazione di esistere.