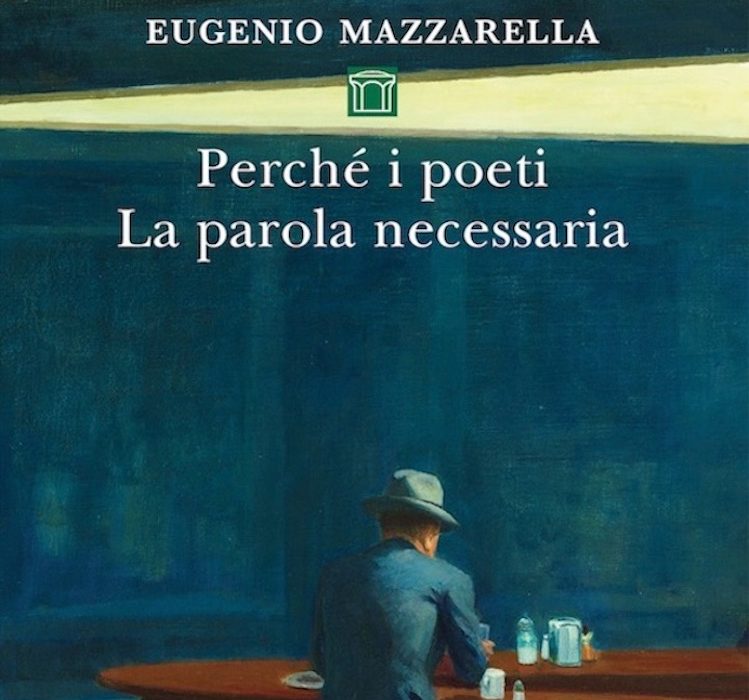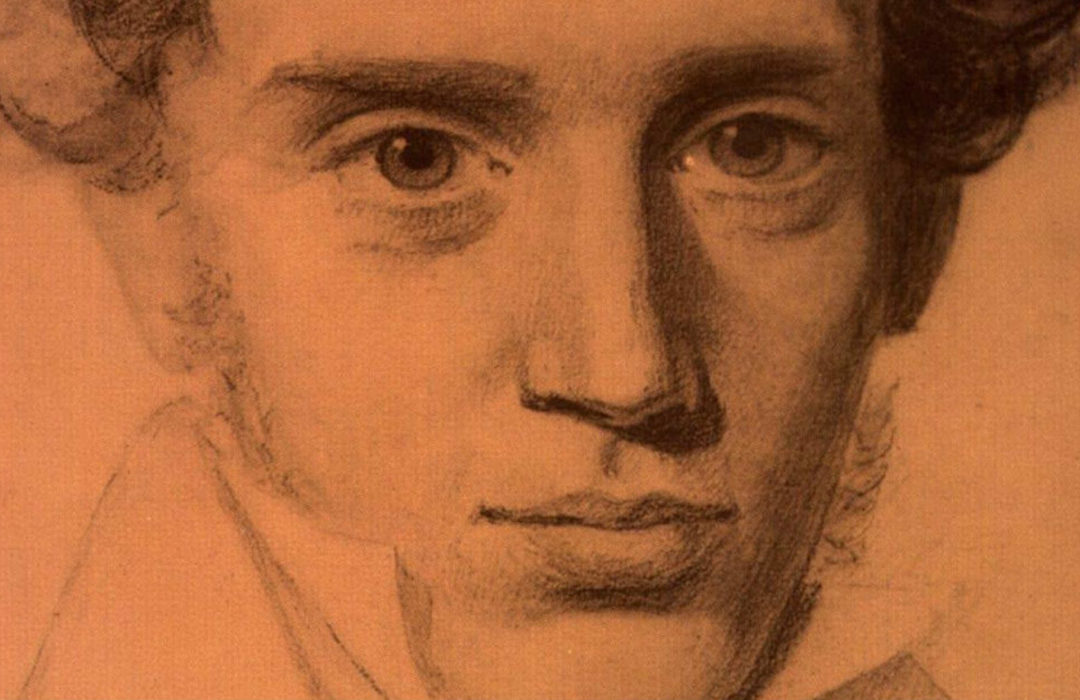Iddu
di Antonio Piazza e Fabio Grassadonia
Italia, 2024
Con: Elio Germano (Matteo), Toni Servillo (Catello Palumbo), Daniela Marra (Rita Mancuso), Fausto Russo Alesi (Emilio Schiavon), Barbara Bobulova (Lucia Russo), Antonia Truppo (Stefania), Betti Pedrazzi (Elvira)
Trailer del film
«Mio padre è morto tra le pecore e io vivo come un topo». Questo pensa e dice con amarezza Matteo, capomafia di una imprecisata zona della Sicilia. Devotissimo al padre Gaetano, ne assume alla morte eredità e ruolo, vivendo per decenni come latitante in una abitazione del suo stesso paese e da lì continuando a dare ordini di violenza e di morte, pur vivendo appunto come «u suggi». Tra le lettere e comunicazioni, assume un ruolo centrale il rapporto con Catello Palumbo, suo padrino di cresima ed ex sindaco del paese. Tornato da sei anni di detenzione, Palumbo viene costretto dai servizi segreti a partecipare a un’operazione il cui scopo sembra l’arresto di Matteo.
Sembra. Tutto è cangiante e simbolico nel cinema di Piazza e Grassadonia. Un cinema intessuto della deformazione dello spazio, del tempo, della memoria, delle vicende. I silenzi e la desolazione di Salvo (2012); la tenerezza e la crudeltà di Sicilian Ghost Story (2017) si trasformano nel grottesco di Iddu, un’opera che scende scende negli abissi insensati dell’esistenza siciliana, tra finti vivi, vivi a metà, morituri i quali «vivono giorni contati di vita inutile», come ancora una volta Matteo afferma. Questo criminale è un lettore attento della Bibbia e in particolare del Qohélet o l’Ecclesiaste che legge nella edizione Einaudi tradotta da Guido Ceronetti.
E tutto il film è pervaso della dimensione biblica, di citazioni dall’antico testamento, di quello Havèl havalím, vanità delle vanità o – come Ceronetti traduce- «fumo di fumi / Polvere di polveri / tutto fumo / polvere» (Qohélet o l’Ecclesiaste, Einaudi 1988, 1,2). Davvero la vita dei mafiosi che sparano e di quelli che decidono a chi e perché sparare è «orrore / Perché per me è tutto male / Qualsiasi cosa si faccia sotto il sole (2.17).
In questo film, come nel Qohélet, la donna è «amara più che la morte» (7.26) e il mangiare-bere-godere è l’«unico bene dell’uomo» (2.24). Se qualcosa si vuol pur capire, è meglio non attribuire colpa al mondo o al dio e comprendere, invece, che «dal cuore dei figli d’uomo / Trabocca il male» (9.3), che se una sapienza è possibile essa sta nel comprendere l’insignificanza degli umani e il loro limite in un universo perfetto nella sua indifferenza. Certo, forse al crescere della conoscenza «più grave si fa il tormento» (1.18) e tuttavia soltanto uno sforzo di sapienza può diradare un poco le tenebre del mondo. Quella sapienza che è più forte delle armi e di ogni semplice violenza, sapienza che è anch’essa un’ombra ma che «illumina il viso» (8.1) ed è «la vita di chi vive per lei» (7.12).
Nella sua ignoranza e rozzezza Matteo percepisce e sente la verità di ciò che legge nel Qohélet, soprattutto percepisce e sente che «felice» è chi «ancora non è stato», ancora non è nato e meglio sarebbe che non nascesse (4.3).
Il finale della storia conferma che latitanze di decenni dei mafiosi sono possibili soltanto perché le istituzioni della Repubblica non costituiscono l’altro di Cosa Nostra ma sono una loro espressione. Per chi conosca anche solo da lontano e per fugaci occasioni qualche mafioso, appare del tutto evidente che si tratta di persone inconsistenti, rozze, quasi analfabete, di pecorai arricchiti, di individui senza strumenti che non siano un’arma in mano. Persone che la forza militare e giuridica di uno Stato contemporaneo non avrebbe nessuna difficoltà a spazzare via. Se invece costoro controllano ancora territori ed economie è perché godono della protezione di imprenditori, forze dell’ordine, magistrati, presidenti di amministrazioni, presidenti del consiglio, presidenti della repubblica. Soggetti, questi ultimi, che non sono l’altro della mafia ma sono la mafia, come la vicenda della cosiddetta «trattativa» ha confermato.
Disperante da pensare e da dire? Forse. Ma non per un siciliano, che tutto questo lo vede – se lo vuole vedere – da quando è nato. E io lo vedo. Meravigliosa l’interpretazione di Elio Germano come Matteo ed è sempre una gioia vedere recitare Toni Servillo, qui nei panni del sindaco complice e traditore del capomafia.
A Matteo il padre aveva affidato un «pupo», un antico bronzo greco, raccomandandogli di non venderlo mai, di tenerlo sempre con sé. Simbolo, forse, di ciò che l’Isola è stata nei millenni che hanno eretto i templi agrigentini, Segesta, Selinunte, luoghi dove la mafia di Sicilia è oggi ancora padrona. Emblema di una Sicilia libera certo non dal male (questo da nessuna parte è possibile) ma da un male così rozzo, così inutilmente feroce, così insipiente, come quello di Cosa Nostra.