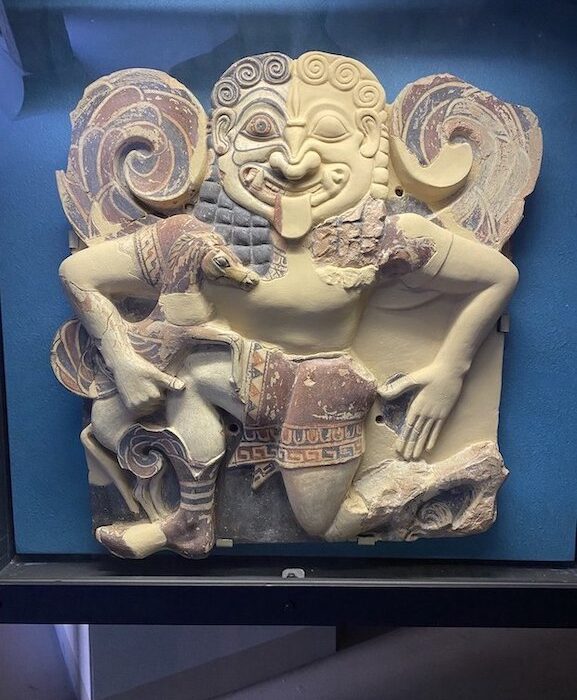Il sintetico documento che segnalo, autorizzato dall’autrice, spiega più di molte e lunghe analisi che cosa sia diventata l’Università italiana. Si tratta di una lettera dolorosa, intrisa di lucida dignità, di capacità di pensare e di capire. Capire che cosa? Alcune caratteristiche di fondo della società italiana contemporanea, così riassumibili.
-Il tramonto dell’Università come ascensore sociale. Il ‘110 e lode’ regalato anche ai tanti che non lo meritano e, in generale, i certificati di laurea diventati la conseguenza del semplice iscriversi a un corso universitario hanno, come è ovvio, tolto valore sostanziale al titolo di studio.
-La tagliola che immediatamente dopo il regalo avvelenato della laurea scatta e impedisce alla più parte dei laureati di proseguire il loro percorso formativo e/o professionale. Per chi è interessato all’insegnamento, il labirinto normativo ostacola in modo spesso insormontabile la realizzazione delle proprie aspirazioni.
-La tipologia di bando della quale parla questa lettera mostra con evidenza che in Italia è stato reintrodotto il criterio del censo, l’ottocentesco criterio censitario, per il quale soltanto i rampolli delle famiglie agiate possono aspirare a realizzare le proprie passioni e talenti, gli altri devono accontentarsi. La reintroduzione del criterio censitario è voluta e favorita dal decisore politico (di ogni area partitica e ideologica), dai pedagogisti e didatticisti, dalla onnipotente burocrazia ministeriale. Rettori e direttori generali applicano tali norme con più o meno zelo ai loro Atenei; in ogni caso la cifra minima da richiedere è per legge di 1500 € e il numero dei posti messi a bando da ogni Università è irrisorio rispetto a quello dei laureati.
-Il cospicuo denaro che viene chiesto ai giovani cittadini italiani e alle loro famiglie non dà alcuna garanzia sul loro futuro ma serve semplicemente ad accedere ai concorsi per l’insegnamento. Che per accedere a tali concorsi si debbano aggiungere alle competenze acquisite durante gli anni universitari sui contenuti delle proprie discipline ore e ore di indottrinamento sulle tecnologie didattiche – presentate immancabilmente come ‘nuove’ ma in realtà assai vecchie, obsolete e definite con l’asettica formula «60 CFU, Crediti Formativi Universitari» (si noti il linguaggio bancario) – è il risultato più catastrofico dell’occupazione dei ministeri della scuola e dell’università da parte della corporazione dei didatticisti, vale a dire di coloro che per lo più non sanno insegnare ma pretendono di dire agli altri come si fa (ne conosco personalmente numerosi).
-La necessità di aggiungere alle spese per l’abilitazione quelle per l’ottenimento di certificazioni linguistiche di fatto ormai obbligatorie se si vuole racimolare qualche punto in più nelle graduatorie. Il costo medio di tali certificazioni è 500 €, che possono diventare 800/1000 se si accoglie la proposta di alcuni enti certificatori di ‘certificare’ anche senza svolgere le prove previste (pratica ovviamente illegale ma diffusa).
-Il patetico nascondimento di questa sostanziale discriminazione socio-economica mediante una ultrasensibilità linguistica, che nella premessa fa dire: «Laddove in questo documento, unicamente a scopo di semplificazione, è utilizzato il genere grammaticale maschile, la forma è da intendersi riferita in maniera inclusiva a tutte le persone interessate dalla procedura di ammissione». Tipico caso, normale caso, nel quale il politicamente corretto contribuisce a giustificare l’iniquità, ne è complice attivo.
La lettera è stata spedita il 27 maggio 2024 al rettore e al Direttore generale pro tempore dell’Università di Catania. Il suo oggetto ha come titolo Percorso abilitante su posto comune, tra amarezza e rabbia.
Allego il pdf del bando oggetto della lettera.
==========
Gentile Professore Priolo,
sono una studentessa dell’Università di Catania che ha conseguito la laurea magistrale. Sono stata una studentessa, dovrei più correttamente dire. Le scrivo però da studente per esprimerle la mia amarezza e, se mi consente un sentimento un poco troppo umano, la mia rabbia. Stamattina ho letto il bando relativo ai Percorsi di formazione e abilitazione docenti su posto comune a.a. 2023/2024 (D.R. 2179 24/05/2024). Provo amarezza e rabbia nel leggere procedure che anziché aiutare e sostenere la formazione dei vostri studenti non fanno altro che ostacolarli, affossarli, scoraggiarli.
Vede Professore, a me che il personale di Unict ponga come premessa che il maschile utilizzato nel bando sia neutro ma che la forma è inclusiva non desta alcun sentimento di rammarico, ma che l’università di Catania – la mia casa – chieda a degli studenti il pagamento di costi così esosi a fronte di un numero di posti praticamente simbolico, ridicolo mi lasci dire, questo sì che mi suscita rammarico.
Procedure e requisiti di ammissione sono in contraddizione con il fine per cui il percorso nasce. Se lo scopo è abilitare dei giovani studenti e/o neo-laureati alla attività didattica, vale a dire a un inserimento rigoroso, serio e maturo nel mondo della scuola e dunque del lavoro, non crede che sia un ossimoro chiedere loro una somma così onerosa in partenza? Non crede che uno studente debba essere messo nelle condizioni di diventare un bravo docente e non debba invece essergli chiesto ciò che, si spera, avrà modo di guadagnare con il frutto del suo lavoro? Le graduatorie non saranno stilate sul punteggio – torno dopo sulla questione – raggiunto, mi lasci dire che la lista avverrà sulla base dei conti correnti disponibili a sostenere simili cifre, e quelli che invece dovranno rinunciarvi. E così l’università, che un tempo poteva essere per molti uno strumento di crescita sociale, diventa un luogo adatto, disponibile e ospitale solo per chi ai piani alti già ci abita.
Tralasciando la tassazione prevista e volendo sottopormi all’ennesima lista di raccolta punti da supermercato, si presenta davanti a me una situazione altrettanto sconfortante. E non soltanto per il numero di posti ma perché il punteggio viene calcolato su una conta numerica che praticamente esclude me e molti dei miei colleghi in partenza. Se, poi, posso contare sulle competenze linguistiche, anche quelle partono da un livello elevato ed escludono quindi le certificazioni ‘inferiori’. E così mi ritroverò forse, e quasi certamente, scavalcata da studenti alcuni dei quali avranno acquistato il loro C1 di inglese, e invece l’impegno e lo studio serio, nient’affatto facile, ma sempre svolto con rigore e passione rimarrà segregato nel mio cassetto o tra i miei libri. Potrebbe a questo punto venirmi in aiuto il voto di laurea ma il 110 e lode è diventato un premio donato in beneficio per il solo fatto di essersi iscritti all’università, ciò significa che avere tutti 110 e lode equivale a non possederlo, nessuno.
Questo è il modo in cui l’Università di Catania sta trattando i suoi studenti. Questa è la voce amareggiata e arrabbiata di una studentessa che si trova a non potere nemmeno pensare di presentare domanda per un percorso che dovrebbe aprire le porte del mio futuro e invece me le sbarra in partenza. Non spero di cambiare le cose, non credo che la mia voce sia sufficiente a cambiare le cose. Ma almeno saprò di non essere rimasta in silenzio e a guardare.
==========
Questo articolo è stato pubblicato anche su girodivite.it il 3 giugno 2024.