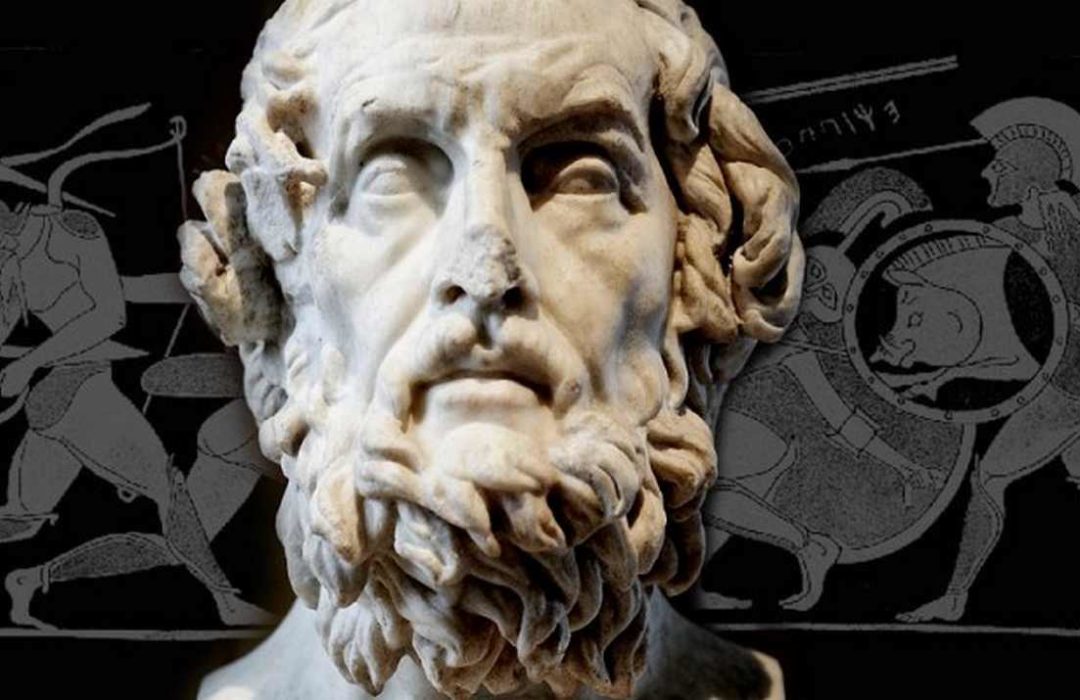Julian Jaynes
Il crollo della mente bicamerale e l’origine della coscienza
Nuova edizione ampliata
(The Origin of Consciousness in the Breakdown of the Bicameral Mind, 1976)
Trad. di Libero Sosio
Adelphi, 2002 (I ed. 1984)
Pagine 582
Uno degli oggetti più enigmatici dell’universo conosciuto non sta in remote distanze siderali, non va cercato negli anfratti più inaccessibili del pianeta. Esso è parte di noi, elemento costitutivo e fondamentale dell’essere che siamo: è il nostro cervello.
Fra le tante domande alle quali non ci sono risposte certe, una delle più importanti riguarda la divisione dell’encefalo in due emisferi: il sinistro che controlla la parte destra del nostro corpo e il destro che ha una funzione inversa. Non si tratta, come è noto, di due parti funzionalmente identiche. Le aree linguistiche sono, ad esempio, contenute nell’emisfero sinistro, che anche per questa ragione è definito come dominante. L’emisfero destro sembra relativamente vuoto dal punto di vista della comunicazione e questo è un fatto da spiegare. È quello che tenta di fare Julian Jaynes ponendosi la domanda se le aree oggi silenziose dell’emisfero destro abbiano avuto in passato una qualche funzione, adesso non più attiva. La risposta è che sì, questa funzione c’era e fu decisiva per tempi lunghissimi: «il linguaggio degli uomini fu localizzato in un solo emisfero per lasciare l’altro libero per il linguaggio degli dèi» (pag. 133), dove con divinità si deve intendere la loro voce, quella voce allucinatoria la cui traccia è ancora così presente ed evidente, per esempio, in molte affermazioni dei dialoghi platonici.
Bicamerali vengono pertanto definite tutte quelle epoche, civiltà, soggetti – dalle culture mesopotamiche e andine sino agli attuali schizofrenici – nei quali «i due emisferi sono in grado di funzionare come se fossero due persone indipendenti, persone che nel periodo bicamerale erano, a mio avviso, l’individuo e il suo dio» (149).
Il libro – davvero affascinante in molti dei suoi passaggi – cerca di fornire tutte le possibili prove a sostegno di tale ipotesi, mediante una ricerca volta in due direzioni: storia, archeologia, letteratura da una parte; psicologia dall’altra. Il testo dell’Iliade rappresenta, da questo punto di vista, la confluenza di entrambe le direzioni proprio perché, al di là del suo valore letterario, si tratta di un documento psicologico di assoluta importanza. E ciò a partire già dal lessico del poema. Come, infatti, confermano gli studi di Bruno Snell e soprattutto di R.B. Onians, i termini con i quali nell’Iliade si designano fenomeni che oggi chiameremmo mentali hanno tutti un significato radicalmente fisico e somatico, a dimostrazione che nella cultura nella quale il poema è nato non esiste nulla che si possa paragonare alla coscienza modernamente intesa.
Nell’Iliade thumos è la risposta adrenalinica e noradrenalinica del corpo a eventi esterni, le phrenes sono in pratica i polmoni, kradie/kardie è ovviamente il cuore, etor è lo stomaco, uno degli organi più legati alla mente attraverso le reazioni immediate di contrazione, spasmi, vomito, crampi, vuoto – appunto – allo stomaco e la psyche costituisce la capacità di respirare e di sanguinare. Non solo: nell’Iliade nessun termine designa la volontà o il libero arbitrio e la stessa parola soma – che venne a significare corpo – in Omero è usata sempre al plurale per designare le “membra morte”, il cadavere come opposto alla psyche che indica un corpo che ancora respira.
È all’interno di tale corpomondo che le voci parlano, ordinano, determinano l’agire e i comportamenti. Questa era la mente bicamerale, assai diversa dalla mente personale e soggettiva che noi siamo. Le due parti – la voce e l’ascoltatore, il divino e l’umano – erano, nell’ipotesi di Jaynes, entrambe non coscienti perché entrambe parte di una struttura olistica oggettiva che possiamo definire come l’accadere delle cose e degli eventi; in una parola: il mondo. In questa struttura volere significava semplicemente udire, poiché comando e comportamento erano una sola cosa. Diventa quindi chiaro che la mente bicamerale non coincide con i due emisferi cerebrali, i quali possono eventualmente rappresentare l’attuale modello neurologico di quell’antica struttura. Piuttosto, «la mente bicamerale è una mentalità arcaica che si rivela nella letteratura e nei manufatti dell’antichità» (542).
Nell’ipotesi di Jaynes, i guerrieri in lotta sotto le mura di Troia erano guidati da tali allucinazioni, erano dei «nobili automi che non sapevano quel che facevano» (101). Nelle civiltà bicamerali sparse per tutto il pianeta le divinità non stavano al di fuori, non venivano implorate come lontane o persino inaccessibili, non erano il “totalmente altro” ma costituivano una parte dell’essere umano, una presenza costante nel tempo e nello spazio, pronta ad ascoltare, consigliare, ammonire, punire, difendere. In questo senso, gli dèi non furono inventati o immaginati ma erano semplicemente la volontà dell’uomo che non sapeva o non percepiva di averne una; erano parte del sistema nervoso pronto a proiettarsi al di fuori del corpo ma dalla corporeità sempre scaturiente. Il tempo lunghissimo – millenni interi – nel quale alle statue veniva attribuito un culto tanto costante quanto convinto e diffuso in ogni civiltà, non può essere spiegato in termini anacronistici, quali semplici “superstizioni” o “idolatria”. È assai più probabile «che gli esseri umani udissero le statue rivolgere loro la parola, nello stesso modo in cui gli eroi dell’Iliade udivano i loro dèi o Giovanna d’Arco udiva le sue voci» (223). La persistenza del culto delle statue nella pratica cattolica conferma la fecondità di tale ipotesi, come se molti esseri umani non si rassegnino a privarsi di un contatto fisico con il proprio dio, con una parte così essenziale e potente del sé ma anche del noi.
La scrittura sarebbe uno dei fattori decisivi del crollo della mente bicamerale. Una volta, infatti, che la voce degli dèi si trasforma in scrittura, essa si separa dal corpo dell’uomo e può persino non essere più ascoltata. Il segno scritto si trova in un luogo ben preciso mentre la voce bicamerale poteva investire il proprio destinatario in qualunque momento e in qualsiasi luogo. Se l’essenza della mente bicamerale era l’udito, il passaggio al segno scritto e quindi visivo rappresenta una svolta decisiva. Una svolta dalla quale ebbe origine la coscienza, la nostra coscienza. E questo termine va inteso proprio nella duplice accezione consentita, ad esempio, dalla lingua inglese: sia come consciousness, consapevolezza di sé e della soggettività che si è, sia come conscience, dimensione morale dell’agire. Venute meno le voci degli dèi, infatti, la nuova soggettività che si produce dà a se stessa le regole dell’agire, attribuendole certo ancora a potenze esterne ma appunto esterne e non voci interiori con le quali l’essere umano coincide, che sono l’essere umano.
I fattori della trasformazione furono naturalmente molteplici e fra questi Jaynes ritiene che abbia contato – per il Mediterraneo – lo sconvolgimento seguito all’inabissarsi di buona parte delle terre dell’Egeo, con la conseguente migrazione di molti popoli e l’incapacità delle voci divine di dare una spiegazione e un significato alle catastrofi e ai lutti, di impartire ordini e soluzioni praticabili e sensate nella tragedia generale. Ma ciò significa che la coscienza sarebbe un dato anche storico e non soltantpsicolpsicologiao biologico, in particolare affinché si dia coscienza è necessario che prima ci sia un linguaggio. La coscienza, in altri termini, sarebbe «un evento culturalmente appreso, cresciuto precariamente sulle vestigia soppresse di una forma mentale precedente» (471).
Espressione della capacità narrativa della mente bicamerale è anche quel compagno immaginario che ancora molti bambini si inventano e col quale dialogano come se fosse altro da sé (celebre l’amico di Dany nel film di Kubrick Shining); un compagno che rappresenta ancora un’altra traccia della mente bicamerale fin nei gangli psicologici della contemporaneità. E ovunque sono presenti le tracce di quell’antico intrattenimento dell’umano col sacro presente nel proprio corpo e nel corpo proprio, nel Leib che non è appunto l’organismo ormai silenzioso e morto, il soma, ma è ancora corporeità aperta al mondo, alle relazioni, all’alterità che la costituisce, è psyche.
Nel II millennio aev tali voci sono cessate, nel I millennio hanno cominciato a tacere anche gli oracoli e i profeti, e cioè coloro che erano diventati gli intermediari delle voci perdute. Nel I millennio ev il comando era ancora dato dai testi delle voci degli dèi che si erano rapprese nello scritto, mentre in quello successivo anche i libri hanno progressivamente perduto la loro autorità. Per Jaynes, «ciò che abbiamo vissuto in questi quattro millenni è la lenta, inesorabile profanazione della nostra specie» (518), che coincide con il ritrarsi del sacro, con la riconduzione della teosfera all’antroposfera e da qui alla tecnosfera. Il pullulare di movimenti religiosi settari, il grande successo dell’astrologia e delle varie forme di esoterismo in una società disincantata, economicistica e ipertecnicizzata conferma ancora una volta che senza una spiegazione altra rispetto al semplicemente visibile, gli esseri umani forse non riescono proprio a vivere.
Questo libro rappresenta il tentativo di costruire una «paleontologia della coscienza, nella quale sia possibile discernere, strato per strato, in che modo e in seguito a quali pressioni sociali fu costruito questo mondo metaforizzato che chiamiamo coscienza soggettiva» (264-265). Con le sue ipotesi, Jaynes contribuisce a chiarire la natura del tutto reale della coscienza, il suo costituire una forma di vita biologicamente e storicamente data, nel senso che la sua evenienza storica era implicita nella forma biologica di un corpo capace di generare, udire, comprendere, decifrare i significati. Sono questi ultimi il portato della coscienza, a sua volta radicata nel corpo. E ciò vuol dire che il corpo è una macchina semantica, così come lo è la mente. Due facce – σῶμα e ψυχή – della stessa struttura comprendente il mondo.