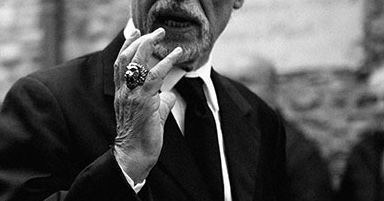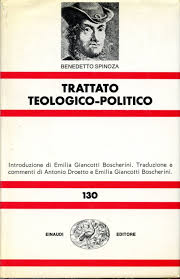Non dimenticare nulla è una patologia. Lo sa il Funes del racconto di Borges, lo sa bene la neurobiologia, lo sa Nietzsche con il suo folgorante «Per ogni agire ci vuole oblio» (Sull’utilità e il danno della storia per la vita, § 1, in «Opere» III/1, Adelphi1976, p. 264). Sia le vite individuali sia quelle collettive devono dimenticare per poter vivere ancora, per lasciarsi alle spalle il male. E invece l’Europa si immerge sempre più in orge della memoria, in giornate della condanna che sono anch’esse un chiaro segnale nichilistico, qualunque esperienza si ricordi e si condanni: lager, foibe, colonialismi, mafie e altro.
Una pervasiva orgia della comunicazione è in realtà comunicazione del nulla: «Gli individui avranno certo mezzi di comunicazione sempre più sofisticati. Ma non avranno più nulla da dire. Senza vita interiore non si ha più nulla da scambiare con gli altri. Si entra in un universo di zombie privi di intelligenza» (Michel Houellebecq in un’intervista, al solito preveggente, del 1996 a Immédiatement). I venticinque anni che sono trascorsi da questa dichiarazione la confermano. Nonostante i suoi chiari e fecondi vantaggi nella consultazione, nel lavoro di scrittura, nel reperimento di informazioni, Internet è anche e soprattutto un luogo di volgarità linguistiche, pensieri balbettanti, sistematica schedatura.
L’orgia da Social Network sta toccando uno dei suoi vertici nella sottomissione a poteri non soltanto autoritari ma anche del tutto incapaci e spesso maliziosi. Nella gestione politico-amministrativa-sanitaria dell’epidemia da Sars2, infatti, «i pubblici poteri hanno miseramente fallito in tutti i campi: mascherine, test, vaccini. Non c’è un solo errore che abbiano mancato!» (Alain De Benoist, Diorama Letterario, n. 360, Marzo-Aprile 2021, p. 6) e tuttavia dai Social si alzano o miopi e conformisti elogi oppure insulti pregiudiziali, in relazione al colore partitico di tali poteri, criterio che dovrebbe invece non contare nulla in un dramma come quello che stiamo vivendo.
Il dramma è anche e soprattutto l’orgia autoritaria che come un’ondata devastante sta sommergendo le società illuministe, progressiste, libere.
Tale ondata è stata ben descritta dal politologo Carlo Galli già in un intervento del 29 aprile 2020:
=======
«La sovranità è regolatrice, in uno spazio determinato, perché ha inizio dal “non-ordine”, perché ha davanti a sé una materia, i cittadini, omogenea e indifferenziata, infinitamente plastica, che può essere ordinata e disordinata in mille mutevoli differenze, con molteplici classificazioni, in infiniti sbarramenti e infinite aperture. Questo legare e slegare, questo “far ordine nel fare disordine”, e viceversa, è l’opera della decisione sovrana. […]
Nel lessico della bio-politica orientata verso la tanato-politica, la sovranità regna su una società incapace di sostenersi, una società malata, contagiata, priva di forma propria e soggetta all’azione politica decidente che separa i sani dai malati. Alcuni fa vivere, altri lascia morire: arbitrariamente, nel senso che le ragioni di questa decisione non esistono – la decisione in senso proprio è l’assenza di ragioni, anche se viene implementata attraverso dispositivi tecnici razionali –. Sanità e malattia sono collegate dall’eccezione, come ordine e disordine. […]
Il mondo liberale – i politici liberali –, sobriamente e prosaicamente, senza pathos e semmai con qualche lacrima sentimentale d’accompagnamento mediatico, pratica il caso d’eccezione. Nulla di sanguinoso: il cataclisma, la quasi-sospensione della costituzione, la pesante limitazione dei diritti costituzionali che stiamo vivendo – il lockdown –, sono il risultato di un’ordinanza commissariale implementata con un dpcm e legittimata da una legge ordinaria (il Codice della protezione civile) nonché da una interpretazione gerarchica dei diritti costituzionalmente riconosciuti. L’eccezione è già contenuta nella catena delle norme, con qualche forzatura ma senza che l’ordinamento sia apertamente e solennemente scardinato. L’uguaglianza davanti alla legge viene oggi utilizzata per classificare, per etichettare, per creare casi e sotto-casi, categorie e peculiarità: ammalati, portatori sani, guariti ancora infetti, critici, sub-critici, immuni – tipologie differenti che danno diritto a differenti accessi alle cure, e che generano differenti doveri di controllo e di autocontrollo –. Sempre nuovi perimetri spaziali vengono imposti: l’abitazione, il comune di residenza, i duecento metri dalla residenza, il metro e mezzo dalle altre persone; e poi i limiti regionali, e poi i confini nazionali. Su queste basi sono previsti controlli elettronici, internamenti, confinamenti, esclusioni, discriminazioni, concessioni di salvacondotti per età, per professione, per territorio. Le deroghe al blocco fisico delle persone – ai loro distanziamenti cui fanno da pendant i forzosi avvicinamenti (ricoveri) – sono legate a infiniti casi di necessità, a cause e motivazioni tanto fantasiose quanto incerte quanto arbitrariamente valutabili dai tutori dell’ordine (e dagli avvocati, che in un simile pandemonio sono perfettamente a casa propria): ne è un esempio fra l’assurdo e il grottesco la difficoltà di definire giuridicamente i “congiunti”, i “parenti”, gli “affini”, con cui ci si può incontrare, senza peraltro dar luogo ad assembramenti; o il numero massimo di quindici persone ai funerali.
La più minuziosa casistica, il massimo di ordine artificiale, imposto per decreto, si rovescia in un turbinio di disordine reale, si sfrangia in infinite fattispecie. […]
Tutto ciò non deve essere confuso con la disorganizzazione, con la disfunzionalità. Queste sono esiti delle debolezze pratiche del nostro Paese, in termini di efficienza amministrativa – debolezze moltiplicate dall’ordinamento regionale che consente disparità assai marcate –. No: il disordine, il pullulare di eccezioni, è contenuto nei dispositivi ordinativi, nelle norme stesse. […]
Per eliminare le accuse di negazionismo va detto che l’epidemia esiste, non è un effetto ottico; ciò che interessa sono gli effetti politici prodotti dalla sua gestione, dalla sua trasformazione in caso d’eccezione –. E si noti che questa trasformazione non è necessariamente dettata da volontà malevola dei governanti: piuttosto, è nel DNA della sovranità; che non sempre opera attraverso il caso d’eccezione, ma che sempre può farlo. Gli anti-sovranisti al governo non si sono accorti, o non lo vogliono ammettere, di avere attivato le logiche sovrane più radicali. […]
Ciò significa, oggi, cittadini ridotti a corpi, governati e gerarchizzati in nome della sanità, da una politica che si legittima attraverso la scienza. […]
La vita come assoluto è una vita sciolta da legami, povera, estenuata, irrelata. Quasi tutte le funzioni vitali non biologiche sono sospese, o sostituite dal virtuale, rappresentate nell’elettronica. Se la vita biologica del singolo è l’ultima istanza – analogo funzionale di Dio –, allora è autoreferenziale; è questo il motivo per cui si presta a essere virtualizzata. Il passo dal biologico all’elettronico è breve: c’è una affinità fra queste due forme di mancanza di concretezza storica e relazionale, di deficit di vita vera (il legame attraverso il virtuale non è, evidentemente, un legame ma una semplice comunicazione).
Le legittimazioni narrative, le mediazioni discorsive, a loro volta, hanno agito su due fronti, entrambi centrati sull’assioma che il summum bonum sia la nuda vita. Il primo è la paura, di cui i media si sono fatti accorti promotori – perché si depositasse nelle menti, e generasse angoscia ma non panico (che il potere politico non saprebbe fronteggiare) –; senza l’incombente presenza della paura l’infinita serie di limitazioni e vincoli non sarebbe sopportabile. Una paura che ha ulteriormente allentato il legame sociale: ognuno ha imparato a guardare con sospetto ogni altro, a temere tutti. A stigmatizzare i non-conformi, i nuovi untori (dal runner al pensionato indisciplinato), e ad assistere, in tv, alla caccia all’uomo con elicotteri e droni.
Il secondo fronte legittimante è la scienza. A differenza di quanto si crede, il mood fondamentale delle nostre società non è l’antiscientismo, che pure esiste, ma il culto della scienza come tecnica quasi magica, capace di risolvere ogni problema. Presentata dalla politica e dai media come il vero culto del vero Dio, come la via per la salvezza biologica individuale e collettiva, la scienza finora non ha saputo vincere la battaglia contro il virus – il lockdown è una dimostrazione di impotenza. […]
L’effetto dell’eccezione è, lo vediamo, una nuova normalizzazione, una nuova normalità. È rafforzato l’effetto di adesione conformistica alle pratiche e alle parole d’ordine dell’esecutivo: in tempo di crisi, non si può discutere ma si deve obbedire, remare concordi; l’imperativo della salus populi delegittima ogni dialettica – e ciò viene fatto valere per l’ambito sanitario, ma anche in relazione ai rapporti economici e finanziari con la Ue –. Un riflesso d’ordine, un effetto di neutralizzazione, che non è concordia civile né empatia sociale: è, semmai, un forzato affidarsi al potere. Passerà, quando ai cittadini verrà presentato il conto economico della pandemia; ma intanto c’è. […]
E l’effetto è che l’emergenza viene prolungata, resa permanente. Contro la volontà di vita che pervade il corpo sociale, contro il desiderio diffuso di tornare a quella che a tutti appare come la normalità pre-crisi (il fattore psicologico, qui, prevale comprensibilmente sui dati strutturali), continuamente si levano moniti di scienziati e di politici (con pochissime isolate eccezioni) che indicano il dovere di “cambiare stile di vita”, di imparare a “convivere col virus”, di “non abbassare la guardia”: la paura deve sedimentarsi nel corpo sociale, deve indurre a nuova obbedienza, a nuova introiezione di disciplina, a nuova sottomissione – in un contesto reso sempre più disordinato da sempre nuovi ordini –. La compressione dei diritti diviene così nuova normalità, legittimata dalla razionalità scientifica e da una misurata inoculazione della paura. Distanziamento personale, mascherine, impoverimento della vita sociale, tele-lavoro e tele-didattica, devono proseguire: almeno fino a che il vaccino sarà pronto (se mai lo sarà). […]
Questo non è un rovesciamento, ma un potenziamento delle logiche della politica moderna: l’eccezione celata originariamente nelle viscere del Leviatano si fa ora palese; il grande animale marino ora la esibisce, la insegue per nutrirsene. Finché c’è eccezione c’è vita: la sua. Il fine è sempre lo stesso: l’obbedienza in cambio della sicurezza; prima, della sicurezza già raggiunta, nell’ordine artificiale; oggi, della sicurezza da raggiungere, nella mobilitazione perenne. […]
Al momento, sono le esigenze della produzione (non certo i “diritti”) a fare argine al potere sovrano; esigenze che richiedono l’allentamento di alcuni dei vincoli ora vigenti. Un nuovo equilibrio fra prestazione ed eccezione si troverà, a spese dei soggetti, dei cittadini: per i quali il ritorno al lavoro sarà paradossalmente una liberazione, e l’obbedienza a obblighi sempre nuovi un giusto prezzo da pagare al combinato disposto dell’epidemia, della ricostruzione e dell’indebitamento col Mes; la libertà sarà “condizionata”, e la spontaneità una concessione. Donne e uomini saranno più sottomessi, più disciplinati davanti ai regimi di eccezione che via via normalizzeranno, in nuovi ordini sempre più bizzarri, il susseguirsi di emergenze di ogni tipo. […]
La dilatazione dell’eccezione significa quindi che tutto deve cambiare perché tutto resti com’è. Anziché essere l’irruzione del nuovo, l’eccezione è il banco di prova della resilienza del sistema – a spese delle libertà dei cittadini, a cui si chiede un’obbedienza nuova, che conferma le vecchie –. Una continuità al ribasso, quindi, in cui al capitalismo di controllo (quello dei big data, privatistico) si affianca lo Stato di sicurezza (la funzione pubblica), in una mescolanza zoppicante e aporetica, in un ordine disordinato, affollato di eccezioni, anomico.
Naturalmente, anche se la pandemia e la sua gestione hanno disvelato e accelerato processi e strutture, non è del tutto irrealistico pensare che dai molti squilibri che stanno profilandosi all’orizzonte possa emergere un imprevisto: la voglia di libertà di una società stanca di vivere dissolta, e pronta a stringere legami significativi sulla base della vita concreta e delle sue reali difficoltà, non della paura, né della nuda vita né della vita virtuale. Un evento eccezionale, e insieme una pulsione alla normalità, che, per una volta, sarebbero non una coazione a ripetere ma un soffio autentico di novità».
(Epidemia tra norma ed eccezione, in «Diario della crisi – Istituto Italiano per gli Studi Filosofici» – Pdf integrale dell’articolo)
=======
Un’analisi, questa di Carlo Galli, esemplare, densa di intelligenza, disincanto e apertura in ogni caso a un futuro diverso, nonostante l’orgia decisionista e sovranista del presente, nonostante lo stato d’eccezione.
Gli strumenti attuali di sorveglianza e controllo, i pervasivi dispositivi foucaultiani che ci attraversano, sono di una efficacia che i vecchi totalitarismi del Novecento sognavano senza poterla realizzare. Alla loro base, alla base della nuda vita, del controllo e dell’eccezione, c’è l’impulso a far vincere l’Identità rispetto alla Differenza, l’Uno rispetto al molteplice, a far vincere il Leviatano al quale accenna Galli.
Un’Identità fondata sul Terrore e che «porterebbe gli uomini a sacrificare la loro libertà al Leviatano. Con la pandemia, la fuga assoluta davanti alla morte conduce allo stesso risultato, con il rischio di avere solo una vita mutilata, posta sotto una perpetua sorveglianza. La dittatura sanitaria dello Stato materno e terapeutico, quello che ci dice come bisogna soffiarsi il naso ed abbracciarsi, è il nuovo Leviatano. Si appoggia a ‘la scienza’ e ci propone la sua tecnologia. Anch’esso è un Titano. […] Per il momento, il mondo titanico estende ovunque le sue metastasi. Il caos sale» (de Benoist, DL 360, p. 4).
[Una versione leggermente ridotta dell’articolo è uscita su Corpi & politica e su girodivite.it]