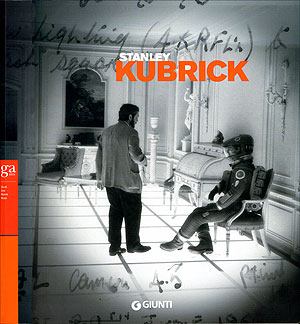di Aa.Vv.
A cura di Hans-Peter Reichmann
Giunti Arte Mostre Musei, Firenze-Milano 2007
Pagine 382
Plato is Philosophy and Philosophy is Plato. L’affermazione di Emerson potrebbe essere volta in questa forma: Kubrick is Cinema and Cinema is Kubrick. La perfezione tecnica, la forza delle immagini, l’unitarietà del percorso che da Day of the Fight (1951) conduce a Eyes Wide Shut (1999), la continua innovazione e un classicismo fuori dal tempo, sono alcune delle ragioni che giustificano l’identificazione tra Stanley Kubrick e l’arte cinematografica.
«Lettore vorace, interessato a ogni argomento» (A. Frewin, p. 170), radicato nella cultura europea –i nonni paterni provenivano dalla Mitteleuropa-, Kubrick assorbe, rielabora, esprime e ricrea temi e domande filosofiche. E lo fa con la forza dirompente delle immagini, dei significanti e dei significati non verbali, di icone e simboli che non possono né devono essere spiegati. Il senso dei suoi film è evidente e nello stesso tempo inaccessibile anche perché essi vogliono descrivere la realtà del mondo e della psiche ma lo fanno con un atteggiamento di radicale disincanto nei confronti del potere comunicativo delle parole: «In a film, however, I think the images, the music, the editing and the emotions of the actors are the principal tools you have to work with. Language is important but I would put it after those elements» (cit. da R.M. Fischer, p. 230).
L’opera di Kubrick è una filosofia non verbale, iconica, sorretta da una logica lucida e da una matura antropologia. Non solo per i numerosi e più o meno espliciti riferimenti –la War Room del Dr. Strangelove è la Caverna platonica; HAL 9000 e il monolito sono simboli del pensiero tecnico e cosmico, della potenza e della fragilità di ogni «ragione strumentale» (V. Fischer, p. 157)…- ma soprattutto per la potenza di uno sguardo fenomenologico che non giudica bensì mostra, che esclude ogni psicologismo nella analisi e comprensione delle azioni umane, per attingere invece alle strutture biologiche, storiche, archetipiche della nostra specie. La caratteristica filosofica più importante del cinema di Kubrick è il suo profondo rispetto nei confronti della realtà e cioè degli enti, degli eventi e dei processi. Per questo «non esiste uno stile kubrickiano. Il Kubrick cineasta si caratterizza proprio per il fatto che il suo modo di procedere creativo si adatta al soggetto in questione e si sviluppa a partire da quest’ultimo» (C. Appelt, p. 317).
Il cosiddetto “perfezionismo” non è altro che una espressione di tale completa aderenza al reale, testimoniata dalle parole di Ken Adams a proposito di Barry Lindon, molto più che un aneddoto: «Facemmo ricerche sugli spazzolini da denti del periodo, sui contraccettivi, su una quantità di cose che alla fine non sono apparse sullo schermo» (R.M. Fischer, p. 223). Chi vuole descrivere il mondo deve infatti cominciare col rispettarlo e con l’averne cura in ogni sua componente.
È tale riconoscimento filosofico della complessa unitarietà del reale a fare dell’opera kubrickiana una delle più riuscite espressioni di superamento dei dualismi che impediscono di comprendere l’essere. Kubrick, infatti, nel descrivere l’uomo e il suo mondo coniuga in modo inestricabile ragione e sentimento, tragedia e ironia, comicità e disperazione, maschera e autenticità, “bene” e “male”. Davvero «il pubblico rimane privo di una morale della favola» (Ivi, p. 230).
Kubrick filosofo sa da subito e conferma ogni volta che la lotta costituisce una condizione ineliminabile della corporeità, che bìos e thanatos, desiderio e guerra sono tra di loro intrecciati. Dagli scontri fra boxeur delle prime pellicole, passando per le guerre di Fear and Desire, Spartacus, Paths of Glory, Dr. Strangelove, Barry Lindon, attraversando la violenza estrema delle relazioni personali, familiari, sessuali e sociali di Lolita, A Clockwork Orange, The Shining, si arriva al culmine di Full Metal Jacket, «forse il film di guerra più radicale che sia mai stato girato. Nel film di Kubrick (…) l’opposizione tra guerra e umanità si rivela illusoria» (G. Seesslen, p. 276), illusione confermata da Eyes Wide Shut, il cui tema principale è probabilmente il proustiano “essere di fuga” che ogni umano rappresenta per l’altro, una impossibilità di possedere che trasforma le relazioni in una guerra e fa dell’amore un sogno e un incubo, maschera suprema del niente.
Lo sguardo teoretico di Kubrick va ancora oltre e arriva a cogliere due cardini della comprensione filosofica: il determinismo, la verità nomade. In The Killing (Rapina a mano armata) l’intreccio di caso e necessità produce un perfetto meccanismo di eventi dal quale è impossibile uscire, così come il vero tema di Arancia meccanica è il condizionamento biologico di ogni essere umano. La sottile e inspiegabile impressione di “innocenza” che nonostante tutto promana da Alex si fonda su questa inevitabilità del suo comportamento, per la quale non serve la rozza tecnologia della “cura Ludovico” e che invece acquista senso alla luce del principio deterministico enunciato da Schopenhauer: «operari sequitur esse, ergo unde esse inde operari» (La libertà del volere umano, Laterza, p. 118). Concezione che ha una sua profonda espressione metaforica nell’annotazione scritta da Kubrick in una bozza di sceneggiatura del progettato film su Napoleone: «forse è proprio così: il grande campione di scacchi non può battere il peggiore dei giocatori in meno di un determinato numero di mosse. A un osservatore casuale può sembrare che il dilettante possa tenergli testa, ma un vero scontro non c’è mai stato» (citato da E.M. Magel, p. 208); un “vero scontro” tra il singolo e la necessità “non c’è mai stato”, davvero.
L’essere, il tempo, appaiono così per quello che sono: labirinti della mente. Il dedalo su cui Jack Torrance si sofferma e dentro il quale trova la morte è il labirinto temporale e interiore nel quale l’immobilità spaziale della figura congelata di Jack è identica all’immobilità temporale che fa di lui da sempre il custode dell’Overlook Hotel, come conferma la foto su cui il film si chiude: una festa del 1921. Il centro immobile del Tempo coincide con il suo eterno ritornare. Un’eternità che colloca 2001. A Space Odissey al centro geometrico del pensiero di Kubrick, una centralità che rende profondamente unitaria la sua opera, un percorso nel quale ciascun film si collega a ogni altro attraverso una serie ricchissima di rimandi, temi, citazioni intertestuali, obiettivi, crescita sapienziale.
L’occhio dello Starchild che chiude 2001 diventa nella prima immagine del film successivo l’occhio di Alex, così come l’avanzatissima intelligenza tecnologica di Hal -fattasi nemica dell’umano- apre alla intelligenza biologica dell’Overlook Hotel, un vero e proprio animale che divora la mente di chi lo abita fino a inglobarlo in sé. Lo scimmione preistorico diventa umano nel momento della violenza, il grande e grosso Palla di lardo diventa uomo anch’egli quando uccide il sergente suo aguzzino. Il peregrinare di David nel tempo diventa sia il cammino di ascesa e crollo sociale di Barry Lindon sia il viaggio del Dottor Harford nel labirinto del desiderio e della paura…Un vagabondare che caratterizza tutti i film e i personaggi di Kubrick e che si dispiega come nomadismo di una verità che riserva sempre nuovi luoghi, dimensioni e significati.
La mobile verità del mondo genera il nomadismo della mente ed è da essa prodotto. In questo cammino, la possibilità è l’itinerario verso lo svelamento dell’enigma, il rischio è il precipitare verso la follia, verso le tenebre…ed è a questo punto che si mostra la radice filosofica e gnostica del pensiero di Kubrick. Il familiare diventa mostruoso, la Heimat –la dimora, la solida terra che ben si conosce- si trasforma nello unheimlich, nell’inquietante che non dà più punti di riferimento e dentro la cui oscurità ci si può perdere per sempre. Ci sono due luoghi visuali in cui tenebre e luce sembrano trapassare l’uno nell’altro e fondersi: il primo è la scena conclusiva di Dr.Strangelove nella quale «accompagnato dall’idea che il mondo segua una legge matematico-divina, il cerchio di luce diventa l’immagine simbolica della forma di un cosmo irradiante/irradiato, infuocato e morente che, nella notte del cosmo, muore con la stessa rapidità con cui era nato» (B. Hars-Tschachotin, p. 116); il secondo è il duplice esito del labirinto di Shining: «dal momento che il labirinto combina due motivi collegati con l’infinito, uno dei quali è un motivo ornamentale che porta ad un vicolo cieco, chiuso, inguaribilmente pessimistico (l’eterno ritorno collegato a Jack), mentre l’altro, la spirale, è un motivo positivo, aperto, ottimistico (l’eterno divenire collegato a Danny), il labirinto simboleggia alla fine il trionfo del figlio sul padre, del “figlio della luce” sull’oscura violenza» (M.Ciment, cit. in U. von Keitz, p. 240).
Dentro il cinema ma anche molto al di là di esso, il pensiero di Kubrick riconosce l’indistruttibilità del male e del dolore: Hal 9000/l’albergo della scintillanza/Jack Torrance e i suoi fantasmi/la pervasività del conflitto e della distruzione…sono la potenza delle tenebre. Ma l’occhio della mente cinematografica e filosofica può guardare la Medusa e non morire: gli occhi chiusi su questo mondo di sogno si aprono col cinema ad altre visioni perché –afferma Kubrick- «il vero scopo di un film è fare luce» (cit. da G. Seesslen, p. 278). Una foto di Weegee ritrae il giovane regista «misteriosamente ammantato nella materia stessa del cinema: luce e ombra» (D. Kothenschulte, p. 137). La stessa materia dei suoi pensieri.