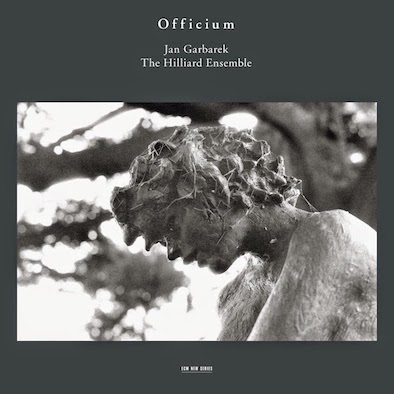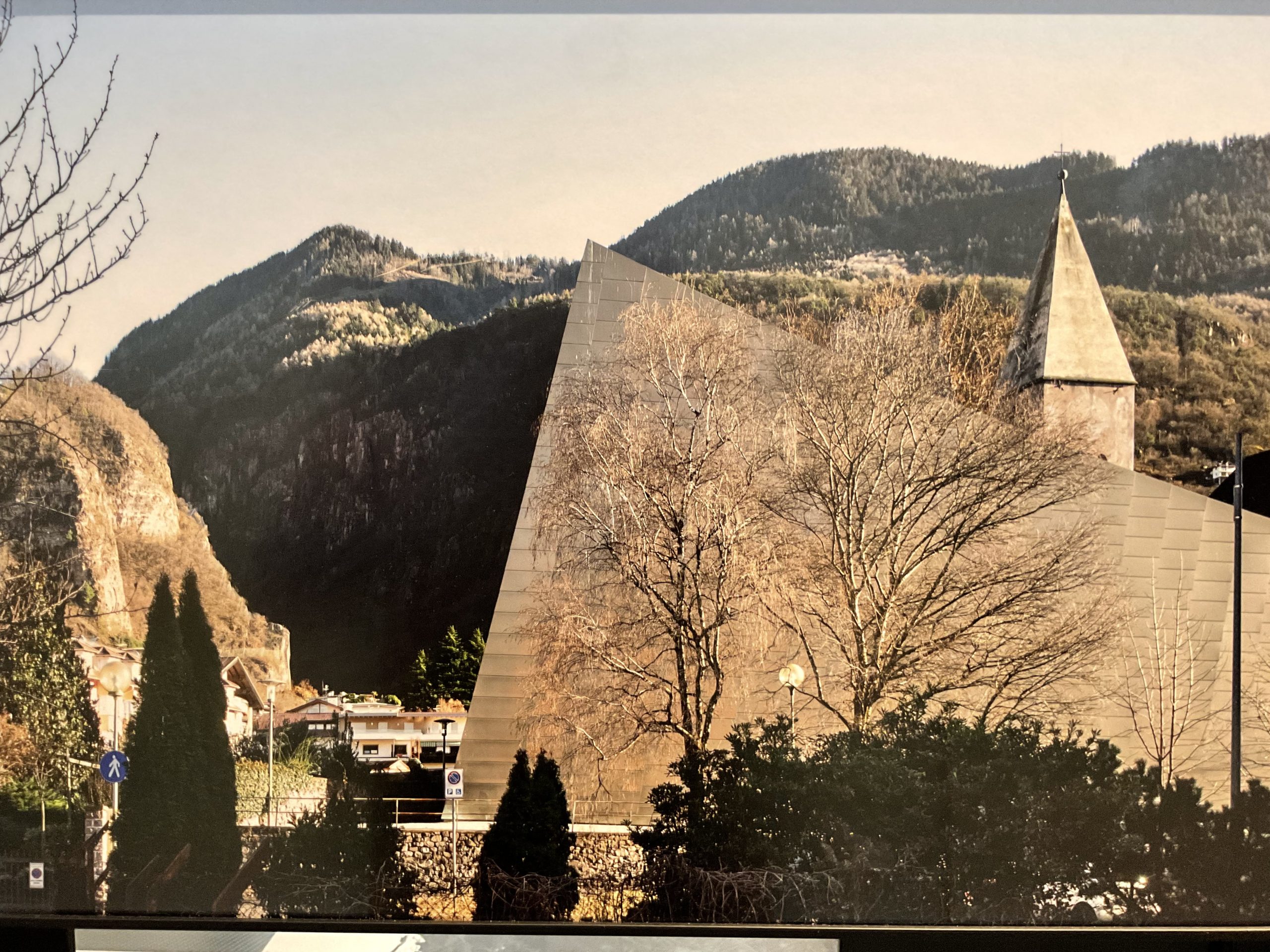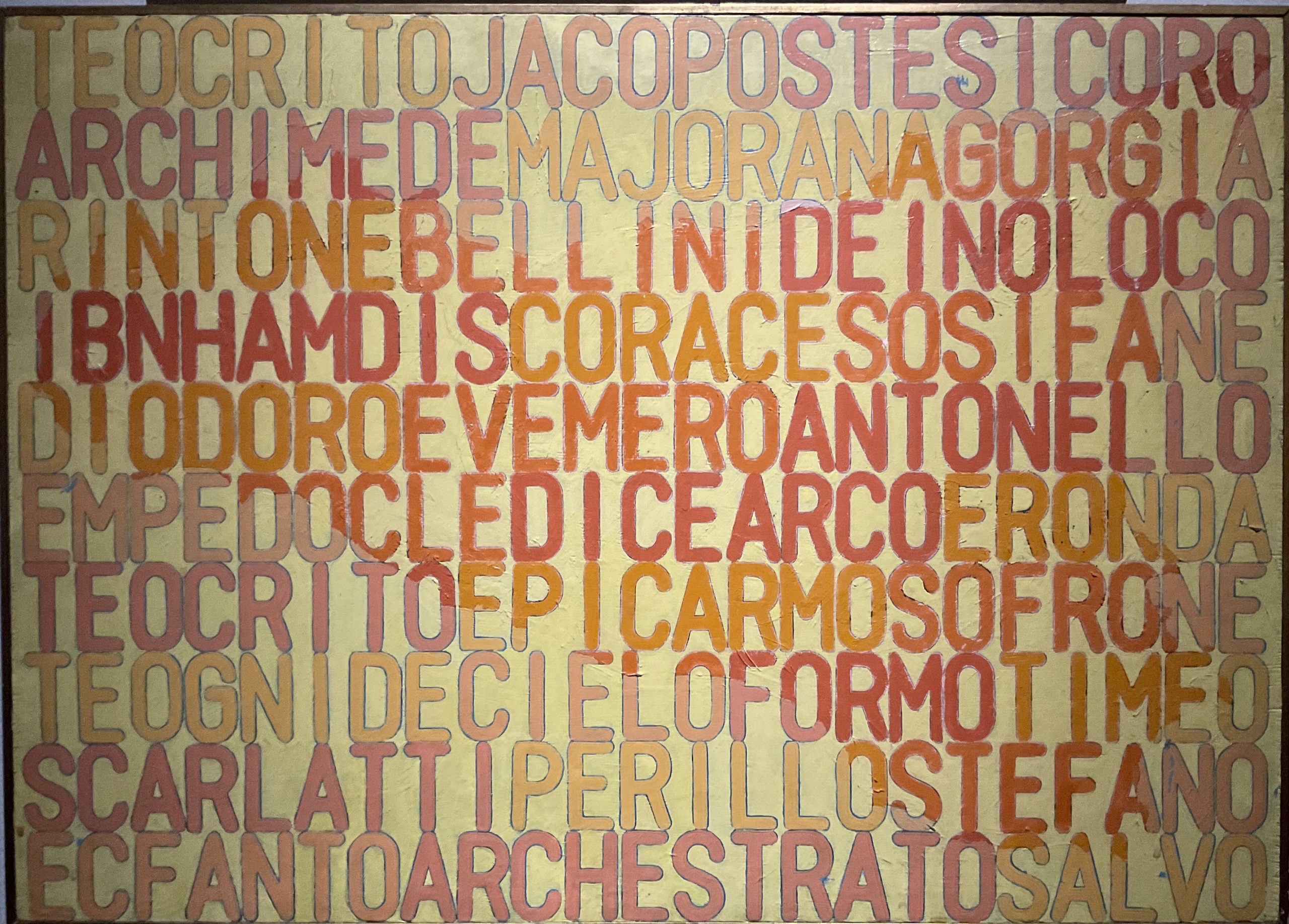Il mio debito verso questo filosofo, la mia riconoscenza, datano da quando sedicenne lessi la notizia della sua morte e forse per la prima volta sentii l’espressione Essere e tempo, titolo di un libro labirintico e posto sull’oltre della vita. Di questo libro e del suo autore ci parlava Eugenio Mazzarella nei corsi di Filosofia teoretica a Catania. La vocazione per la filosofia aveva trovato un nome pari a quelli di Platone e di Spinoza.
In occasione degli ottant’anni di Heidegger, Hannah Arendt pronunciò alcune semplici parole che descrivono perfettamente quest’uomo e la sua opera: «C’era uno che faceva davvero le cose che Husserl aveva proclamato, uno che sapeva che non si trattava di faccende accademiche, ma delle domande degli uomini che pensano, e non soltanto da ieri o da oggi ma da sempre […] La fama lo diceva in modo semplicissimo: il pensiero ha ripreso a vivere […] C’è uno che insegna, forse è possibile imparare a pensare» (Essere e tempo, trad. di A. Marini, Meridiani Mondadori, 2006, pp. CXIV-CXV).
E anche imparare ad apprezzare il calcio. Non molti sanno che Martin Heidegger nutriva una «inalterabile passione per il calcio. Che divenne anche militanza attiva nel periodo adolescenziale, tra le fila della squadra del Meßkirch, ricoprendo il ruolo di ala sinistra. Ma ancor più sorprenderà leggere dell’ammirazione senza riserve che Heidegger celebra per uno dei maggiori difensori-mediani della storia del calcio: Franz Beckenbauer, idolo di Germania a partire dagli anni ’60, conquistatore di trofei e trionfi nazionali e internazionali. Lo sguardo del filosofo si illumina appena quel nome viene pronunciato, cui fanno seguito precise argomentazioni: intelligenza della posizione in campo, abilità suprema nel presagire e ostacolare l’attacco dell’avversario, autorevolezza della funzione di raccordo nel centro del campo e, non da ultima, la precisione del rilancio, che in numerose occasioni offre alla propria compagine d’attacco l’occasione di andare in goal.
Senza parole, probabilmente, rimarranno i legionari e gli appassionati del pensiero del Maestro, assicura Fédier, quando leggeranno che per il talento di Beckenbauer egli arrivò a pronunciare un aggettivo che raramente o forse mai era affiorato sulle sue labbra: “geniale”».
(Fonte: Carlo Rafele, Il filosofo e il calciatore Per una tregua del caso Heidegger, righe finali del testo)
Un’interessante testimonianza lo conferma:
«Heidegger by then was a venerable old gentleman, and his former brusqueness and severity had mellowed with the years. He would go to a neighbor’s house to watch European Cup matches on television. During the legendary match between Hamburg and Barcelona, he knocked a teacup over in his excitement. The then director of the Freiburg theater met Heidegger on a train one day and tried to conduct a conversation with him on literature and the stage. He did not succeed however, because Heidegger still under the impact of an international soccer match, preferred to talk about Franz Beckenbauer. He was full of admiration for this player’s delicate ball control – and actually tried to demonstrate some of Beckenbauer’s finesses to his astonished interlocutor. He called Beckenbauer an “inspired player” and praised his “invulnerability” in duels on the field».
[Fonte: Heidegger and Beckenbauer]
Quando leggo le pagine di Heidegger si accresce il desiderio di decifrare la realtà e anche di segnare un gol, come mi accadde una volta a quattordici anni nel campetto dei Cappuccini di Bronte: una ‘rovesciata’ in piena area che lasciò di stucco il portiere avversario e fu per la mia squadra ragione di festa.