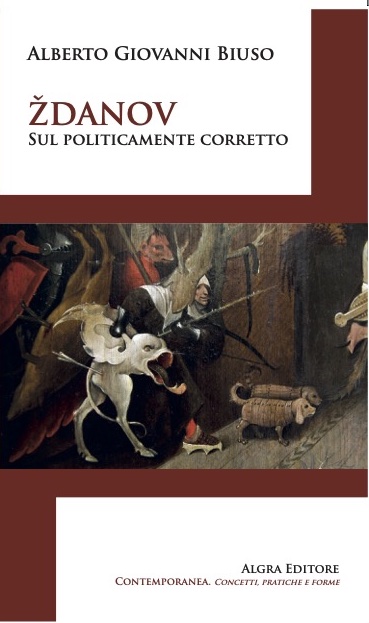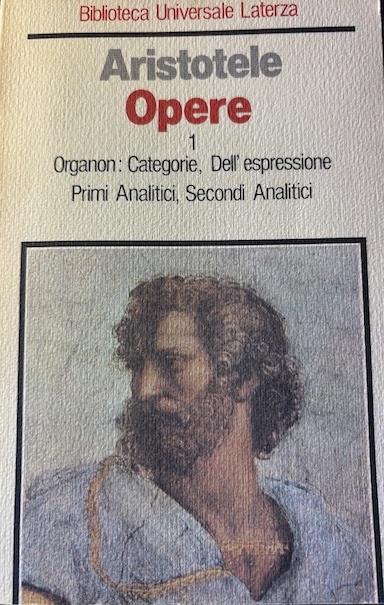Aristotele
Organon
Categorie, Dell’espressione, Primi Analitici, Secondi Analitici
in «Opere», a cura di Gabriele Giannantoni, volume I
Traduzione e note di Giorgio Colli
Laterza 1982
Pagine LXIV-373
Logica, Metafisica, Etica nel pensiero aristotelico appaiono sempre strettamente legate. Quanto viene acquisito in un ambito contribuisce a chiarire e ad approfondire altre discipline, settori, domande. È anche questo movimento interno della verità – quasi come il sangue che circola in un corpo – a fare dell’opera aristotelica una struttura di pensiero sempre viva, pulsante, attuale, come se fosse stata scritta oggi. Ciò che è stato chiamato Organon, lo strumento della ricerca, non è limitabile al campo della logica pur fondando la logica.
Nelle prime quattro delle sei opere che compongono l’Organon viene, infatti, chiarita la distinzione che è anche metafisica tra le sostanze prime – l’ente singolo nel qui e ora della sua esistenza irriducibile – e le sostanze seconde, i concetti, i generi, gli universali. Non ha quindi senso affermare che una sostanza prima sia più sostanza di un’altra, dato che il semplice esserci qualifica e caratterizza gli enti che sono. La logica mostra qui la sua natura profonda di scienza non antropomorfica, pur costituendo proprio essa una tipica caratteristica umana.
La ragione per cui le sostanze prime si dicono sostanze in massimo grado consiste nel fatto che esse stanno alla base di tutti gli altri oggetti, e che tutti gli altri oggetti si predicano di esse, oppure sussistono in esse […]. Allo stesso modo, del resto, tra le sostanze prime nessuna è sostanza in misura maggiore di un’altra; un determinato uomo è infatti sostanza in misura per nulla maggiore di un determinato bue.
(Cat. 5, 2b 15-30)
Se i concetti altro non sono che la generalizzazione degli enti operata dalla mente umana, è chiaro che ogni conoscenza non può nascere che dal contatto con la dimensione concreta degli oggetti singoli, della pluralità infinita e determinata delle cose individuali. La contrapposizione alla gnoseologia del Menone è quindi esplicita: «in effetti, non ci accadrà mai che dell’oggetto singolo sussista una prescienza; si deve dire piuttosto che mentre si sviluppa l’induzione noi assumiamo la conoscenza degli oggetti particolari, come se li riconoscessimo» (An. post. B 21, 67a 22-25; cfr. anche An. post. A 1, 71b 6-10). Non solo: nessuna conoscenza è possibile se si prescinde dalla sensazione «dal momento che noi impariamo o per induzione, o mediante dimostrazione […] non è tuttavia possibile cogliere le proposizioni universali se non attraverso l’induzione, poiché anche le nozioni ottenute per astrazione saranno rese note mediante l’induzione» (An. Post. A 18, 81a 39-40, 81b 1-5).
Dal particolare all’universale, dal singolo al concetto, questo è secondo Aristotele il cammino della conoscenza. Dalla sensazione nasce il ricordo, dal ricordo ripetuto si genera l’esperienza. Le forme più alte del sapere, l’intuizione e – a essa subordinata – la dimostrazione, hanno quindi a fondamento la sensazione diventata esperienza. Ma lo Stagirita non è un semplice empirista. Prima di Galilei e della Rivoluzione scientifica, nata più contro gli aristotelici che contro Aristotele, egli aveva chiara la differenza fondamentale tra la semplice osservazione dei fenomeni e la loro comprensione razionale. La percezione da sola non è, infatti, spiegazione: «la conoscenza dimostrativa non si può raggiungere attraverso la sensazione […] La sensazione si rivolge, infatti, necessariamente all’oggetto singolo, mentre la scienza consiste nel render noto l’oggetto universale» (An. post. A 31, 87b 28-35; cfr. anche An. post. A 13, 79a 10-12).
Le Categorie accennano anche alle tesi sviluppate nella Fisica a proposito delle diverse forme del mutamento, qui individuate in sei ma sintetizzabili in quattro: «generazione e corruzione, accrescimento, diminuzione, modificazione qualitativa, movimento» (14, 15a 13-14); elencano poi le dieci categorie: «i termini che si dicono senza alcuna connessione esprimono, caso per caso, o una sostanza, o una quantità, o una qualità, o una relazione, o un luogo, o un tempo, o l’essere in una situazione, o un avere, o un agire, o un patire» (4, 1b 25); enunciano infine una vera e propria filosofia del linguaggio che ha a fondamento la distinzione tra il nome, il verbo e la proposizione: un nome può diventare vero/falso solo se viene unito a una predicazione-determinazione, la funzione di verità dipende quindi dalla connessione fra i nomi, ciascuno dei quali può essere sensato o meno ma mai da solo può essere vero o falso.
La filosofia del linguaggio viene ulteriormente sviluppata nel De interpretatione. Qui Aristotele afferma con molta chiarezza che «i suoni della voce sono simboli delle affezioni che hanno luogo nell’anima, e le lettere scritte sono simboli dei suoni della voce» (1, 16 a 5). Anche per questo, «nessun nome è tale per natura» e il linguaggio è una delle espressioni peculiari dell’identità umana, intessuta sin dall’inizio di artificio, convenzione, tecnica (2, 16 a 25-30).
Anche qui, come in molti dei suoi scritti, Aristotele ribadisce il principio di fondo – ancora una volta insieme logico, gnoseologico e metafisico – secondo cui «noi pensiamo di conoscere un singolo oggetto assolutamente -non già in modo sofistico, cioè accidentale- quando riteniamo di conoscere la causa, in virtù della quale l’oggetto è» e la necessità che lo fa esistere e agire (An. post. A 2, 71b 9-10; cfr. anche An. post. B 8, 93a 4-5).
I risultati più specificatamente logici delle ricerche contenute nell’Organon sono riassumibili nel principio di non contraddizione: «Orbene, non è possibile che delle determinazioni contrarie appartengano simultaneamente allo stesso oggetto» (De interpr., 24b 10); nella delineazione di ciò che gli scolastici chiameranno «quadrato logico» (Ivi, 24b 1-5; An. pr. B, 62a 15-19); nella lucida, approfondita e finanche appassionata discussione dei sillogismi, delle dimostrazioni, dei ragionamenti capziosi come il “circolo vizioso”: «la dimostrazione è infatti un particolare sillogismo, mentre non tutti i sillogismi sono dimostrazioni. Orbene, quando tre termini stanno tra di essi in rapporti tali, che il minore sia contenuto nella totalità del medio, ed il medio sia contenuto, o non sia contenuto, nella totalità del primo, è necessario che tra gli estremi sussista un sillogismo perfetto» (An. pr. A 4, 25b 30-35). Cfr. anche An. pr. B 16, 64b 25-30, 65a 1-5; An. post. A 2, 71b 19-21; «colui che possiede la dimostrazione universale conosce pure l’oggetto particolare, mentre colui che possiede la dimostrazione particolare non conosce l’oggetto universale» (An. pr. A 4, 24, 86a 12).
Certo, molte pagine dell’Organon sono assai tecniche, a volte oscure e non prive di contraddizioni. Non a caso, la filologia aristotelica trova in esse un campo assai vasto di indagine. E tuttavia, il pensiero dello Stagirita è alla fine sempre lucido, coerente e sistematico; una vera e propria machine à penser. L’aristotelismo è tuttavia un dispositivo sempre consapevole dei limiti che ineriscono al ragionare umano, tanto più grandi quanto più esso si autocostruisce nella formalizzazione logica. Infatti, «su argomenti di questa natura è forse difficile, senza aver condotto ripetute indagini, formulare delle dichiarazioni nette; non è tuttavia inutile l’aver agitato delle difficoltà su questi vari punti» (Cat. 7, 8b 20-25). Ed è proprio tale agitazione uno degli specifici elementi della filosofia.