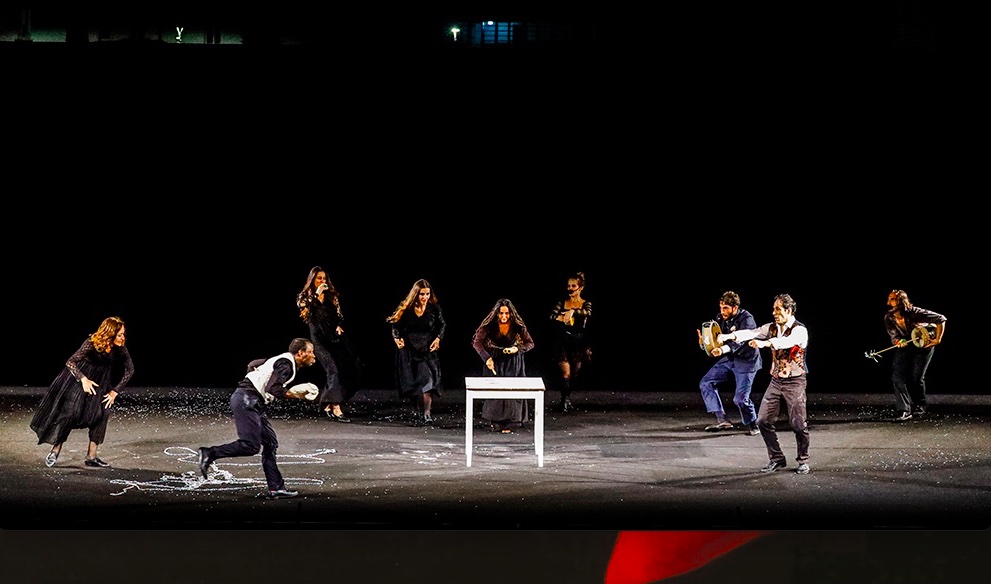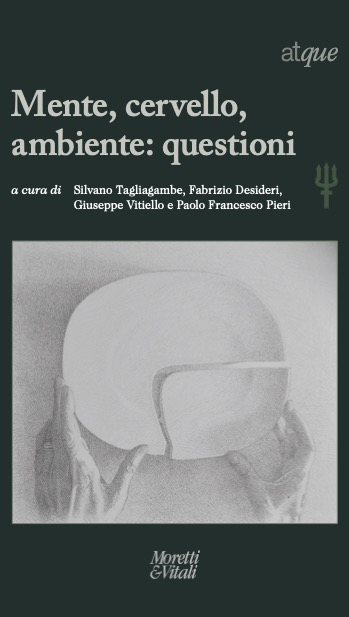
Una coscienza antropodecentrica
in ATQUE. Materiali tra filosofia e psicoterapia
numero 30-31, n.s, 2023
Mente, cervello, ambiente: questioni
pagine 105-120
Abstract
Among the most fruitful results of a philosophy of the mind open to the contribution of the biological sciences there is also the bringing back of the human being and his awareness of being there to the wide world of animal sensitivity. Ancient dualisms and new reductionisms are thus overcome in a perspective that can be defined as zooanthropology/etoanthropology, capable of reading every species, every function and every conscience of the world as an expression of an anthropodecentric richness that safeguards the identity of life and the difference of his expressions.
Tra i risultati più fecondi di una filosofia della mente aperta al contributo delle scienze biologiche c’è la riconduzione anche dell’umano e della sua coscienza d’esserci all’ampio mondo della sensibilità animale. Antichi dualismi e nuovi riduzionismi vengono in questo modo oltrepassati in una prospettiva che può essere definita zooantropologia/ etoantropologia, capace di leggere ogni specie, ogni funzione e ogni coscienza del mondo come espressione di una ricchezza antropodecentrica che salvaguarda l’identità della vita e la differenza delle sue espressioni
Indice
-Coscienza e ontologia
-Al di là del primato della coscienza
-Filosofia della mente
-Zooantropologia
-Antropodecentrismo
-Identità e Differenza
-Coscienza e corpomente animale
Riconoscerci in tutto e per tutto come gli animali che siamo significa accettare la carnalità dei nostri bisogni senza la pretesa di dominarli con uno sguardo soltanto razionale. L’ontologia relazionale diventa così forma ed espressione dello sguardo filosofico, da sempre sapiente del limite, e ci aiuta a oltrepassare il teatro cartesiano nel quale soggetto e oggetto recitano stancamente la loro parte, mentre tutto intorno il mondo continua a essere ciò che è sempre stato: un intero che accoglie distinzioni epistemologiche, affinché una sua parte possa comprenderlo meglio, ma non conosce separazioni ontologiche, data l’oggettiva e feconda continuità delle sue strutture.
Il principio di base per una comprensione del mondo animale, umano compreso, è quello della Differenza, della diversità specie-specifica che non significa minorità o carenza ma semplicemente una diversa dotazione adatta a differenti contesti ambientali e funzionali.
La negazione dell’animalità umana si fonda e insieme si esplica nella negazione dell’identità e della differenza. Negazione della differenza poiché lo specismo non riconosce la varietà non gerarchica della vita. Negazione dell’identità che accomuna l’intera animalità in quanto vita attiva della materia. Una negazione che sta alla base della presunzione umana di costituire qualcosa di speciale nell’essere. L’umano è unico, certamente, come unica è la forma di esistenza di ogni altro vivente.
Specismo è anche esser convinti – come sono molte filosofie della storia e opzioni politiche ‘progressiste’ – che una natura umana non esista e che Homo sapiens sia un’entità del tutto storica, volontaristica e autopoietica. E tuttavia attribuire una ‘natura’ a ogni altro vivente e negarla al vivente umano è il culmine teorico di ogni concezione specista della ζωή.
Se percepire ciò che si sta vivendo mentre lo si sta vivendo è ciò che definiamo coscienza, essa è comune a tutta l’animalità e non soltanto all’umano, è comune in forme differenti, complesse, molteplici e mirabili.