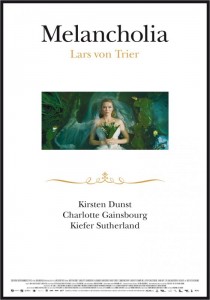La ragazza senza nome
(La fille inconnue)
di Jean-Pierre Dardenne e Luc Dardenne
Belgio, 2016
Con: Adele Haenel (Jenny), Olivier Bonnaud (Julien), Jérémie Renier (Vincent), Louka Minnella (Bryan)
Trailer del film
I dintorni di Liegi non sono un ambiente facile, tra miseria autoctona e miseria dei migranti, ma Jenny è appassionata del suo lavoro di medico, che svolge con cura e con il necessario distacco emotivo. Una sera, ad ambulatorio ormai chiuso da un’ora, qualcuno suona. Julien, collaboratore di Jenny, si alza per aprire ma lei gli dice che è tardi e che i pazienti «devono avere rispetto della nostra stanchezza». Quest’ordine è anche un modo «per imporsi» -come lei stessa ammetterà- su Julien, semplice studente di medicina. Il giorno dopo la polizia chiede a Jenny i filmati della videocamera di sicurezza, perché una ragazza è stata trovata morta nei dintorni. È la stessa persona che aveva suonato all’ambulatorio. Non ha documenti, viene seppellita senza nome. Jenny è sconvolta e inizia una sua tenace ricerca dell’identità di questa morta.
C’è qualcosa di profondo, ancestrale, biologico, metafisico nel senso di colpa che attanaglia gli umani. Tutte le religioni nascono di fatto da tale sentimento, espresso con il racconto di una caduta originaria da uno spaziotempo senza il male. Le spiegazioni soltanto psicologiche, sociologiche, culturali, di questa tonalità emotiva e metafisica rimangono incapaci di coglierne la vastità, l’universalità e il significato.
Lo stile asciutto e insieme colmo di pietà dei fratelli Dardenne riesce a esprimere due elementi della colpa.
Il primo è la convinzione di essere sempre noi i facitori delle nostre azioni. Anche se Jenny non ha nessuna responsabilità in ciò che è accaduto, se ne assume per intero la colpa, convinta che sarebbe bastata una sua piccola azione -aprire la porta- per evitare la tragedia. Il film chiarisce bene, invece, che tutto è accaduto e tutto accade sempre per l’insieme di circostanze che definiamo casuali, imprevedibili, particolari, meschine, ambientali e il cui intreccio contribuisce a formare ciò che chiamiamo Necessità. L’Ananke è in gran parte questo, è il convergere in ogni istante della vita individuale e collettiva di una miriade di cause che precedono la nostra stessa nascita e sulle quali il nostro controllo è illusorio. Sarebbe più saggio «vedere nel mondo un gioco crudele e nei mutamenti il frutto del caso e della necessità congiunte, costituenti l’unica infinita trama delle cose. Negli eventi che sembriamo dominare come in quelli che ci vedono oggetti passivi delle circostanze» c’è «una innocenza primigenia che non esclude però, anzi rafforza l’oscura colpa complessiva dell’esistere. Il destino del saggio Edipo sta lì a testimoniarlo. Il re di Tebe non era affatto responsabile di ciò che aveva fatto e tuttavia la pena che lo colpisce è giusta. Edipo aveva ragione a dichiarare che non siamo colpevoli dei nostri sogni ma non lo siamo neanche della veglia. Nondimeno la pena, una qualche pena, punisce lecitamente le nostre innocenti passioni. Non c’è colpa, infatti, nell’albero che un fulmine colpisce eppure quel lampo, quella morte sono tanto naturali quanto il crescere delle foglie sui rami» (L’antropologia di Nietzsche, p. 179).
Il secondo elemento che questo film è capace di esprimere è il legame tra colpa e corporeità. Il fatto che dobbiamo morire -ironica, unica e paradossale certezza della vita- genera la domanda sul perché della morte e dunque il disperato bisogno che il nostro cervello sente di trovare una spiegazione all’impensabile, all’orrore, al nostro non essere più, diventare nulla, sparire. Si tratta di un’altra potente radice del sentimento religioso, legata ai limiti inaggirabili della corporeità che siamo. In questo film la dottoressa Jenny tocca continuamente dei corpi feriti, vecchi, convulsi, derelitti, gonfi. La colpa primordiale sta nell’essere corpo. È del tutto conseguente che divieti, tabù, regole e consuetudini morali riguardino nella quasi totalità l’uso dei corpi.
Il corpo mostra con implacabile potenza tutti i nostri limiti.
L’intreccio degli eventi mostra con inesorabile potenza tutti i nostri limiti.
Su questi scogli si infrange l’illusione del libero arbitrio e su questi scogli naufraga la vanità umana. «Un’umanità il cui sentimento fondamentale è e rimane quello per cui l’uomo è l’essere libero nel mondo della necessità, l’eterno taumaturgo, sia che agisca bene, sia che agisca male, la sorprendente eccezione, il super-animale, il quasi-Dio, il senso della creazione, il non pensabile come inesistente, la parola risolutiva dell’enigma cosmico, il grande dominatore della natura e dispregiatore di essa, l’essere che chiama la sua storia storia del mondo! Vanitas vanitatum homo» (Nietzsche, Umano, troppo umano II, af. 12, in ‘Opere’ IV/3, Adelphi 1967, p. 141).