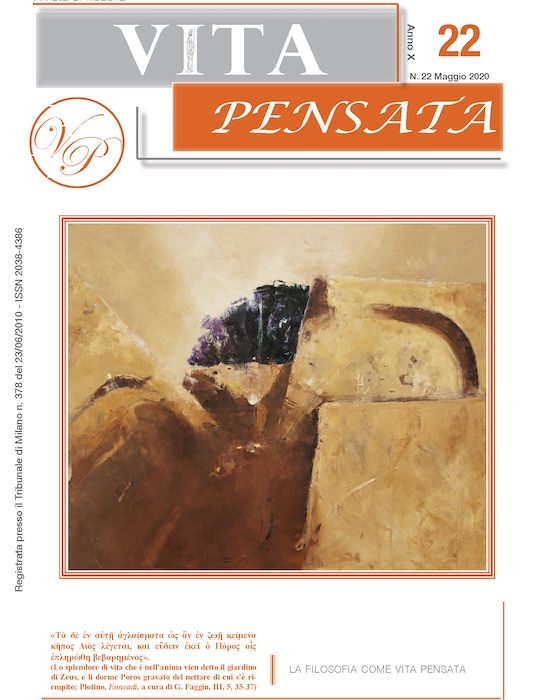Savoca / Ungaretti
in Vita pensata, numero 22, maggio 2020
pagine 94-95
A un secolo da Allegria di Naufragi Giuseppe Savoca propone una lettura di Ungaretti che da quel libro rivoluzionario si dispiega verso una comprensione non soltanto dell’intero itinerario del poeta ma della poesia in quanto tale.
La poesia è infatti, nella sua essenza, musica. E Ungaretti è stato uno dei maggiori musicisti italiani del Novecento. La sua Difesa dell’endecasillabo, provenendo da chi frantumandolo aveva creato un nuovo ritmo per le parole, è significativa della potenza che questo particolare verso ha nella nostra lingua. Una potenza che percorre per intero Sentimento del tempo. Quest’ultima parola – tempo – è tra le fondamentali di Ungaretti. Assimilata da uno dei suoi maestri e ispiratori, Bergson, la realtà del tempo è nei suoi versi e nella sua vita pervasiva e totale poiché «lo spirito umano non è se non tempo», come una volta Ungaretti disse.
L’intera opera di questo poeta è musica ed è tempo. Un solo esempio: il Recitativo di Palinuro.
Per l’uragano all’apice di furia
Vicino non intesi farsi il sonno;
Olio fu dilagante a smanie d’onde,
Aperto campo a libertà di pace,
Di effusione infinita il finto emblema
Dalla nuca prostrandomi mortale.
Avversità del corpo ebbi mortale
Ai sogni sceso dell’incerta furia
Che annebbiava sprofondi nel suo emblema
Ed, astuta amnesia, afono sonno,
Da echi remoti inviperiva pace
Solo accordando a sfinitezze onde.
Non posero a risposta tregua le onde,
Non mai accanite a gara più mortale,
Quanto credendo pausa ai sensi, pace;
Raddrizzandosi a danno l’altra furia,
Non seppi più chi, l’uragano o il sonno,
Mi logorava a suo deserto emblema.
D’àugure sciolse l’occhio allora emblema
Dando fuoco di me a sideree onde;
Fu, per arti virginee, angelo in sonno;
Di scienza accrebbe l’ansietà mortale;
Fu, al bacio, in cuore ancora tarlo in furia.
Senza più dubbi caddi né più pace.
Tale per sempre mi fuggì la pace;
Per strenua fedeltà decaddi a emblema
Di disperanza e, preda d’ogni furia,
Riscosso via via a insulti freddi d’onde,
Ingigantivo d’impeto mortale,
Più folle d’esse, folle sfida al sonno.
Erto più su più mi legava il sonno,
Dietro allo scafo a pezzi della pace
Struggeva gli occhi crudeltà mortale;
Piloto vinto d’un disperso emblema,
Vanità per riaverlo emulai d’onde;
Ma nelle vene già impietriva furia
Crescente d’ultimo e più arcano sonno,
E più su d’onde e emblema della pace
Così divenni furia non mortale.
(da «La Terra Promessa», Vita d’un uomo. Tutte le poesie, Meridiani Mondadori 1977, pp. 250-251)
Ungaretti moriva esattamente cinquant’anni fa, il 2 giugno 1970, a Milano. Ma il suo canto risuona, attraversa, splende.