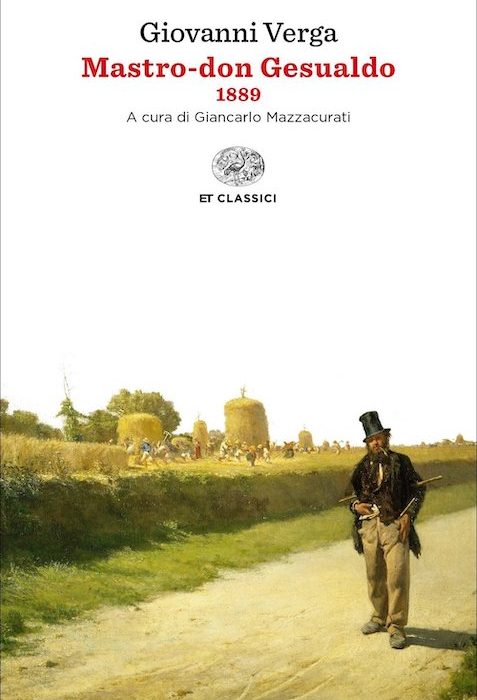Perfect Days
di Wim Wenders
Giappone-Germania, 2023
Con: Kôji Yakusho (Hirayama), Arisa Nakano (Nika), Tokio Emoto (Takashi)
Trailer del film
I giorni perfetti della solitudine. I giorni di un uomo che nel gomitolo urbano di Tokyo si alza prima dell’alba, ripone il suo letto in un angolo, annaffia le piantine che conserva con cura, si prepara, compra una lattina di caffè e va a pulire i gabinetti pubblici della città, accompagnando il viaggio in auto con l’ascolto di vecchie cassette audio. Le canzoni sono degli anni Settanta e Ottanta, probabilmente quelle più amate da Wim Wenders. Finito il lavoro, si lava ai bagni pubblici (pulitissimi), a volte fa una passeggiata in bici, la sera va a mangiare qualcosa in due diversi locali, uno più intimo e più familiare.
Regolarmente ritira le foto scattate con una vecchia macchina analogica e consegna nuovi rullini. Hirayama fotografa soprattutto gli alberi, il vento tra gli alberi, i raggi di sole che improvvisamente e serenamente si mostrano tra le foglie. Un fenomeno irripetibile e casuale, per il quale in italiano non esiste una specifica parola e che in giapponese si dice Komorebi, termine composto dai caratteri kanji per albero (木), splendore (漏れ) e sole (日). Prima di addormentarsi legge alcune pagine di un libro. Così tutti i giorni.
A condividere questa solitudine è un barbone che disegna figure con il proprio corpo; a infrangerla e a disturbarla è invece un giovane compagno di lavoro chiacchierone e approfittatore. Si aggiunge poi l’arrivo di una nipote in fuga dalla famiglia. Dalla sua presenza e poi dal suo tornare a casa, prelevata dalla madre, veniamo a sapere solo indirettamente che Hirayama appartiene a una ricca famiglia, dalla quale si è allontanato per ragioni a noi sconosciute.
Una sera viene cercato dall’ex marito della signora presso cui cena, con il quale si chiede se due ombre sovrapposte risultino per questo più scure. I due uomini cominciano un gioco con le ombre per verificarlo. Nella scena conclusiva il volto di Hirayama sorride e riflette mentre va ancora una volta al lavoro.
Un proverbio latino recita O beata solitudo, o sola beatitudo. Una beata solitudine come condizione della gioia. E questo nel gioco di oscurità e luce che sono i giorni umani, le ombre, komorebi.