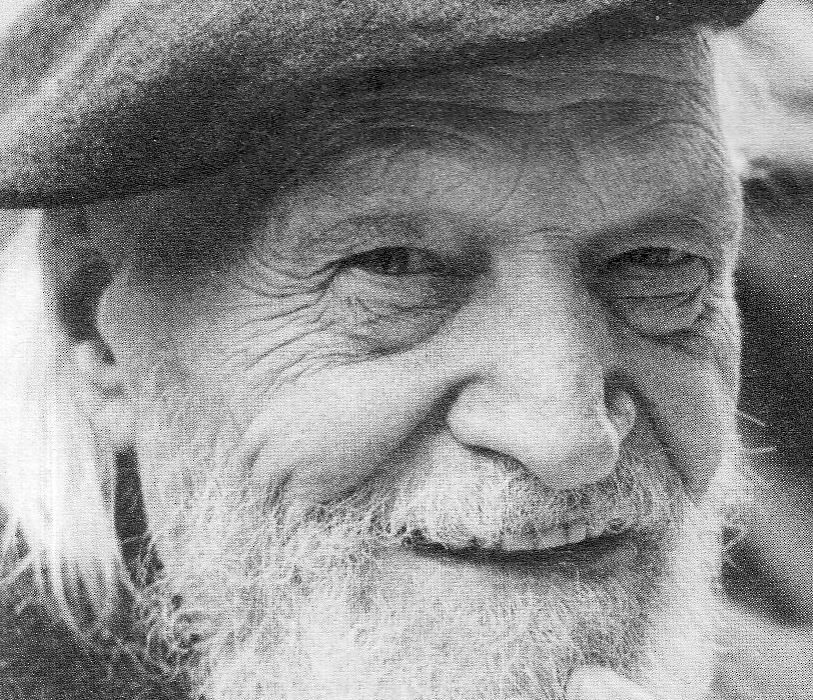Cascina Linterno – Milano
Framarin – Barbera
La qualità di una città si misura anche da come appaiono e vivono i quartieri lontani dal centro, al di là dunque dei palazzi più o meno in buon ordine e lustrinati delle zone maggiormente frequentate dai turisti e dagli stessi residenti. La Cascina Linterno si trova certamente alla periferia di Milano, per secoli è stata parte di una zona agricola, fu anche abitata da Francesco Petrarca durante i suoi soggiorni in Lombardia e forse anche a questo si deve il fatto che non sia stata travolta e distrutta dal delirio edificatorio-industriale che nel Novecento ha trasformato Milano da città d’acque a città di fabbriche. Fabbriche che adesso sono sparite nel processo di deindustrializzazione e di impoverimento dell’intero Paese, nella fasulla smaterializzazione delle società occidentali.
La qualità di vita a Milano, che nonostante tutto sopravvive, è confermata anche da come questo spazio viene preservato, vissuto e reso luogo di cultura viva. Assai bello e dinamico è stato infatti un evento musicale che lo scorso 22 giugno si è svolto nella piccola cappella della Cascina (evento previsto nel cortile – assai più ampio – ma che a causa del tempo che minacciava pioggia è stato spostato all’interno). Due giovani musicisti e compositori sono riusciti a portare la musica del Novecento e del presente in un luogo antico e tra un pubblico non particolarmente specializzato. Selene Framarin (clarinetto) e Lorenzo Barbera (percussioni) hanno eseguito con abilità e passione brani di Chick Corea, Edward Knigth, Gene Koshinski, Nick Heilborn, Steve Reich, di Arcangelo Corelli e dello stesso Barbera.
Il brano di Reich Clapping music viene eseguito senza strumenti ma con quello strumento del tempo e del suo battere che è il corpo umano. La composizione di Barbera prevede, insieme al body percussion, l’utilizzo di una palla da basket. Il brano più completo e catturante sono state le variazioni di Framarin-Barbera sul tema della Follia di Arcangelo Corelli (Sonata op. 5, n. 12). Elaborazioni pensate per il clarinetto e per una varietà di strumenti percussivi che hanno trasmesso l’emozione del ritmo che si fa sentimento, discorso, meditazione, potenza.
Sono riuscito a trovare un solo video nel quale Selene Framarin esegue in parte tali elaborazioni ma lo fa soltanto al clarinetto: https://www.youtube.com/watch?v=6s1wAdwePBQ. L’esecuzione alla Cascina Linterno è stata molto più ricca e coinvolgente, confermando, appunto, come le città siano vive quando sono vive le loro periferie.