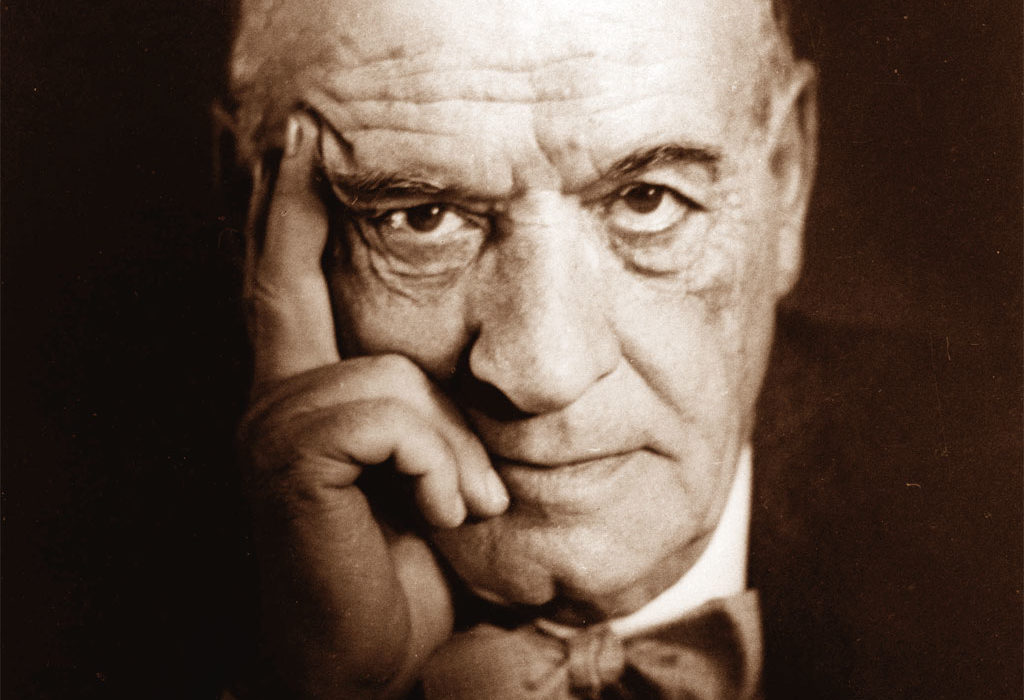Le democrazie contemporanee sono ridotte alla condizione di oligarchie finanziarie tenute in piedi dalla distribuzione di profitti a ben precise organizzazioni -tramite le strutture dell’economia legale e criminale- e da un apparato mediatico assolutamente ferreo, il quale presenta come universali, giuste e indiscutibili delle discutibilissime e strumentali espressioni ideologiche quali i diritti dell’uomo e il connesso gergo del politicamente corretto. I segnali linguistici di tale tendenza sono assai numerosi. Un esempio molto chiaro è la scomparsa della parola «sfruttati», sostituita da termini quali «esclusi, sfavoriti, ultimi» e soprattutto «discriminati». Mentre lo sfruttamento implica la critica a un ben preciso sistema produttivo e rapporto di produzione, i termini psicologistici e sociologici che lo hanno sostituito rimandano invece a una vaga e quindi innocua forma della morale (si comprende meglio, tra l’altro, quanta ragione avesse Nietzsche nel volere andare al di là del bene e del male).
La natura autoritaria del discorso politico e mediatico costruito su tali fondamenta arriva al suo vertice nella trasformazione dei sistemi elettorali da semplici metodi di amministrazione della volontà degli elettori a strutture ontologiche il cui obiettivo sarebbe una «governabilità» diventata l’altro nome -il nome soft– della dittatura. Ha ragione Marco Tarchi a iniziare una sua lucida analisi (dal significativo titolo I malpensanti) ricordando che «qualunque studente del primo o secondo anno di una Facoltà di Scienze politiche sa che le leggi elettorali sono uno strumento per eccellenza manipolativo. Servono cioè, a seconda della formula che ne è alla base, a distorcere il rapporto fra la volontà degli elettori, espressa attraverso il voto a un candidato e/o a un partito, e l’esito delle loro scelte, ovvero la presenza nelle istituzioni di eletti che corrispondano alle loro opinioni ed aspettative» («Diorama letterario», n. 318, pp. 1-3).
Chi è consapevole che i sistemi elettorali della democrazia rappresentativa costituiscono gli aritmetici e raffinati strumenti del dominio antidemocratico, ha sostanzialmente due alternative: il rifiuto del metodo elettorale (è la tesi della tradizione anarchica) o il voto dato alle formazioni che difendono esplicitamente la democrazia diretta e il controllo sugli eletti, formazioni che il mainstream mediatico liberista stigmatizza con la qualifica di «populisti». Una parola, quest’ultima, dal significato semplicemente descrittivo -analoga a termini quali «conservatori, socialisti, liberali, anarchici, comunisti»- e che invece ha assunto connotati valutativi e addirittura spregiativi. Il populismo viene definito antipolitico mentre è evidente che si tratta di una opzione politica come le altre e anzi volta a restituire significato ai diritti del demos ponendosi contro lo strapotere delle strutture amministrative e di governo, tese soltanto a blindare il potere di cerchie ristrette e tendenti all’autoperpetuazione dei privilegi acquisiti in decenni di espropriazione della democrazia dal basso.
La tendenza a criminalizzare le posizioni politiche distanti dagli assetti di governo attualmente imperanti in Europa si fa sempre più pericolosa poiché tocca il cuore stesso della libertà, che è il diritto di parola, di critica, di distanza dalle idee dominanti. Può sembrare un ossimoro e invece è la descrizione forse più adeguata degli eventi: quella in cui viviamo è e va sempre più diventando una dittatura liberale.
[Photo by Randy Colas on Unsplash]