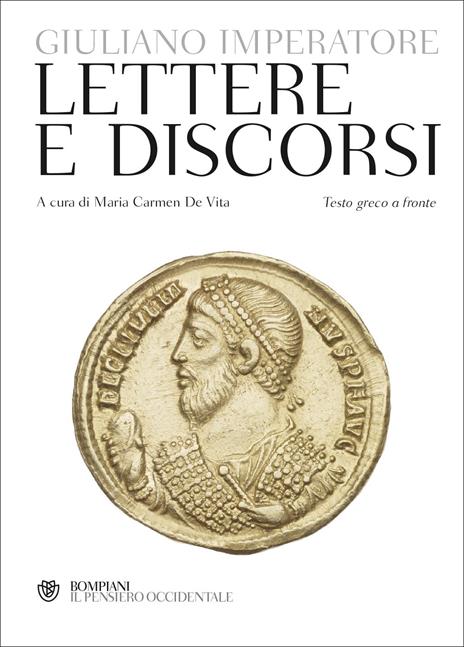Teatro Greco- Siracusa
Aiace
di Sofocle
traduzione di Walter Lapini
con Luca Micheletti (Sofocle), Daniele Salvo (Odisseo), Diana Manea (Tecmessa), Teucro (Tommaso Cardarelli)
scene e luci di Nicolas Bovery
musiche di Giovanni Sollima
regia Luca Micheletti
Sino al 7 giugno 2024
A differenza di altre esperienze siracusane a teatro, Aiace è una tragedia che non rinuncia al buio dell’ora successiva al tramonto ma lo accompagna e se ne riempie poiché tale buio è l’unica luce rimasta per l’eroe sconvolto dall’ira sino a invocare le «venerabili Erinni» affinché possano vendicare l’offesa sprezzante che gli Atridi e Odisseo hanno compiuto sottraendo le armi di Achille a colui il quale, se l’eroe avesse potuto decidere, sarebbero state destinate, ad Aiace, il più forte dei guerrieri achei dopo Achille, il più valoroso, l’invincibile. Le armi sono invece andate a Odisseo, il quale rimane sempre presente al confine della scena quando protagonista è la compagna di Aiace Tecmessa che racconta al Coro quanto è accaduto all’eroe, quasi a volere confermare con la sua permanenza la sorte comune e misera che anche a lui, in quanto mortale, è destinata.
L’inganno e l’offesa subita scatenano la μῆνις di Aiace, l’ira, la vendetta, il rancore. E scatenano insieme alla μῆνις la follia e la furia che avrebbero portato l’eroe a far strage dei Greci suoi compagni se non fosse intervenuta Atena a indirizzare la violenza del guerriero contro delle pecore, contro dei buoi, creduti invece da Aiace umani ai quali infliggeva dolore e dava la morte. Il velo di sangue che copre la scena e nasconde i cadaveri degli agnelli e dei buoi squartati partorisce anche Aiace che fa il suo ingresso proprio da quello stesso ventre di lamento e di sangue.
Quando il guerriero si sveglia dalla furia che lo ha sconvolto, si accorge di essere diventato lo zimbello dei Greci. È stato toccato il suo onore, perdere il quale è una condizione intollerabile in una civiltà della vergogna e non della colpa, qual è la Grecia antica. Sentono, sentono i suoi soldati le urla strazianti e orribili di Aiace. Si impossessa dei cuori di tutti la paura, il terrore, altra violenza, l’arcaismo di sentimenti primordiali e non controllabili. A rischiare di diventare folli sono tutti e non soltanto l’eroe.
«Quale turbine di orrori mi vortica intorno» dichiara Aiace. E più volte, come fa il colonnello Kurz di Cuore di tenebra, ripete il suo «l’orrore, l’orrore». Una condizione che è frutto non soltanto dell’inganno di Odisseo ma anche e specialmente della ὕβρις di Aiace, del suo vantarsi nei confronti di Atena e di Ares di poter sconfiggere i nemici anche senza la loro protezione e il loro aiuto. Non possono gli dèi tollerare una tale protervia, poiché vale sempre – è regola inscalfibile del mondo greco – che, come afferma Odisseo, «il ridere e il piangere degli umani dipendono solo dagli dèi».
Alla fine accade ciò che deve accadere e la scena viene occupata dall’enorme scheletro di Aiace che si è conficcato la propria spada nel petto. Perché se, come lui stesso afferma, «il tempo porta luce là dove era ombra e ombra dov’era la luce» – e dunque se il tempo è Differenza – è anche vero, come ancora Aiace dichiara, che «la natura di un uomo è immodificabile», Identità. L’identità di guerriero che gli ha reso intollerabile il vivere ancora.
La rappresentazione di tutto questo a Siracusa è stata coinvolgente e corretta. Corretta perché la scena, cosparsa ovunque di sangue e di carcasse di animali uccisi, riesce a trasmettere la struttura arcaica e tribale della tragedia, di questa di Sofocle ma non soltanto di essa. Coinvolgente perché il regista/interprete Luca Micheletti e il compositore Giovanni Sollima hanno tentato di restituire la natura di Gesamtkunstwerk della drammaturgia greca, il suo essere quindi non soltanto un testo recitato – come nel moderno teatro borghese – ma una rappresentazione fatta anche di musica, movimenti coreutici, canto. Un’opera d’arte totale. E le musiche di Sollima rispettano l’andamento ritmico del testo, pur tradotto in italiano.
La musica è protagonista di questa rappresentazione siracusana, musica che assurge al compito nietzscheano di una influenza «veramente rispondente» nella quale «immagine e concetto acquistano un accresciuto significato». Essa infatti «spinge all’intuizione simbolica dell’universalità dionisiaca, e in secondo luogo la musica fa risaltare l’immagine simbolica in una suprema significazione» (Nietzsche, La nascita della tragedia, Adelphi 2011, § 16, p. 110). Che siano percussioni, archi o strumenti a fiato, che facciano vibrare l’aria insieme o singolarmente, essi riempiono lo spazio e le immagini che si lasciano così vedere meglio e più a fondo. La rappresentazione mostra assai chiaramente come a essere centrale, alla fine, non è la morte di Aiace ma il destino ineluttabile che appartiene a tutti, come saggiamente ci ricorda quello scheletro imponente presente sulla scena.
L’enorme scheletro di Aiace che occupa tutta la parte finale della rappresentazione è infatti lo scheletro del nulla umano. Ma non è soltanto questo. È, senza averlo voluto, anche qualcosa di più contingente e miserabile. Il Teatro di Siracusa era infatti pieno. Pieno anche e specialmente di scolaresche. E quindi di adolescenti, o poco più, che hanno mostrato via via tutta la loro insofferenza nei confronti di ciò a cui erano costretti ad assistere. E per questo bisbigliavano, chiacchieravano, interrompevano di continuo con degli applausi anche mentre gli attori recitavano.
Guardavo le posture degli studenti, evidentemente e somaticamente a disagio. Perché infliggere a queste persone un simile tormento? Che diventa un’altra domanda: è corretto pagare biglietti dal costo anche assai alto per uno spettacolo continuamente disturbato e interrotto in questo modo? La responsabilità non è degli studenti, o non è soltanto loro. È anche e specialmente dei loro educatori, o presunti tali, dei loro professori che non esitano a costringere le scolaresche (in gita in Sicilia ma anche autoctone) ad assistere a una espressione di profondità e radicalità antropologica e metafisica alla quale questi adolescenti sono evidentemente impreparati o, in ogni caso, ‘non è cosa loro’. Che stiano a casa a guardare Maria De Filippi e TikTok, che stiano in giro attaccati ai loro cellulari, al torrente di messaggi audio, al flusso di WhatsApp. Quello è il loro mondo, lì devono stare, lì si sentono e sono a proprio agio. Non davanti a un incomprensibile e per loro noiosissimo spettacolo di due ore su argomenti e dinamiche alle quali sono estranei come lo sarebbe un marziano.
Lo scheletro in scena è dunque anche quello del teatro, greco e non greco. È lo scheletro dell’Europa, i cui giovani cittadini sono interamente e totalmente immersi nella Stimmung barbarica che proviene da New York e non da Atene.