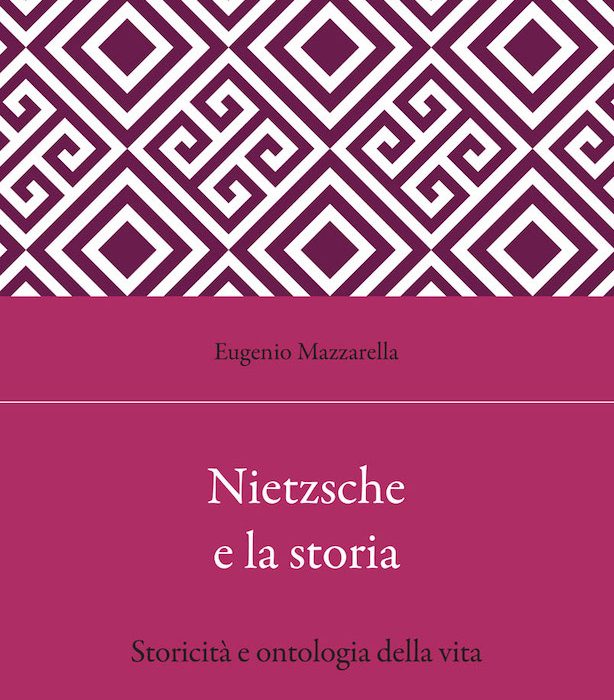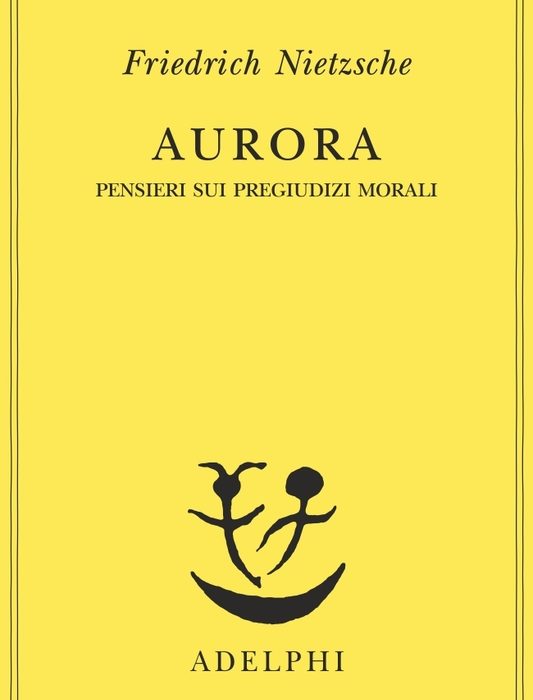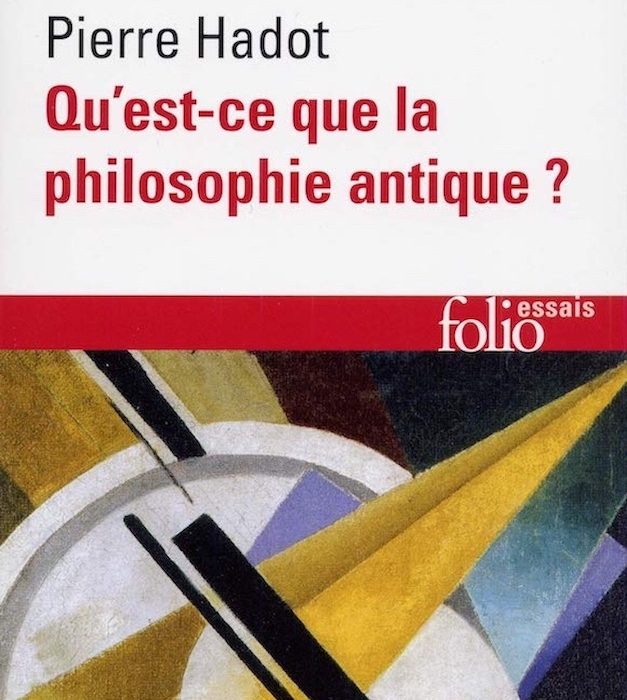
Pierre Hadot
Che cos’è la filosofia antica?
(Qu’est-ce que la philosophie antique?, Gallimard 1995)
Traduzione di Elena Giovannelli
Einaudi, 2010
Pagine 302
La filosofia è un modo di vivere all’interno di una comunità, nel dialogo, nel confronto, nel sentirsi esistere in una relazione continua con altri umani animati dalla stessa forma, passione, interesse, intenzione, vita. Non è necessario condividere sempre gli spazi ma sapere che quello che stiamo in questo momento vivendo, pensando, scrivendo, è condiviso dai desideri e dalla lucidità di altri filosofi. Lucidi come noi, strani come noi, indifferenti come noi. Un’indifferenza che significa almeno tre cose: consapevolezza dei limiti umani, della nostra infima misura dentro lo splendore e l’immensità dell’intero; disincanto nei confronti della condizione di dolore e di morte non soltanto dell’umano ma di tutto ciò che è vivo; metamorfosi di questo consapevole disincanto in azione, in opera, in trasformazione della vita propria e delle relazioni, dei legami, della politica.
Conoscenza e azione che si fondano su numerosi e vari presupposti teoretici, che nel mondo greco sono in particolare:
– L’essere ogni ente una parte dell’intero, un’espressione della potenza della materia generatrice, che sempre sorge da se stessa, dalla propria potenza, dall’energia universale, la Φύσις.
– Il coincidere di tale energia e potenza con ciò che tutte le culture chiamano il sacro, il quale non abita quindi in qualche luogo specifico, in un tempo altro, in una realtà lontana ma accade qui e ora, in ogni ente, evento e processo. La realtà stessa è sacra, tutta, come l’aneddoto eracliteo del focolare in cucina testimonia con semplicità.
– Ciò che chiamiamo male è l’ignoranza di questa energia pervasiva e sacra, nella quale e con la quale il mondo in ogni istante esiste; è anche per questo che l’etica è un’espressione dell’ermeneutica, perché «il male non è nelle cose, ma nel giudizio di valore che gli uomini attribuiscono alle cose» (p. 101).
– Ciò che chiamiamo bene è invece l’immersione consapevole in questa dinamica, qui e ora; non quindi l’aspirazione ad altre vite o l’inquietudine senza pace dei progetti più fantasiosi e irraggiungibili ma l’esistere nel presente. Non naturalmente il semplice presente fisico e matematico, infinitamente divisibile e anche per questo di fatto insussistente, ma il presente come percezione della durata e suo significato. Un presente semantico prima di tutto.
– La necessaria fiducia che tutto questo si possa comunicare, trasmettere, insegnare e in tal modo contribuire a formare altri umani, a plasmare altre vite a partire da ciò che il tempo sacro ha donato alla nostra, tale è la pratica della παιδεία.
– La necessità che tale pratica educativa sia sempre intramata e sostenuta dall’approccio teoretico e da prospettive universali che si sforzino di andare oltre la limitatezza dell’orizzonte storico e prassico di ogni individuo e di ciascuna comunità: «Senza questa riflessione, la vita filosofica rischia di cadere nella banalità o nell’insipienza, nei buoni sentimenti o nell’aberrazione. […] Vivere da filosofi significhi precisamente anche riflettere, ragionare, concettualizzare, in modo rigoroso e tecnico, ‘pensare in modo autonomo’ come diceva Kant. La vita filosofica è una ricerca che non si arresta mai» (269).
– L’accettazione dunque della natura asintotica della vita in generale e dell’esistere filosofico in particolare, vita ed esistere per loro natura sempre aperti e mai definitivi. Vivere significa precisamente questo incompiuto che in ogni suo momento è sempre realizzato.
– Il convergere di queste pratiche asintotiche e teoretiche verso l’enigma del tempo, il vero e proprio oceano il cui infinito movimento è definito allo stesso modo in un testo fondante quale la Teogonia di Esiodo (verso 38) e in una sentenza epicurea (la n. 10) attribuita a Metrodoro: «Ricorda che nato mortale, con una vita limitata, tu sei assurto, grazie alla scienza della natura, fino all’infinito dello spazio e del tempo e hai visto ciò che è, ciò che sarà, ciò che fu» (22).
La filosofia è quindi conoscenza e pratica del tempo infinito dentro il tempo limitato che siamo, è la consapevolezza che una parte della materia universale ha di esistere per un arco, una parabola, un percorso sempre limitati ma non per questo meno densi. Filosofia è diventare l’infinito che si è. È ciò che Ernest Renan definisce il «punto di vista di Sirio», la stella più luminosa che i nostri occhi di terrestri possano vedere.
Come i corpi hanno bisogno d’aria per vivere, la filosofia richiede la libertà come respiro. Questa è la principale ragione per la quale la filosofia nacque in Grecia e non altrove. Nell’Accademia di Platone vigeva una integrale libertà di pensiero, tanto che i suoi allievi e anche gli immediati successori alla guida della scuola espressero posizioni anche assai lontane dal Maestro, il più famoso tra questi è Aristotele. L’Accademia era infatti «un luogo di libera discussione e al suo interno non vigeva nessuna ortodossia specifica della scuola e nessun dogmatismo» (64).
Gli ultimi filosofi greci, cacciati via dal cristiano Giustiniano, trovarono nell’Oriente persiano, tra i nemici persiani, il luogo estremo nel quale esercitare ancora tutto questo. Nel 529 infatti «l’imperatore Giustiniano proibisce ai pagani di insegnare. I filosofi neoplatonici Damascio, Simplicio e Prisciano lasciano Atene per rifugiarsi in Persia. Dopo il trattato di pace concluso tra Cosroe e Giustiniano, essi si stabiliscono a Carrae, in territorio bizantino ma sotto influenza persiana, e continuano il loro insegnamento» (280), che ancora prosegue.
In questa sistole e diastole di esistenza e teoresi, di limite e di infinito, abitano il dolore e la gioia dell’essere filosofi.
«Il filosofo sperimenta in modo crudele la propria solitudine e la propria impotenza in un mondo lacerato tra due inconsapevolezze: quella che è provocata dall’idolatria del denaro e quella che risulta dalla miseria e dalla sofferenza di miliardi di esseri umani. In simili condizioni, il filosofo non potrà sicuramente mai raggiungere la serenità assoluta del saggio. Filosofare equivarrà, dunque, a soffrire di quell’isolamento e di quella impotenza. Ma la filosofia antica ci insegna anche a non rassegnarci, continuando invece ad agire ragionevolmente, e a sforzarci di vivere secondo la norma rappresentata dall’Idea della saggezza, qualsiasi cosa succeda, per quanto la nostra azione ci possa apparire molto limitata.
Come diceva Marco Aurelio:
‘Non sperare la Repubblica di Platone, ma accontentati se una cosa piccolissima progredisce, e pensa che questo risultato non è così piccolo’ » (270; Ricordi, 9.29.5).
Questo è la filosofia antica, questo è la filosofia.