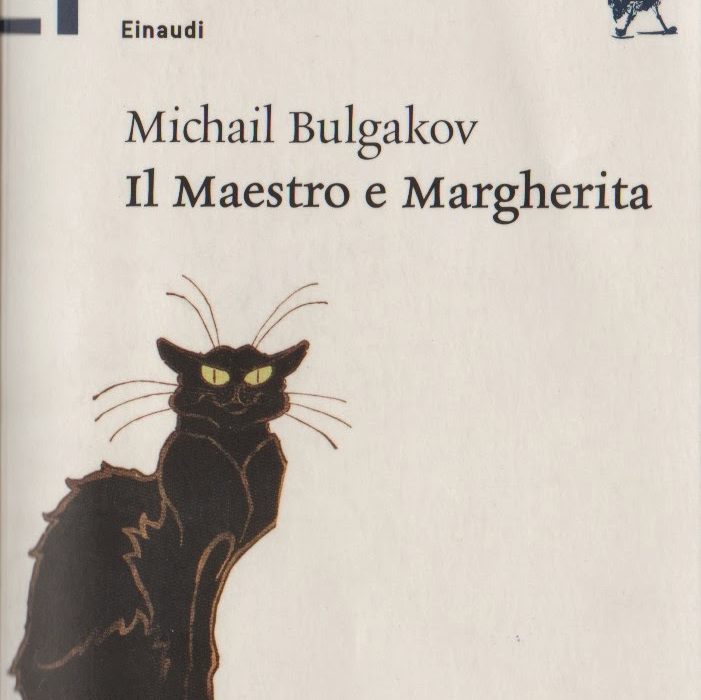
Il Maestro e Margherita
(Master i Margarita, 1940)
di Michail Bulgakov
Trad. di Vera Dridso
Einaudi, Torino 1996
Pagine 448
(Edizione Biblioteca di Repubblica)
Woland prende casa a Mosca negli anni Venti con il suo sèguito, composto dal fedele Korov’ev-Fagotto, dall’enorme gatto nero Behemoth, da Azazello, dalla strega Hella sempre nuda e da Abadonna, la nuda morte. Gli occhi di Woland sono la sua identità, perché «la lingua può nascondere la verità, ma gli occhi mai» (p. 188). E gli occhi di questo viaggiatore, consulente, mago, ipnotizzatore, artista, sono «una scintilla dorata, che avrebbe penetrato fin nell’intimo qualsiasi anima, il sinistro vuoto e nero, una specie di stretta cruna angolare, un orifizio nel pozzo senza fondo di tutte le tenebre e di tutte le ombre» (287).
Woland e i suoi assistenti organizzano uno straordinario spettacolo al Teatro di Varietà della capitale russa. In quella serata indimenticabile essi dimostrano di conoscere più di chiunque altro l’umanità, i suoi desideri, le passioni, l’ingenuità e la meschina avidità. Dopo quella serata lui e i suoi compagni causano incendi, prodigi, follie di ogni genere. Perché Woland è –come recita l’epigrafe dal Faust di Goethe- «una parte di quella forza che vuole costantemente il Male e opera costantemente il Bene»; infatti, «che cosa farebbe il tuo bene, se non esistesse il male? E come apparirebbe la terra, se ne sparissero le ombre? Le ombre provengono dagli uomini e dalle cose» (406).
Per il suo annuale ballo di gala, questa entità chiede di fare da padrona di casa a Margherita Nikolaevna, una donna bellissima e intelligente, che accetta l’invito solo perché ha compreso che in questo modo potrà di nuovo riavere l’uomo che ama con un trasporto totale e che l’invidia e la malvagità hanno ridotto a vivere in una casa di cura per malati di mente. Il Maestro che Margherita adora ha scritto una storia di Ponzio Pilato che non è piaciuta al potere comunista, che ha indotto l’Autore a tentare di bruciare il proprio manoscritto ma «nulla spariva, l’onnipotente Woland era davvero onnipotente» (337), tanto da restituire a Margherita il suo Maestro e al Maestro quella sua opera che è il vero, enigmatico, denso nucleo di questo romanzo di Bulgakov.
Il procuratore della Giudea sa bene che l’accusato che gli hanno posto davanti in quella mattina del giorno quattordici del mese di Nisan, quel «filosofo che aveva escogitato una cosa così incredibilmente assurda come la bontà universale degli uomini» (360), quell’ingenuo delinquente Jeshu-ha-Notzri, è innocente. Ma, per tante ragioni, non spinge la propria azione sino a salvarlo. Perché Pilato odia quell’orrenda fogna di fanatici che è Jerushalajim, perché è stanco di tutto, perché il Sinedrio tiene davvero alla morte di quello straccione, perché –soprattutto- è un poco vile. Ma quella condanna, di cui pure dichiara di lavarsi le mani, quella morte sul monte dietro la città, quella prova che «ogni potere è violenza sull’uomo», come Jeshua dichiara (35), non abbandoneranno più la sua vita e i suoi pensieri. L’Hanozri e il procuratore staranno sempre insieme -«se parleranno di me, parleranno subito anche di te!» (361) e questa immortalità, questa gloria senza tramonto, questa continua rimemorazione del suo nome nelle chiese di tutto il mondo, saranno parte della condanna di Pilato.
Ma proprio Margherita e il suo Maestro daranno a Pilato la pace, liberandolo dal suo destino di sogni e di incubi, di immobilità e di memoria, di aridi e sempre uguali pleniluni…«così parlava Margherita…e la memoria del Maestro, l’inquieta e martoriata memoria del Maestro cominciò a spegnersi. Qualcuno lo lasciava libero, come poco prima egli aveva lasciato libero l’eroe da lui creato. Questo eroe era scomparso, era scomparso irrevocabilmente, perdonato nella notte fra il sabato e la domenica, il figlio del re astrologo, il crudele quinto procuratore della Giudea, il cavaliere Ponzio Pilato» (432-433), il vero protagonista di questo inquietante, ironico, struggente e magnifico romanzo.


