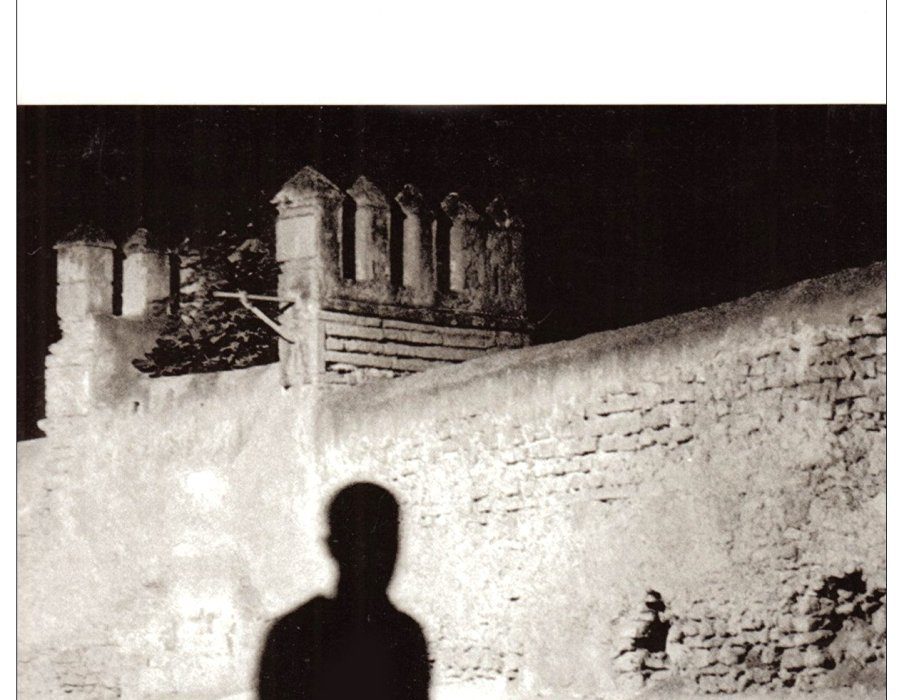Il risentimento.
Lo scacco del desiderio nell’uomo contemporaneo
(Pour un nouveau procés de l’étranger; Système du délire, Éditions Grasset 1976; Eating disorders and Mimetic Desire, 1996)
di René Girard
Trad. di Alberto Signorini
Introduzione di Stefano Tomelleri
Raffaello Cortina Editore, 1999
Pagine XI-188
 Il risentimento, smascherato anche da Nietzsche, non sarebbe secondo Girard un sentimento opposto alla volontà di potenza ma consisterebbe nella stessa volontà che vuole raggiungere il proprio modello e non riuscendoci lo condanna. «Desiderio di essere secondo l’altro» (p. 2), secondo un modello ammirato, amato e odiato poiché «l’altro è anche il nostro maggior rivale, perché sarà sempre laddove vorremmo essere e non siamo» (3). L’io e l’altro, l’imitatore e l’imitato, convergono sul medesimo oggetto entrando quindi in una rivalità mimetica che per il primo è sempre esiziale. Dato che è proprio tale convergenza dei desideri a definire l’oggetto terzo, «la mimesi costituisce una fonte inesauribile di rivalità di cui non è mai veramente possibile fissare l’origine e la responsabilità» (96). Questo è il desiderio mimetico che Girard pone a fondamento del Moderno e delle tre sue manifestazioni analizzate in questo libro: l’apparente indifferenza dello Straniero verso la società; le macchine desideranti di Deleuze e Guattari; le pratiche anoressiche.
Il risentimento, smascherato anche da Nietzsche, non sarebbe secondo Girard un sentimento opposto alla volontà di potenza ma consisterebbe nella stessa volontà che vuole raggiungere il proprio modello e non riuscendoci lo condanna. «Desiderio di essere secondo l’altro» (p. 2), secondo un modello ammirato, amato e odiato poiché «l’altro è anche il nostro maggior rivale, perché sarà sempre laddove vorremmo essere e non siamo» (3). L’io e l’altro, l’imitatore e l’imitato, convergono sul medesimo oggetto entrando quindi in una rivalità mimetica che per il primo è sempre esiziale. Dato che è proprio tale convergenza dei desideri a definire l’oggetto terzo, «la mimesi costituisce una fonte inesauribile di rivalità di cui non è mai veramente possibile fissare l’origine e la responsabilità» (96). Questo è il desiderio mimetico che Girard pone a fondamento del Moderno e delle tre sue manifestazioni analizzate in questo libro: l’apparente indifferenza dello Straniero verso la società; le macchine desideranti di Deleuze e Guattari; le pratiche anoressiche.
«Posseduto dall’assurdo come certuni […] sono posseduti dalla grazia» (29-30), Mersault -il protagonista del romanzo di Camus- incarnerebbe la malafede del suo creatore, il quale «ha finito prima di tutto per ingannare se stesso» (52) sulla possibilità che si dia un uomo allo stesso tempo colpevole e innocente. Colpevole agli occhi di chi non gli perdona non di aver assassinato uno sconosciuto ma di nutrire una sovrana indifferenza verso la collettività, innocente quindi dell’assassinio del quale lo si accusa. Lo stesso Camus ammetterebbe tale (auto)inganno nel successivo romanzo La caduta, che costituirebbe una vera e propria autocritica nella quale lo scrittore riconosce per bocca di Clamence che «i “buoni criminali” hanno ucciso non per le ragioni abituali, questo salta agli occhi, ma perché volevano essere giudicati e condannati. Clamence ci dice che in fin dei conti i loro moventi erano identici ai suoi: come molti dei nostri simili in questo mondo anonimo, volevano un po’ di notorietà» (50).
La stessa notorietà/competizione/rivalità che anima la bulimia nervosa e l’anoressia. Un vero e proprio imperativo di magrezza domina infatti l’immaginario collettivo della contemporaneità. Un ordine assai più implacabile di quello delle vecchie religioni e del defunto Dio. Pervenuti finalmente alla terra della nostra autonomia senza divieti e senza leggi, «le divinità che diamo a noi stessi sono autoprodotte nel senso che dipendono interamente dal nostro desiderio mimetico» (167) e i loro comandi sono assoluti perché anch’essi autoprodotti. Nessuno può dunque convincere l’anoressica della sua malattia; lei «è orgogliosa di adempiere a quello ch’è forse il solo e unico ideale ancora condiviso da tutta la nostra società: la magrezza» (160). Notevole ed esemplificativa dello stile dell’Autore è l’immagine che chiude l’analisi dei disturbi alimentari:
Se i nostri avi vedessero i cadaveri gesticolanti delle riviste di moda contemporanea, li interpreterebbero probabilmente come un memento mori, un promemoria di morte, equivalente forse alle danze macabre dipinte sui muri delle chiese del tardo Medioevo; se dicessimo loro che, per noi, questi scheletri disarticolati significano piacere, felicità, lusso, successo, è probabile che fuggirebbero in preda al panico, pensando che siamo posseduti da un demone particolarmente ripugnante. (188)
Il demone del desiderio, della volontà di potenza, del delirio intesse per Girard anche L’Anti-Edipo di Deleuze e Guattari. Un delirio teoretico e analitico che rimane impregnato di Freud e dal quale Edipo esce in realtà intatto, soprattutto perché distrugge il desiderio stesso che pure proclama di installare come autorità maiestatica, come fondamento molecolare delle strutture molari liberate. Il desiderio concreto e quotidiano, con il suo inevitabile attrito, sembra infatti in quest’opera dissolto a favore di una “schizoanalisi” che lascia intatta la Legge che pur si illude di avere oltrepassato:
I divieti sono sempre lì; bisogna convincersi che attorno a essi vigila un’armata potente di psicoanalisti e di curati, mentre dappertutto ci sono solo uomini smarriti. Dietro i rancori guasti contro le vecchie lune dei divieti si nasconde il vero ostacolo, quello che si è giurato di non confessare mai: il rivale mimetico, il doppio schizofrenico. (149-150)
Dove sbaglia Girard?
L’esatta critica al romanticismo, alla sua hybris che invece di liberare il soggetto lo ha catturato in un’infrangibile rete di elefantiasi dell’io -«il romantico non vuole veramente essere solo, vuole che lo si veda scegliere la solitudine» (59)-, assume Lo straniero come paradigma romantico, sbagliando però del tutto lettura. Il romanzo di Camus non è infatti espressione e specchio «del mondo del giovane delinquente» (74), della sua esistenza vuota, della sua crudeltà solipsistica. È questa un’interpretazione sociologica che si preclude per intero non soltanto e non tanto la ricchezza stilistica ed estetica del libro -senza la quale esso sarebbe impensabile- ma anche e soprattutto il nucleo generatore del romanzo, che è la Gnosi. Leggiamo Camus: «si près de la mort, maman devait s’y sentir libérée et prêtre à tout revivre. Personne, personne n’avait le droit de pleurer sur elle. Et moi aussi, je me suis senti prêt à tout revivre» (L’étranger, Gallimard, Paris 2011, p. 183); è tale volontà di eterno ritorno a meritare eventualmente la condanna, poiché «tout le monde sait que la vie ne vaut pas la peine d’être vécue» (ivi, p. 171). Lo sanno tutti, e in primo luogo lo sanno gli gnostici, e tuttavia Mersault ama vivere. Il titolo della successiva presunta autocritica dello scrittore, La caduta, è anch’esso un titolo gnostico.
Nietzsche rappresenta per Girard un vero e proprio doppio mimetico, se vogliamo applicare allo stesso studioso il linguaggio da lui adottato. Il concetto di ressentiment è infatti nietzscheano ma per Girard la critica radicale di Nietzsche alla Legge ebraico-cristiana sarebbe anch’essa intrisa di risentimento. Questo desiderio di distanziarsi da Nietzsche fa sì che Girard confonda la volontà di potenza con il desiderio. È eventualmente quest’ultimo a costituire il «colosso dai piedi d’argilla» che crolla davanti alla fuga dell’alterità tanto bramata:
Ci sono certamente delle ritirate tattiche che il desiderio non fatica a scoprire e che lo riconfortano, ma c’è anche la sincera e assoluta indifferenza degli altri esseri: nemmeno invulnerabili, semplicemente affascinati da qualcos’altro. La volontà di potenza porrà sempre al centro del mondo tutto ciò che non riconosce in essa il centro del mondo, e le riserverà un culto segreto. Non mancherà mai, insomma, di volgersi in risentimento. (99)
Ma la volontà di potenza è altro. È un’ontologia e una epistemologia dell’altrove, che in quanto tale non può concepire alcun risentimento: «Io sono troppo pieno e così dimentico me stesso, tutte le cose sono dentro di me e non vi è null’altro che tutte le cose. Dove sono finito io?» (Così parlò Zarathustra, variante al § 4 della Prefazione, p. 423, dell’edizione Adelphi delle opere). L’io non vuole più imitare né dominare il mondo poiché è diventato una cosa sola con esso.
Né solipsistico, né anticonformista, né minimalistico, l’io/mondo di Nietzsche è libero dalle contraddizioni e dalle strette di un «pensiero della differenza pura, senza identità» (145). La totalità pagana di corpo/mente/mondo -totalità che rappresenta il vero bersaglio dell’opera, di tutta l’opera, di Girard- non è il modello delle sindromi contemporanee. Girard sostiene che «i nostri disturbi alimentari non hanno alcuna continuità con la nostra religione: nascono nel neopaganesimo del nostro tempo, nel culto del corpo, nella mistica dionisiaca di Nietzsche, che fra parentesi è stato il primo dei nostri grandi digiunatori. I nostri disturbi alimentari sono causati dalla distruzione della famiglia e delle altre reti protettive che fanno fronte alle forze della frammentazione mimetica e della competizione, scatenate dalla fine dei divieti» (168). Ma la corporeità pagana è forma ed espressione dell’ironica serenità che nasce dalla misura e dall’accettazione della finitudine. Porla all’origine delle manifestazioni contemporanee dell’industria culturale e dell’ordine imitativo delle star spettacolari -dalla principessa Sissi alle attrici hollywoodiane- è semplicemente errato. Il doppio nietzscheano, il risentimento «che l’imitatore prova nei confronti del suo modello allorché questi ostacola i suoi sforzi per impossessarsi dell’oggetto sul quale entrambi convergono» (X), fa cadere anche Girard nella sindrome che egli denuncia.