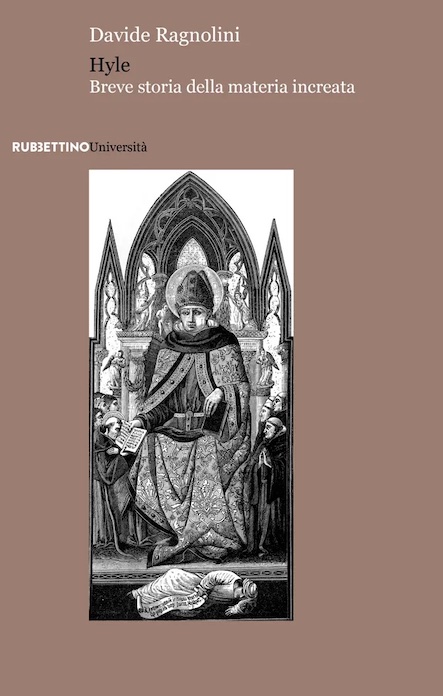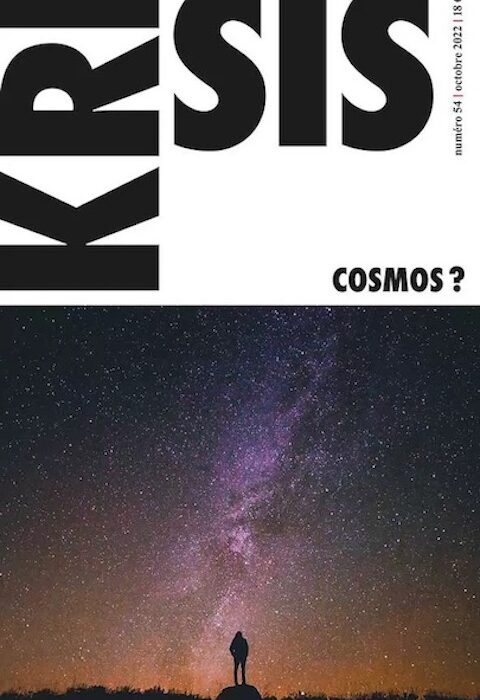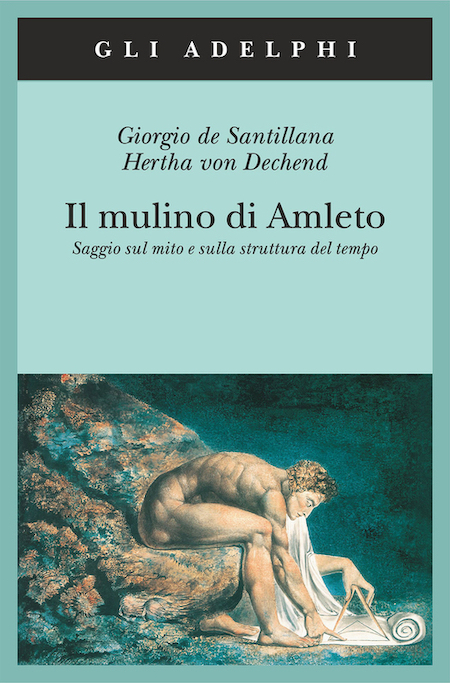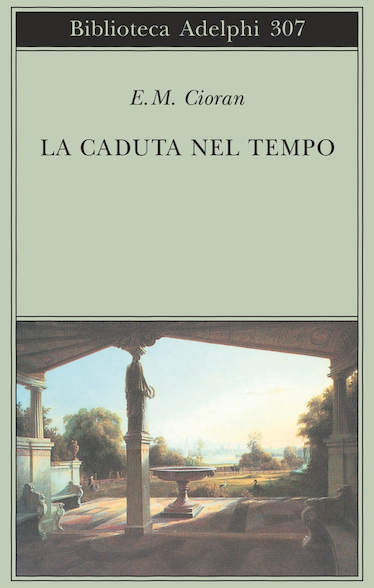James Lee Byars
Hangar Bicocca – Milano
A cura di Vicente Todolí
Sino al 18 febbraio 2024
L’opera e la memoria di James Lee Byars (1932-1997) sono emblematiche di molta arte della seconda metà del Novecento e del XXI secolo. Le sue installazioni, sculture, performance oscillano infatti tra il sublime e il kitsch. Costituiscono quasi degli archetipi di queste due dimensioni delle arti visive e dell’estetica. E lo fanno a partire già dai colori.
Del significato dell’oro e del suo giallo Byars è perfettamente consapevole quando scrive che misterioso è il suo effetto «sulle persone; per alcuni è decadente e insignificante. Per me non è così: l’oro mi proietta verso la dimensione dell’infinitamente mistico. Raramente penso all’oro come a qualcosa di decorativo. Per me è un elemento spirituale» (Depliant della mostra, p. 22). E infatti numerose opere sono ricoperte da una patina d’oro e riverberano un giallo splendente.
Il rosso è affidato alle potenze indicibili, ai demoni, a una sfera composta da 3333 rose che nel periodo della mostra trascorrono da un colore vivissimo all’impallidire, allo sfiorire, al morire. Sempre intatte e di colore giallo sono invece le sfere che compongo la «tomba» che l’artista eresse a se stesso (è la sfera a sinistra nell’immagine di apertura) e la grande Golden Tower che accoglie il visitatore, la cui parte somma appare duplicata accanto alla torre – con la denominazione The Capital of the Golden Tower -, su una base nera che rende ancora più luccicante il riverbero dell’oro.

E dappertutto stanno il cerchio, la sfera, in generale le figure geometriche esemplate anche sul Timeo. «Nell’opera di Platone», scrive Byars «si trova una sublime definizione matematica della bellezza della sfera, in cui tutti i punti sono equidistanti. La superficie è liscia e levigata. Platone la eleva a una delle massime espressioni della bellezza, per poi addentrarsi nel concetto di cosmologia della Terra e dell’interpretazione religiosa» (Depliant, p. 15). Religioso non significa confessionale o fideistico ma attinente alla sfera del sacro, nella quale l’opera di questo artista tenta di immergersi in vari modi, forme, vibrazioni. Sfera del sacro che coincide in gran parte con la natura e la struttura del cosmo. Alcuni esempi sono; The Moon Books, «un grande tavolo rivestito in foglia d’oro sul quale sono disseminate sedici sculture in marmo bianco che rappresentano la luna nelle sue principali fasi – nuova, crescente, piena, calante» (p. 17);
le sfere rosse che compongono Red Angel of Marseille e quelle bianche di The Thinking Field.
Nell’immagine che documenta quest’opera, dietro le cento sfere bianche si intravede l’anfora di The Spinning Oracle of Delfi, riferimento ellenico che pervade l’estetica di Byars. Nei Greci e negli Egizi l’artista trova una spiegazione del vivere e del morire. L’ultima opera da lui realizzata è la monumentale Byars is Elephant (immagine di apertura), che così viene descritta dal curatore Vicente Todolí:
L’installazione è costituita da due componenti in netto contrasto: da una parte un cangiante telo dorato di grandi dimensioni che pende dal soffitto e si estende fino a coprire parte del pavimento, dall’altra una palla di corda intrecciata, appoggiata su un piedistallo, realizzata con pelo di cammello. Entrambi i materiali sono legati alla storia egizia, ma con significati diametralmente opposti: la corda è un prodotto povero, utilizzato già nell’antichità per issare i blocchi di pietra con cui sono state costruite le piramidi, mentre l’oro è legato alla figura del faraone ed è simbolo di immortalità. L’artista, che aveva trascorso i suoi ultimi giorni a Giza, in una stanza d’albergo da cui poteva contemplare le piramidi, straordinari esempi di forme geometriche perfette, sosteneva che gli Egizi fossero il popolo che più avesse esplorato e compreso il concetto di morte (pp. 16-17).
Tesi confermata da tutta la storiografia, a partire da Erodoto. Dove la dimensione sacra appare evidente è nelle grandi opere verticali come la Torre d’oro e The Figure of Death, autentico totem composto da dieci cubi di basalto che nella loro semplicità devono qualcosa al monolito di Kubrick , debito che mi sembra evidente anche in altri manufatti di Byars.
A chiudere la sintetica rassegna che ho tentato di questa mostra, segnalo l’installazione nella quale l’oro, la geometria, la sfera e lo spazio sembrano coniugarsi al meglio: la prospettiva con la quale sono strutturate e vengono guardate due opere: The Door of Innocence e The Figure of Question is in the Room, come se l’essere fosse perfetto, come se le forme immortali ed eterne fossero il vero mondo, del quale le strutture diluite e disordinate dentro cui siamo immersi sono soltanto un riverbero. Ancora una volta Platone.