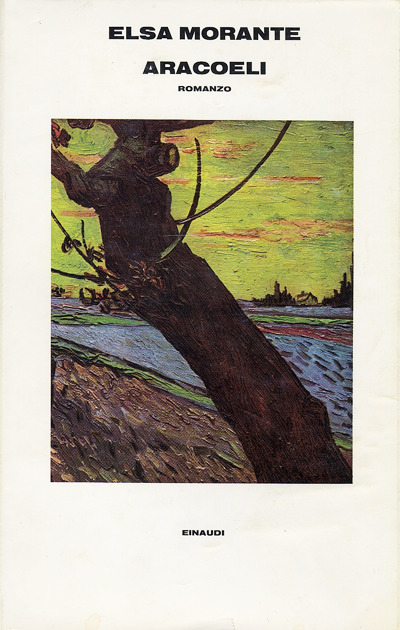Il 20 ottobre 2016 ho partecipato a un Convegno organizzato dalla Struttura didattica speciale di Lingue e Letterature straniere dell’Ateneo di Catania. Convegno voluto e introdotto da Nunzio Zago e dedicato ad alcuni Aspetti dell’ulissismo intellettuale dall’Ottocento a oggi. La sede è stata la magnifica città di Ragusa Ibla.
Ho partecipato per quello che sono, un dilettante di letteratura, e ascoltando i colleghi specialisti ho sentito l’orgoglio e l’onore di far parte di una comunità di ricerca umanamente coinvolgente e scientificamente feconda. Ho infatti imparato da tutti. Ricordo alcuni degli interventi, alla fine dei quali ho chiesto ai relatori la loro opinione sulla lettura che Horkheimer e Adorno hanno dato di Ulisse come emblema anche del borghese che persegue lucidamente i propri scopi in una logica utilitaristica. Chiarisco che quanto scrivo qui non costituisce una sintesi delle tesi enunciate dai colleghi ma si tratta soltanto di alcune mie riflessioni che partono dai loro eccellenti contributi.
Andrea Manganaro ha parlato dei personaggi di Verga e della loro corsa verso la morte. Ascoltandolo ho pensato al fatto che Ulisse torna da solo a Itaca, tutti i suoi compagni sono morti. Forse Ulisse è anche il potente di cui parla Canetti, è colui che differisce la propria morte attraverso il morire degli altri, a cominciare dalla distruzione imposta agli abitanti di Ilio.
Antonio Sichera analizzando l’opera di Pavese si è riferito alle motivazioni per le quali Ulisse rifiuta la straordinaria proposta di Calipso di renderlo immortale e sempre giovane, invece che tornare da una moglie umana. Forse il motivo di tale rifiuto sta nel fatto che Ulisse ha compreso l’infelicità di Calipso. La dea non si è conciliata con il tempo. Non il tempo Χρόνος, naturalmente, essendo lei divina, ma il tempo Aἰών. E invece Ulisse con il tempo si è conciliato, è stato capace di fare del futuro -dei propri desideri, ambizioni, aspirazioni- il suo stesso presente.
Fernando Gioviale ha raccontato di D’Arrigo. Non soltanto di Horcynus Orca ma anche dell’ultimo romanzo darrighiano, Cima delle nobildonne, un testo dedicato alla placenta. Anche Giuseppe Traina parlando di Bufalino ha accennato al ritorno all’utero.
Ascoltandoli mi sono ricordato di uno dei più grandi narratori del Novecento, Elsa Morante, forse troppo trascurata. Nell’ultimo suo romanzo, il figlio di Aracoeli si rivolge alla memoria della madre dicendole: «Ma tu, mamita, aiutami. Come fanno le gatte coi loro piccoli nati male, tu rimàngiami. Accogli la mia deformità nella tua voragine pietosa» (Aracoeli, Einaudi, 1982, p. 109). Ulisse è forse anche il desiderio del ritorno al luogo nel quale tutto era caldo, liquido, sicuro. Il luogo nel quale ogni voce, contatto, movimento, erano pura luce. Tornare a Itaca la madre, tornare a Itaca la Terra. Tornare all’intero da cui proveniamo.
Forse è anche per questo che Odisseo -come l’Ettore di Foscolo- vivrà «finché il Sole / risplenderà su le sciagure umane» (Dei Sepolcri, 294-295), vivrà nelle nostre parole, nei nostri studi, nel nostro tendere al luogo da cui proveniamo. Vivrà in quel νόστος che è l’intera esistenza.