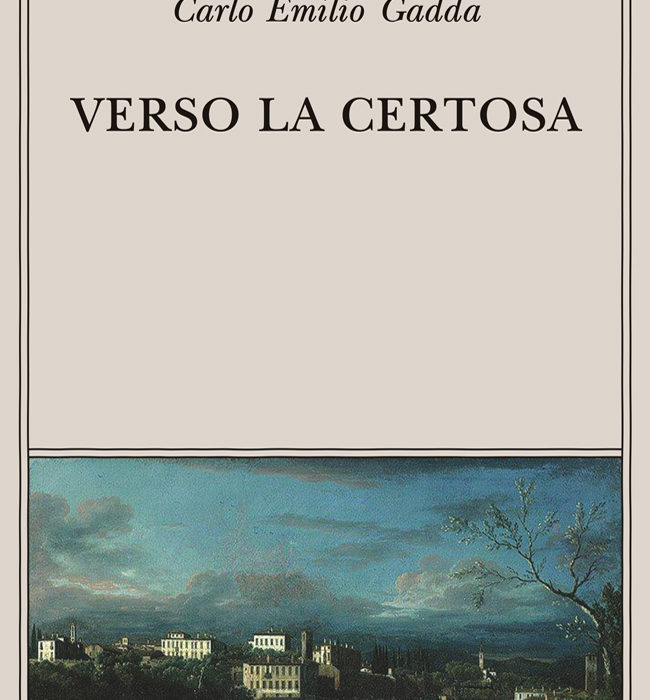Piccolo Teatro Strehler – Milano
La commedia della vanità
di Elias Canetti
Regia di Claudio Longhi
Traduzione: Bianca Zagari
Scene: Guia Buzzi
Con: Fausto Russo Alesi, Donatella Allegro, Michele Dell’Utri, Simone Francia, Diana Manea, Eugenio Papalia, Aglaia Pappas, Franca Penone, Simone Tangolo, Jacopo Trebbi
Violino: Renata Lackó – Cimbalom: Sándor Radics
Produzione Emilia Romagna Teatro Fondazione, Teatro di Roma–Teatro Nazionale, Fondazione Teatro della Toscana, LAC Lugano Arte e Cultura
Sino al 26 gennaio 2020
Un regime volto al bene dei suoi cittadini intende purificarli da uno dei vizi più fastidiosi e pericolosi per la vita collettiva: la vanità. Emana dunque decreti assai severi che impongono di bruciare tutte le fotografie e distruggere tutti gli specchi. Esaltate da questa eccitante novità, le folle accorrono al luogo dove l’Io viene in questo modo distrutto, o almeno impossibilitato a vedersi e rivedersi. La difficoltà di fare i conti con la propria immagine diffonde tuttavia nel corpo sociale una vera e propria nientità del mondo, che ha come effetto disturbi psichiatrici e rigonfiature enormi dell’invidia, dell’odio e degli altri vizi, come accade quando il venir meno di uno dei sensi rende più acuti tutti gli altri. Gli spacciatori di specchi fanno affari, vendendo la possibilità di contemplarsi per qualche minuto. Sorgono infine luoghi dove il vizio viene tollerato e venduto a prezzi di mercato, come nei bordelli. Solo che adesso a essere offerti a differenti tariffe non sono i corpi altrui ma la propria immagine. Perduta l’identità, senza la quale non è possibile alcuna vera relazione, a emergere saranno dei soggetti che ripetono ossessivamente IO mentre si sottomettono tutti al grande ego di un dittatore.
Come si vede, questa commedia giovanile di Elias Canetti (1905-1994), scritta fra il 1933 e 1934, mette in guardia da alcune delle più striscianti illusioni del nostro presente.
La prima è che si possano dichiarare fuori legge i sentimenti. Nella commedia si tratta della vanità, negli anni Venti del XXI secolo si tratta dell’odio. Le dinamiche sono analoghe e non possono che risultare distruttive e autoritarie. Le leggi possono proibire infatti delle azioni, dei comportamenti, non possono toccare i sentimenti, pena la perversione dell’intera vita collettiva. La conclusione della commedia è inevitabile: proibire i sentimenti non può che avere come esito una dittatura.
La seconda illusione consiste nell’attacco all’identità. Chi si pronuncia contro l’identità non soltanto afferma una evidente sciocchezza antropologica ma è causa di grave danno nelle relazioni private, storiche, sociali, collettive. È infatti possibile entrare in relazione con la differenza soltanto a partire da una già esistente identità. Dove non c’è identità non è possibile intrattenere alcuna relazione. È questo un dispositivo sia logico –per il quale A=A e A≠B si coappartengono, l’uno senza l’altro non si dà– sia ontologico, per il quale ogni ente non è mai soltanto un ente ma è anche un evento che è parte di un processo, e quindi ogni ente è una relazione che si origina sempre da ciò che l’ente è già e ciò che l’ente non è ancora.
 Si tratta di un dispositivo che agisce nell’opera fondamentale di Canetti, Massa e potere, e che nella commedia viene intuito e rappresentato mediante una struttura e un linguaggio espressionistici, che la messa in scena di Claudio Longhi rispetta nel grottesco dei movimenti, nella violenza del trucco sul corpo degli attori, nel vivace fracasso della prima parte e specialmente nell’opzione scenografica che riconduce e riduce la vicenda a quella di un circo degli anni Trenta, dentro il quale gli umani sono diventati un fenomeno da baraccone. Nelle quattro ore di spettacolo (una durata comunque eccessiva) sembra di assistere non soltanto a una commedia di Canetti ma anche a una serie di quadri di George Grosz. E tutto viene accompagnato dalle musiche dal vivo (violino e cimbalom) che danno ancor più l’impressione di stare dentro un circo. Il circo senza fine delle nostre vanità.
Si tratta di un dispositivo che agisce nell’opera fondamentale di Canetti, Massa e potere, e che nella commedia viene intuito e rappresentato mediante una struttura e un linguaggio espressionistici, che la messa in scena di Claudio Longhi rispetta nel grottesco dei movimenti, nella violenza del trucco sul corpo degli attori, nel vivace fracasso della prima parte e specialmente nell’opzione scenografica che riconduce e riduce la vicenda a quella di un circo degli anni Trenta, dentro il quale gli umani sono diventati un fenomeno da baraccone. Nelle quattro ore di spettacolo (una durata comunque eccessiva) sembra di assistere non soltanto a una commedia di Canetti ma anche a una serie di quadri di George Grosz. E tutto viene accompagnato dalle musiche dal vivo (violino e cimbalom) che danno ancor più l’impressione di stare dentro un circo. Il circo senza fine delle nostre vanità.