<E> la sibilla,
che con bocca delirante
proferisce cose non risibili,
privi di ornamenti e di aromi,
travalica con la sua voce i millenni,
per forza del dio.
(Eraclito, DK 92, trad. di G. Fornari, Eraclito: la luce dell’oscuro, p. 28)
Consapevole della «Moira invincibile» (Iliade, XIX, 410), della forza di Ἀνάγκη, ma fiduciosa che un ordine razionale possa essere dato al mondo, Delfi onora Zeus Moiragetus, il dio signore del fato. E pone suo figlio al centro del tempio più grande, al centro dell’intero santuario, al centro dell’oracolo il cui Signore «οὔτε λέγει οὔτε κρύπτει ἀλλὰ σημαίνει» (Eraclito, F 93), «non parla né nasconde, bensì suggerisce»1. Questo figlio, questo ἄναξ, questo signore di Delfi è Apollo, dio della conoscenza e dell’ordine ma anche della luce che acceca e del rancore che non perdona, la μῆνις. «Questa dualità di ordine e violenza nel carattere di Apollo Pizio a Delfi, come viene espressa attraverso le fonti relative alle origini del santuario, è una caratteristica importante del modo in cui i Greci concettualizzavano il ruolo di Delfi e di Apollo Pizio nel loro mondo, e rispecchia la dualità di centralità e conflitto che è il perno della vicenda di questa città nella storia antica»2 .
Apollo risiedeva a Delfi per nove mesi, poi si trasferiva in inverno presso gli Iperborei, lasciando il luogo sacro a Dioniso, suo fratello, in onore del quale venivano praticati riti segreti. Con un apparato di conoscenze storico-filologiche di gran lunga inferiori a quelle che possediamo oggi, Nietzsche aveva già compreso la natura dionisiaca di questo luogo, tanto da affermare che nel mondo greco «alla fine Apollo parla la lingua di Dioniso»3.
L’oracolo di Apollo fu attivo per millecinquecento anni ma fu una soltanto delle varie e numerose attività che si svolgevano a Delfi: giochi, feste, incontri politici. Ciò che sappiamo di certo sull’oracolo e sulle altre attività si deve soprattutto a Plutarco, che nel I secolo d.e.v fu sacerdote nel santuario e scrisse molto su quanto in esso accadeva e sul significato di tale accadere. In ogni caso, però, «non ci è rimasto nessun resoconto chiaro e completo di come si svolgesse di preciso una consultazione dell’oracolo di Delfi, o di come giungesse alla sacerdotessa pizia l’ispirazione divina» (12). Sappiamo invece, tra le tante altre informazioni, che all’oracolo non venivano poste quasi mai delle domande su specifici fatti futuri ma degli interrogativi su come interpretare tali eventi e sul modo in cui viverli. Si trattava di un oracolo semantico e sociale: «Nel complesso, dobbiamo intendere la Pizia delfica non come un ‘servizio di predizione del futuro’, ma piuttosto come un ‘meccanismo per la creazione di senso’ ad uso di individui, città e comunità dell’antica Grecia» (28).
E questo fu possibile perché «il mondo greco era colmo di un ‘brusio costante’ di comunicazione divina» (23), un dialogo con le forze profonde -ctonie e celesti- talmente potente che, osserva giustamente Michael Scott, ancora oggi chi visita Delfi sente che «c’è una magia nell’aria, diversa da qualsiasi altro luogo io abbia visitato» (4).
Una potenza che fece di Delfi, specialmente dopo il felice esito delle Guerre persiane, il centro del mondo greco e che però la trasformò in uno spazio paradossale. Era infatti «un oracolo che godeva del rispetto di tutti, aveva secoli di autorità alle spalle ed era sede di un santuario sfarzoso, colmo di centinaia di monumenti offerti da tutto il mondo mediterraneo; ospitava gare atletiche e musicali apprezzate in tutta la Grecia; ed era gestito da un’associazione interregionale di città e Stati. Ma allo stesso tempo era una piccola comunità che viveva di espedienti, aggrappata sul fianco di una montagna della Grecia centrale» (128).
Una comunità che conservò sempre il rispetto costante e profondo della dominatrice del mondo, Roma. La quale non soltanto lasciò al santuario la sua autonomia ma lo arricchì di opere, ne finanziò l’attività, ne ammirò la sapienza e l’enigma. Tra gli imperatori che visitarono e amarono Delfi, il più immerso nel suo significato fu Adriano (in carica tra il 117 e il 138), il cui attaccamento alla città e le cui cure «rappresentano senza dubbio uno dei momenti culminanti della storia di Delfi» (203).
 Cristianizzata e poi inabissata durante il Medioevo, Delfi rinacque a partire dall’Umanesimo, per diventare un sito fondamentale della ricerca archeologica internazionale. A distanza di millenni, Delfi riceve oggi ogni anno più di due milioni di visitatori ed è un luogo sul quale c’è ancora molto da indagare e da scoprire. «È un lavoro senza fine» (247) poiché Delfi è uno spazio di «accesso alla conoscenza, nonché di pensiero filosofico» (253), è un enigma che non smette di dire -al suo consueto modo- parole essenziali e segni/bagliori. Nel suo museo guarda ancora il mondo la sfinge dei Nassi (che vedete qui a sinistra), una scultura del VI secolo a.e.v.che raffigura un’entità che è «in parte essere umano, in parte mammifero e in parte uccello, che a sua volta rispecchia il mistero di Delfi stessa» (262).
Cristianizzata e poi inabissata durante il Medioevo, Delfi rinacque a partire dall’Umanesimo, per diventare un sito fondamentale della ricerca archeologica internazionale. A distanza di millenni, Delfi riceve oggi ogni anno più di due milioni di visitatori ed è un luogo sul quale c’è ancora molto da indagare e da scoprire. «È un lavoro senza fine» (247) poiché Delfi è uno spazio di «accesso alla conoscenza, nonché di pensiero filosofico» (253), è un enigma che non smette di dire -al suo consueto modo- parole essenziali e segni/bagliori. Nel suo museo guarda ancora il mondo la sfinge dei Nassi (che vedete qui a sinistra), una scultura del VI secolo a.e.v.che raffigura un’entità che è «in parte essere umano, in parte mammifero e in parte uccello, che a sua volta rispecchia il mistero di Delfi stessa» (262).
«Stizzita per la scemenza dei suoi stessi oracoli e per l’ingenua credulità dei Greci […] ascoltò le domande del giovane Edipo, un altro che voleva sapere se i suoi genitori erano davvero i suoi genitori, come se fosse facile stabilire una cosa del genere nei circoli aristocratici, dove, senza scherzi, donne maritate davano a intendere ai loro consorti, i quali peraltro finivano per crederci, come qualmente Zeus in persona si fosse giaciuto con loro»4. Per toglierselo di torno la sacerdotessa Pannychis XI profetizzò a Edipo l’esito più inverosimile: che avrebbe ucciso il padre e sposato la madre. E tuttavia quell’oracolo si rivelò vero. Perché Apollo Pizio sorride. Sorride sempre.
È tale sorriso che ho percepito nello spazio e dentro di me quando ho visitato questo luogo senza pari.
Note
1. Così ben traduce Giuseppe Fornari a partire dall’esegesi di Serge Mouraviev, in Eraclito: la luce dell’oscuro, Olschki 2017, p. 28.
2. Michael Scott, Delfi. Il centro del mondo antico (Delphi. A History of the Center of the Ancient World, Princeton University Press, 2014), trad. di D.A. Gewurz, Laterza 2015, p. 38. I riferimenti delle successive citazioni da questo libro sono indicati tra parentesi nel testo.
3. F.W. Nietzsche, La nascita della tragedia, in «Opere» III 1, Adelphi, p. 145.
4 F. Dürrenmatt, La morte della Pizia, trad. di Renata Colorni, Adelphi, p. 9
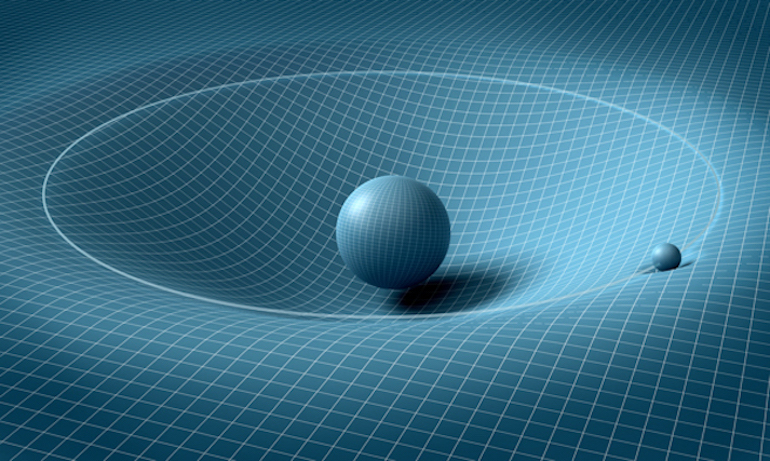






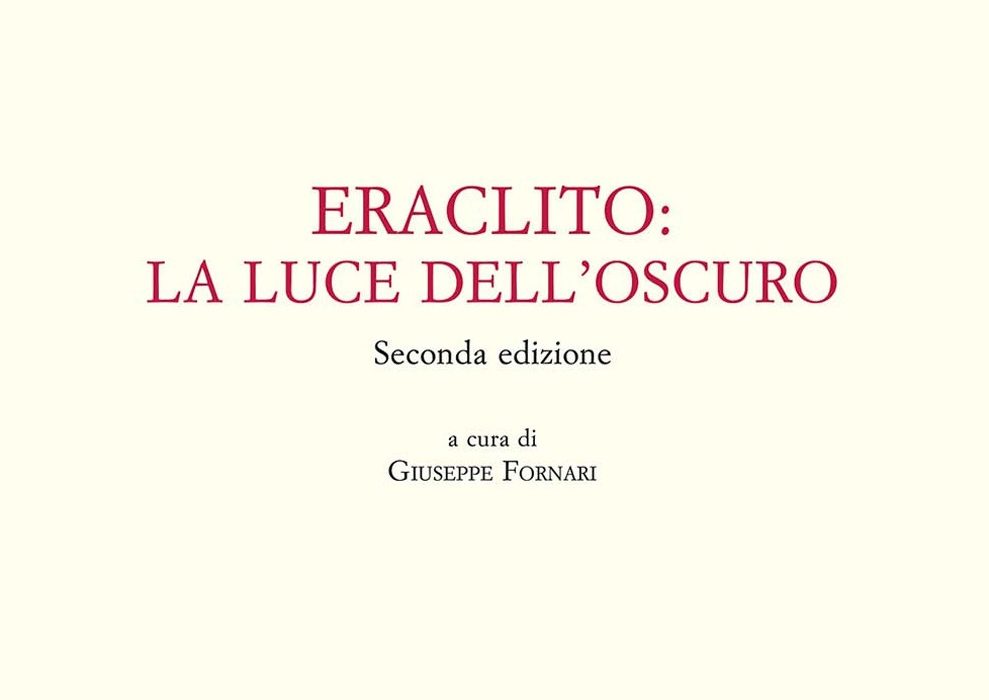

 Cristianizzata e poi inabissata durante il Medioevo, Delfi rinacque a partire dall’Umanesimo, per diventare un sito fondamentale della ricerca archeologica internazionale. A distanza di millenni, Delfi riceve oggi ogni anno più di due milioni di visitatori ed è un luogo sul quale c’è ancora molto da indagare e da scoprire. «È un lavoro senza fine» (247) poiché Delfi è uno spazio di «accesso alla conoscenza, nonché di pensiero filosofico» (253), è un enigma che non smette di dire -al suo consueto modo- parole essenziali e segni/bagliori. Nel suo museo guarda ancora il mondo la sfinge dei Nassi (che vedete qui a sinistra), una scultura del VI secolo a.e.v.che raffigura un’entità che è «in parte essere umano, in parte mammifero e in parte uccello, che a sua volta rispecchia il mistero di Delfi stessa» (262).
Cristianizzata e poi inabissata durante il Medioevo, Delfi rinacque a partire dall’Umanesimo, per diventare un sito fondamentale della ricerca archeologica internazionale. A distanza di millenni, Delfi riceve oggi ogni anno più di due milioni di visitatori ed è un luogo sul quale c’è ancora molto da indagare e da scoprire. «È un lavoro senza fine» (247) poiché Delfi è uno spazio di «accesso alla conoscenza, nonché di pensiero filosofico» (253), è un enigma che non smette di dire -al suo consueto modo- parole essenziali e segni/bagliori. Nel suo museo guarda ancora il mondo la sfinge dei Nassi (che vedete qui a sinistra), una scultura del VI secolo a.e.v.che raffigura un’entità che è «in parte essere umano, in parte mammifero e in parte uccello, che a sua volta rispecchia il mistero di Delfi stessa» (262).