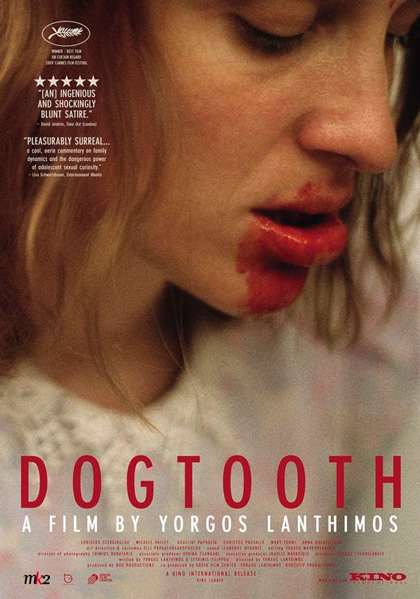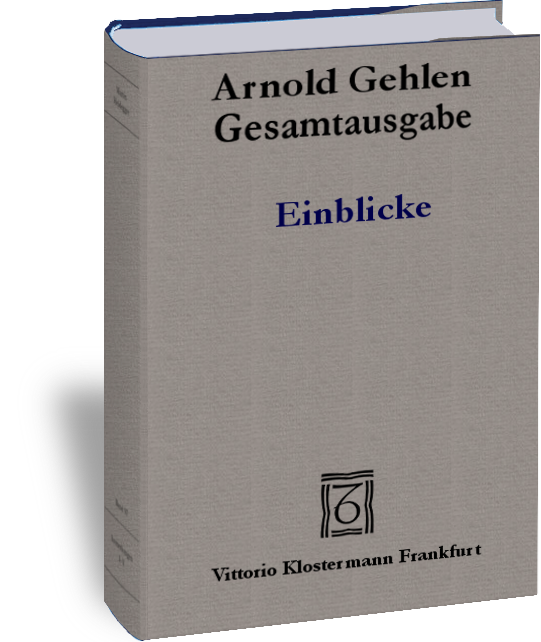The Imitation Game
di Morten Tyldum
Gran Bretagna – USA, 2014
Con: Benedict Cumberbatch (Alan Turing), Keira Knightley (Joan Clarke), Mark Strong (Stewart Menzies), Matthew Goode (Hugh Alexander), Charles Dance (Denniston), Rory Kinnear (Nock)
Trailer del film
L’esercito tedesco andava conquistando tutte le capitali europee. Londra subiva massicci attacchi aerei e non riceveva più rifornimenti a causa delle incursioni contro le sue navi. Gli inglesi erano riusciti a procurarsi un esemplare della macchina con la quale i comandi tedeschi scambiavano tra di loro informazioni criptate. Macchina chiamata Enigma, che alla mezzanotte di ogni giorno modificava i propri codici rendendo impossibile ogni tentativo di decifrazione. Alan Turing -un matematico di Cambridge non ancora trentenne- venne posto alla direzione del progetto volto alla decodificazione di Enigma. Turing progettò e realizzò un’altra macchina –Bomba– in grado di raggiungere l’obiettivo, dando in questo modo un contributo fondamentale alla vittoria degli Alleati nella II Guerra mondiale. Di questa operazione, assolutamente segreta, vennero cancellate quasi tutte le tracce. E così quando nel 1951 Alan venne inquisito per omosessualità -reato rimasto in vigore in Gran Bretagna sino al 1967- non ci fu nessuno a difenderlo, a dimostrare quanto la nazione inglese gli dovesse. Condannato al carcere o alla castrazione chimica, Turing scelse la seconda soluzione. Alla fine preferì uccidersi, mordendo una mela con dentro del cianuro (Apple?). Nel 2009 il governo inglese formulò le scuse ufficiali per questo suicidio-omicidio e nel 2013 la regina Elisabetta II elargì a Turing la grazia postuma.
The Imitation Game racconta in modo classico e inevitabilmente fantasioso questa vicenda (i documenti furono appunto in gran parte distrutti), intersecando i piani temporali che dal processo degli anni Cinquanta vanno agli anni del conflitto e a quelli del College. In verità, in che cosa sia consistito il genio di Turing non viene mai davvero spiegato. Il titolo del film allude (senza parlarne mai) al celebre Test con il quale Turing volle sostenere la possibilità per le macchine non di pensare -questione secondo lui mal posta- ma di comportarsi come se stessero pensando. Se infatti un software (come il Siri dell’iPhone) risponde alle domande di un interlocutore in un modo indistinguibile dalle risposte che darebbe una persona, secondo Turing ciò dimostra che il software ha capacità logico-sintattiche analoghe a quelle di un cervello umano. Su questa base comportamentista Turing progettò la sua altrettanto famosa Macchina, la quale costituisce la struttura di base anche del computer sul quale sto scrivendo. Si tratta infatti di una macchina digitale che può compiere qualunque calcolo mediante la logica binaria dello 0/1, dell’accesso/spento. Turing era convinto che al più tardi entro gli anni Sessanta del Novecento le macchine/software sarebbero state indistinguibili dagli umani. E tuttavia sono passati quasi ottanta anni dall’articolo che diede inizio a tutto questo –On computable numbers, with an application to the Entscheidungsproblem– (1936)- e nessun software è stato sinora in grado di superare il Test di Turing. La ragione l’hanno indicata molti filosofi -tra i quali John Searle con il suo celebre esperimento mentale denominato Chinese Room– e consiste sostanzialmente nel fatto che il pensiero è un’attività certamente anche sintattica ma soprattutto semantica e pragmatica. Pensare non vuol dire processare simboli, in forma binaria o in altro modo, ma conoscere il significato di quei simboli ed essere in grado di utilizzarli nel movimento spaziotemporale in cui l’esserci consiste. E questo nessun software/hardware conosciuto è in grado di farlo.
«Lo stesso Turing –che era stato spinto ai suoi studi anche dalla speranza che la mente del suo amico più caro e morto prematuramente esistesse ancora da qualche parte, seppure separata dai suoi atomi– riconobbe che intelligenza e mente non possono esistere senza una qualche relazione con il mondo» (La mente temporale. Corpo Mondo Artificio, p. 230). Quell’amico si chiamava Christopher Morcom e Christopher è il nome che nel film Alan dà alla sua macchina. L’enigma più grande rimane il nostro corpomente e la sua coscienza d’esistere, comprese le passioni che lo intessono.