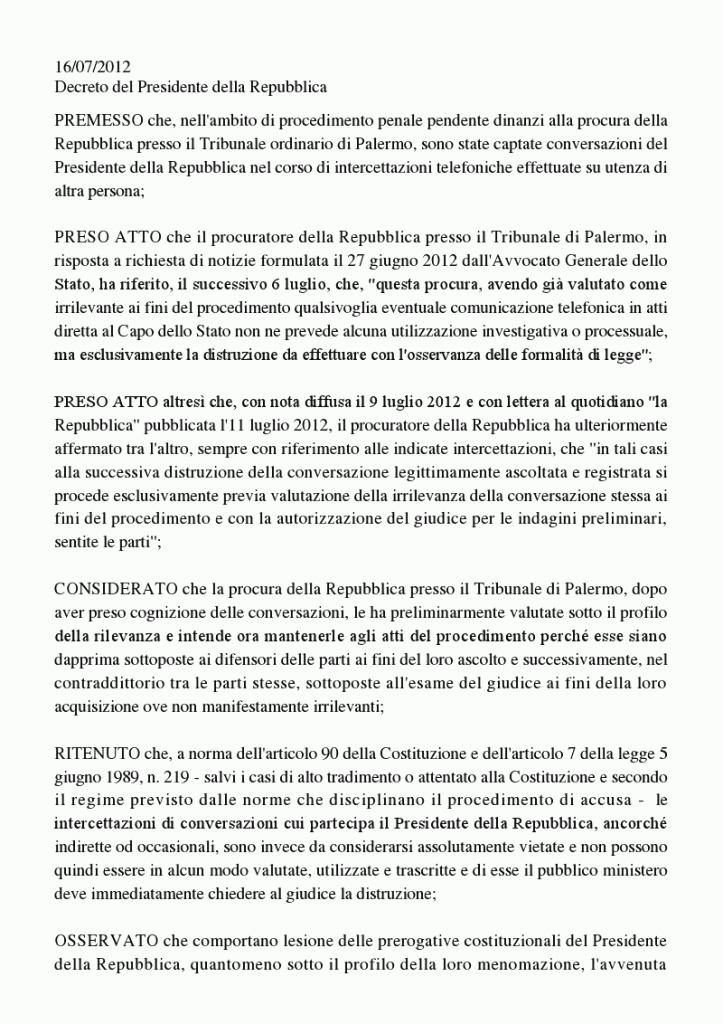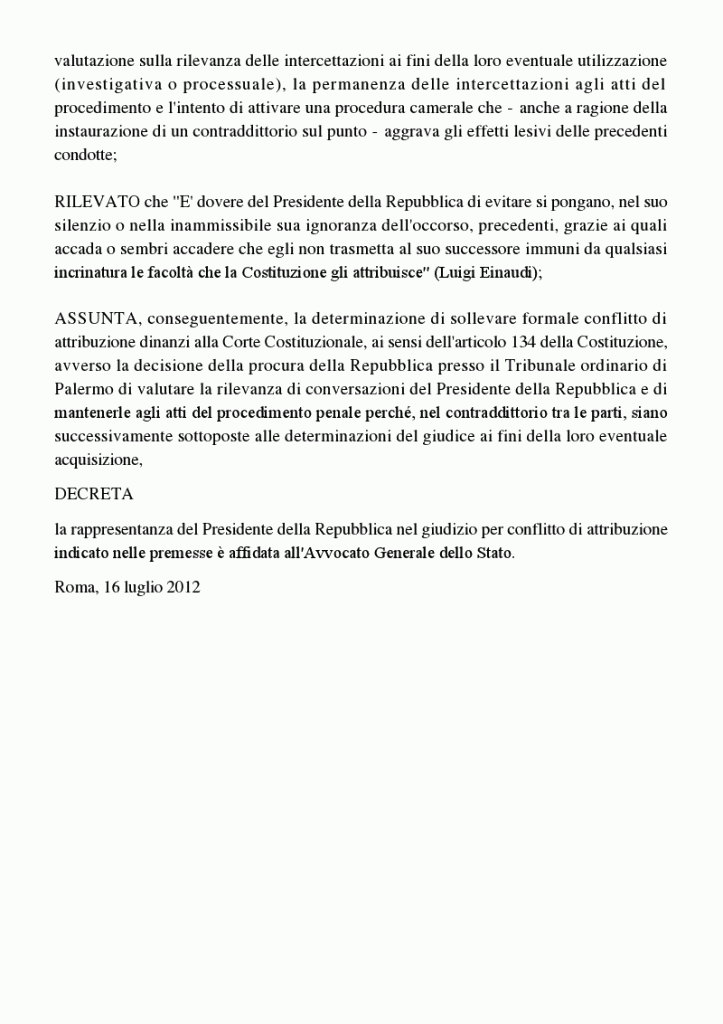Vincenzo Consolo
Lo spasimo di Palermo
Mondadori, 1998
Pagine 133
La scrittura di Consolo è intessuta di poesia, di un suo particolarissimo sperimentalismo, dell’intreccio fra lingua colta e antica parlata popolare. La ricchezza stilistica e lessicale di questa scrittura ha saputo tenere conto degli esempi di Gadda e di Vittorini, componendo però una tavolozza di parole e di stilemi del tutto originale. La tensione lirica di Consolo giunge spesso sino alle soglie del silenzio e dello strazio.
Il protagonista del romanzo, lo scrittore Gioacchino Martinez, dichiara di rifiutare ormai «il romanzo, questo genere scaduto, corrotto, impraticabile. Se mai ne aveva scritti, erano i suoi in una diversa lingua, dissonante, in una furia verbale ch’era finita in urlo, s’era dissolta nel silenzio» (p. 105).
Questa lingua racconta le vicende dello scrittore fra l’infanzia in Sicilia durante la Seconda guerra mondiale, la vita poi a Palermo con la moglie e il figlio, lacerata e dissolta dalla rapacità della mafia edile, la fuga a Milano e le delusioni patite nella città lombarda, l’arresto del figlio Mauro per terrorismo e la sua latitanza a Parigi dove il padre –morta Lucia, la moglie– va a trovarlo. Il finale ritorno di Gioacchino a Palermo lo immerge in una città che è
intrigo d’ogni storia, teatro di storture, iniquità, divano di potenti, càssaro dei criadi, villena degli apparati, osterio di fanatismo, tribunale impietoso, stanza della corda, ucciardone della nequizia, kalsa del degrado, cortile della ribellione, spasimo della cancrena, loggia della setta, casaprofessa della tenebra, monreale del mantello bianco. Congiura, contagio e peste in ogni tempo (122-123).
L’intera Sicilia è «matrice d’ogni male, estremo lembo, perenne scivolio, annientamento» (76). L’isola è luogo privo ormai d’ogni speranza sotto il dominio generale della mafia. Ma essa è ancora una volta la metafora di un mondo dove si combatte una guerra costante e criminale «contro lo Stato, gli Stati per il dominio dell’illegalità, il comando dei più immondi traffici» (128).
«In questo tempo feroce e allucinato» (42), tra la notturna gente che popola le strade, gli spazi, le case, nulla sembra salvarsi, non rimane luogo alcuno nel quale tentare -per Gioacchino, per Consolo, per chiunque- un riparo dalla malvagità dei padri che hanno tradito le speranze; dei figli che si sono nutriti di rovinose illusioni; dell’affarista di una città smarrita «nell’affanno d’ogni traffico, guadagno, nel cupo fanatismo del denaro», tale è Milano (80); del rivoluzionario che «seduce, indica simboli, spinge all’assassinio. Sorride, mostra la bava ansiolitica» (83); dei sovversivi diventati affaristi, capaci quindi di utilizzare prima l’ideologia e poi le televisioni per il loro costante, sconfinato e volgare narcisismo di ieri, di oggi, di sempre: «Da loro s’era installato il piccolo borghese, figlio dell’angustia, della frustrazione impiegatizia, del pallore urbano, fattosi in quel frangente il più acceso, il più torbido dei capi, s’era esaltato per l’accoglienza nei salotti, la frequentazione dell’editore, il filosofo, il prete, l’industriale, nudo davanti allo specchio, studiava pose, giocherellava con la pistola» (90).
Il mondo perduto in cui Gioacchino si sente immerso sembra trovare un qualche riscatto in un vecchio fioraio che parla per proverbi antichi e in un giudice che agli occhi di Martinez somiglia al protagonista di un film visto negli anni dell’infanzia. Quel magistrato viene spesso a trovare la madre, dirimpettaia di Gioacchino. Ma in una domenica sciroccosa di luglio fu «il gran boato, il ferro e il fuoco, lo squarcio d’ogni cosa, la rovina, lo strazio, il ludibrio delle carni, la morte che galoppa trionfante» (130). Perfino l’appartamento dello scrittore era servito a preparare l’attentato contro Paolo Borsellino.
Durante un viaggio con la moglie Lucia nei luoghi interni dell’Isola, i mosaici di Piazza Armerina suscitano sentimenti quasi di rimpianto per «le fiere d’Africa, gli animali rari, le nude fanciulle aggraziate (“Com’erano libere, serene quelle donne!”) e la gioia per i bimbi e gli amorini che cacciano, pescano, giocano» (78).
Questa breve scena pagana, posta quasi a contraltare dell’eccesso di figure del barocco cristiano, impasta di sé un romanzo bello e amaro, nel quale Consolo ammette lo scacco delle utopie sociali, tornando a una forma individuale e panica di giustizia, nel silenzioso grido che lo chiude: «Si sollevò stordito, sanguinante, alzò le braccia, gli occhi verso il cielo fosco. Cercò di dire, ma dalle secche labbra non venne suono. Implorò muto O gran mano di Diu, ca tantu pisi, / cala, manu di Diu, fatti palisi!» (131).