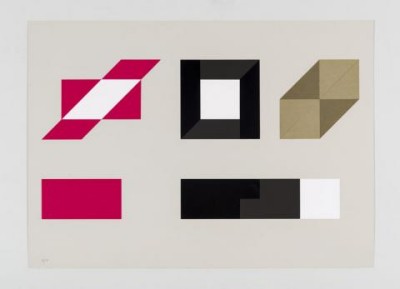Recensione a:
Carl Gustav Jung
Sincronicità come principio di connessioni acausali
(Synchronizität als ein Prinzip akausaler Zusammanhänge, 1952)
Antologia ragionata con testo tedesco a fronte
A cura di Lucia Guerrisi
Traduzione e Nota editoriale di Vincenzo Cicero
ELS La Scuola / Editrice Morcelliana, 2018
Pagine 240
in Diorama Letterario – numero 376 – Novembre/Dicembre 2023
pagine 39-40
Rispetto al dogmatismo monocorde della psicoanalisi freudiana, la psicologia dinamica – o analitica – di Carl Gustav Jung (1875-1961) non scambia le funzioni della mente per delle realtà assolute e per strutture empiriche. Essa delinea invece un quadro mosso e profondo dell’unità psicosomatica che siamo. Per Jung la mente è un evento plurale, intersoggettivo, cangiante. È un dispositivo di comunicazione dentro il quale si crea una realtà nomade e complessa al cui interno prevalgono di volta in volta determinate sensazioni, credenze, sentimenti, poiché la vita psichica è frutto di un dinamismo senza posa tra elementi molto diversi. La salute mentale consiste nella accettazione e gestione della pluralità che ci costituisce, la malattia mentale deriva in gran parte dal prevalere di una sola istanza su tutte le altre.
Razionalità e irrazionalità sono categorie insufficienti – se opposte l’una all’altra – a cogliere il flusso potente e antico della vita psichica, dentro la quale vige una dinamica di identità e differenza tra da una parte le capacità logiche e formali di raffreddamento del vissuto e dall’altra la potenza dei desideri, dell’inspiegabile e dell’immotivato. Queste strutture pulsano in un movimento prima di tutto emotivo, poiché è proprio la ragione a operare sull’inconscio e sulle sue passioni ed è la passione a offrire alla razionalità la capacità di agire nel tessuto quotidiano della vita.
Un concetto che rappresenta un esempio concreto di tale dinamica/struttura è quello di sincronicità. Il libro che ne parla conferma quanto sia profondo, inquietante e discutibile tutto il pensiero di Jung.