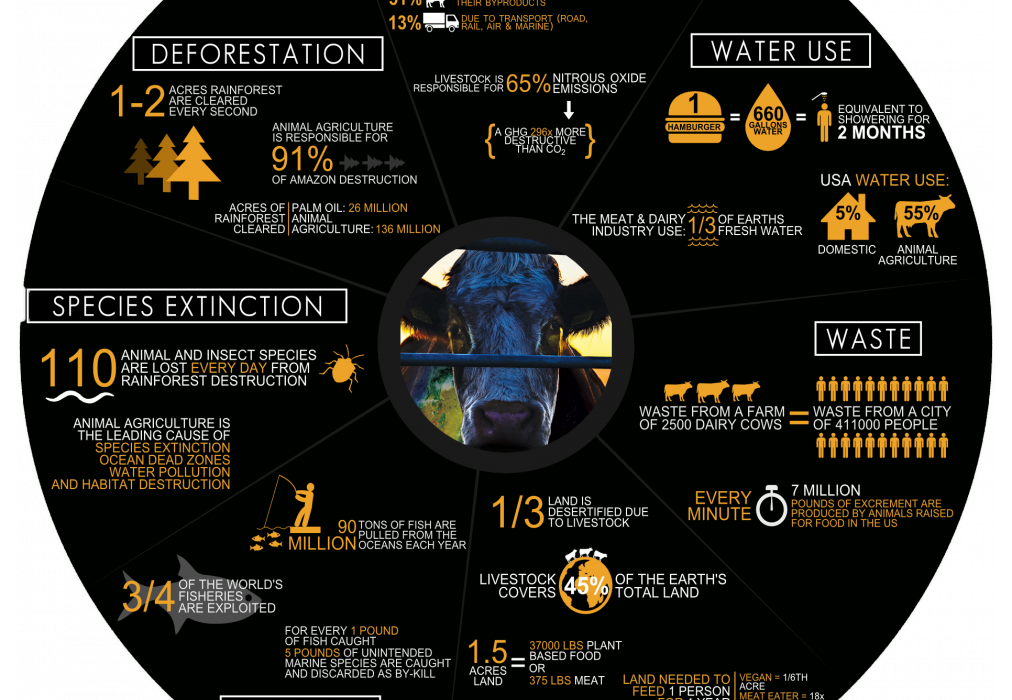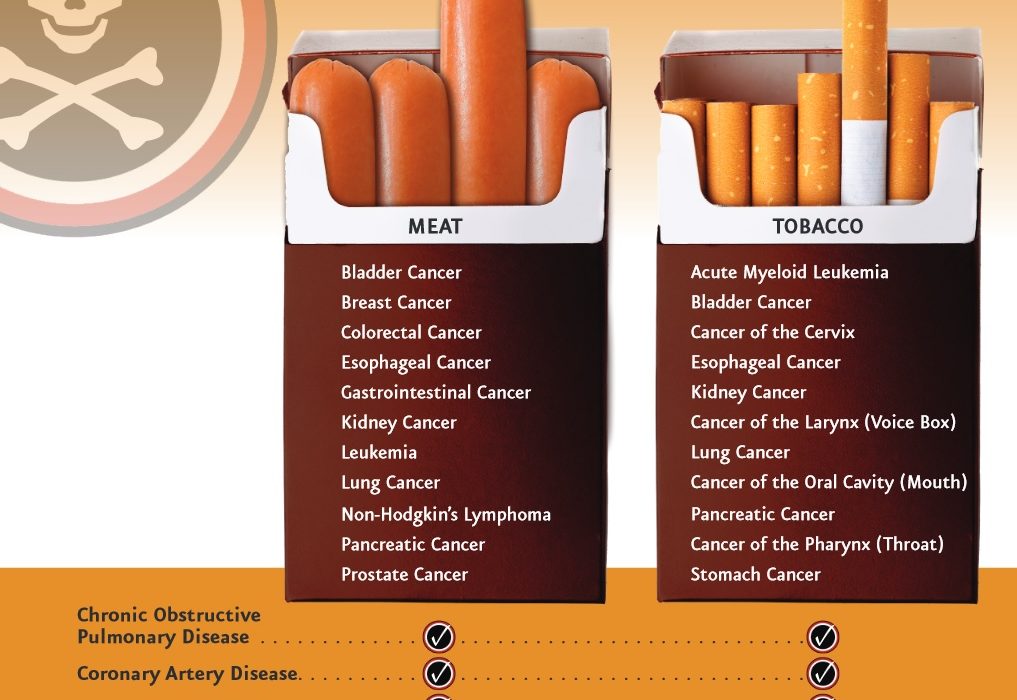Jean-Baptiste Del Amo
Regno animale
(Règne animal, Gallimard 2016)
Trad. di Margherita Botto
Neri Pozza Editore, 2017
Pagine 411
Due intervalli temporali, due epoche che si intrecciano e convergono «scontrandosi all’infinito con le tenebre» (p. 321).
Dal 1898 al 1917 si svolge la fatica quotidiana, dura, impassibile di una coppia di contadini in un piccolo paese della Francia, «nella ripetizione dei gesti da epoche immemorabili» (29). La genitrice secca come un ramo, bigotta, sprezzante verso i paesani. Il padre silente, già malato, minerale. Éléonore nata da un amplesso veloce e spento, senza amore, e tuttavia «avida di esistere» (28). Un mondo di campi e di animali che non ha nulla di nostalgico, idilliaco, sentimentale, e mostra invece «i corpi di tutti loro, i contadini, l’odore della loro razza spregevole, delle loro carni misere e stremate, e all’improvviso le sembrano tremendamente fragili, vecchi già a quarant’anni con la morte che gli incombe sul capo, gozzuti, amputati da lame, calcinati dal sole» (118), contigui alle loro bestie e tuttavia di tali bestie insieme padri, giudici, boia. In questo tempo e in questo luogo «uomini e animali nascono, vivacchiano e scompaiono; il padre sopravvive, per miracolo o per disgrazia, fino a metà marzo, poi finalmente muore» (68) e a prendere il suo posto nei campi e nelle stalle è il cugino Marcel, del quale la piccola Éléonore naturalmente si innamora. Sino al punto da accettarlo anche quando la tremenda cesura della guerra restituisce del volto di Marcel una maschera tranciata, non umana.
La guerra. La Prima guerra mondiale che pone fine al regno arcaico dell’Europa agricola e patriarcale, trasformando i contadini in assassini. «Hanno affondato lame nel collo dei maiali e nell’orbita dei conigli. Hanno sparato alla cerbiatta, al cinghiale. Hanno annegato i gattini e sgozzato la pecora. Hanno messo trappole per la volpe, avvelenato i topi, hanno decapitato l’oca, l’anatra, la gallina. Hanno visto uccidere da quando sono nati. Hanno guardato i padri e le madri togliere la vita agli animali. Hanno imparato i gesti, li hanno riprodotti. Anche loro hanno ucciso la lepre, il gallo, la vacca, il porcellino, il piccione. Hanno fatto scorrere il sangue, a volte lo hanno bevuto. Ne conoscono il gusto, l’odore. Ma un crucco? Come si ammazza un crucco?» (125).
La Prima guerra mondiale che sta all’origine dell’immensa sofferenza contemporanea. La guerra in cui i soldati vengono «polverizzati e sparsi tutto intorno, mentre le loro ossa si conficcavano come proiettili di shrapnel nel corpo degli altri uomini» (181-182). La guerra che requisisce ogni possibile risorsa togliendo dalle stalle le giovenche, i cavalli, i maiali necessari alla logistica e all’alimentazione. La guerra che trasforma le retrovie in immensi macelli, degni di quelli di Chicago ai quali i nazionalsocialisti si ispirarono per progettare e implementare i loro Lager: «Bisogna impastoiare l’animale che si dibatte in un ultimo tentativo di sopravvivenza, poi colpirlo con una mazza, più volte, fino a rompergli le ossa del cranio, spappolargli il cervello che sprizza dall’orecchio quando la bestia cade su un fianco e muore sussultando su un letto di visceri ancora caldi. Le lame delle mannaie hanno perso il filo a furia di tranciare ossa e tendini. I coltelli non tagliano più le gole; allora i macellai le segano. Alcuni agnelli urlano giorno e notte mentre le loro madri vengono legate per le zampe, appese e sventrate da vive» (155). Azioni come queste si moltiplicano allo scopo di nutrire la carne umana che i cannoni e le granate di una guerra abietta trasformeranno in fango.
1981. Éléonore è la matriarca della fattoria che è diventata ora un allevamento industriale di maiali. Il figlio avuto da Marcel, Henri, ha generato Serge e Joël. Serge ha generato Julie-Marie e Jérôme. Catherine, moglie di Serge, rifiuta quel luogo di puzza e di sterminio, respinge i familiari che «hanno acquisito, di generazione in generazione, questa capacità di produrre e trasudare l’odore dei maiali, di puzzare spontaneamente di maiale» (216) e si chiude in se stessa, si spranga dentro il sogno spezzato della vita.
Vita che muore è infatti quella che trionfa nella estesa porcilaia dentro la quale Henri, Serge e Joël divengono una cosa sola con gli animali, diventano i loro tiranni e insieme le loro vittime. Un mondo di verri, di scrofe, di suinetti, di maiali e di fattrici, nel quale «lo sperma stilla, sgocciola, cola» (25) insieme alle deiezioni e agli escrementi che vanamente i tre uomini cercano di contenere: «I maiali pisciano e cacano tutto il giorno nell’esiguo spazio dei recinti che a malapena permette loro di muoversi, li costringe a evacuare sotto di sé, a calpestare i loro escrementi, sdraiarvisi sopra, rotolarvisi, finché l’urina sprizzata rumorosamente dalla vulva e dal pene non scioglie le feci agglutinate, gli stronzi che esplodono, formando un fango nel quale scalpicciano e affondano automaticamente il grugno sbigottito e inutile. Quella diarrea straripa, esonda da ogni minimo interstizio, da ogni minima fenditura, cola su ogni minima pendenza del terreno, ristagna in pozze spesse e nere negli avvallamenti e nelle aree piatte» (245).
Tutto questo diventa cibo, mortadella, prosciutto, costolette. Gli allevamenti industriali di maiali e di altri animali producono «un’immensa infezione pazientemente contenuta e controllata dagli uomini, fino alle carcasse che il mattatoio rigurgita nei supermercati per quanto vengano lavate con la candeggina e tagliate a fette rosa e poi imballate nel cellophane su vassoietti di polistirolo di un bianco immacolato, si portano dietro l’invisibile lerciume della porcilaia, infime tracce di merda, i germi e i batteri contro i quali loro combattono una battaglia che pure sanno persa in partenza […], tutto questo per rimediare alle carenze e alle deficienze deliberatamente create dalla mano dell’uomo» (285), generando «un circolo virtuoso o infernale in cui la merda e la carne non sono più dissociabili» (304), emblema di un regno assai più vasto, l’intera materia vivente e come tale destinata alla decomposizione, «la porcilaia come culla della loro barbarie e di quella del mondo» (289).
Un mondo di sangue, di indifferenza e di sterco, di creature «meschine, subdole, calcolatrici, come sanno esserlo i bambini» (222), di gatti che sembrano e sono «piccole divinità atarassiche» (255). Un mondo fuori dalla fattoria che si mostra degno -nella sua ottusa violenza- della stessa porcilaia. Un mondo di suinetti fracassati contro i muri, di veleni che gli umani spargono e ingeriscono, dei quali si nutrono perché «ciò che spargono e polverizzano sulle terre da tanto tempo -il DDT, il clordano, i PCB- sono schifezze. […] L’incremento della resa è esponenziale, tutto li incoraggia all’uso dei pesticidi: l’Europa, le associazioni agricole, persino il buon senso. Hanno fede nel progresso, nella tecnologia e nella scienza» (322). In questo mondo funebre e demente, due entità accennano ad altre ontologie, ad altre luci.
La prima è un’antica quercia che «regna, indifferente al divenire degli uomini, alle loro vite e alle loro morti risibili. Amanti le hanno versato ai piedi il loro seme, uomini ubriachi e sprezzanti le hanno pisciato sul tronco, labbra hanno mormorato segreti e giuramenti negli incavi della sua corteccia. Capanne sono state costruite alla biforcazione dei rami per poi cadere a pezzi, abbandonate dai giochi dei bambini. Chiodi sono stati piantati e poi si sono arrugginiti e sono scomparsi. I vecchi passeggiano ancora dal paese al praticello, sul sentiero creato dagli andirivieni, per ripararsi alla sua ombra. Se conoscono l’albero da sempre, l’albero li conosce da sempre, loro e quelli fra i loro avi che hanno appoggiato una mano nello stesso punto, con la stessa carezza che accenna sul tronco la loro mano contorta, una mano di bimbo diventata mano di vecchio, e poi mano di bimbo nuovamente» (87).
La seconda entità è un maiale che Henri, Serge e Joël chiamano la Bestia. Un formidabile maschio frutto di incroci che lo hanno reso una creatura che «pesa quattrocentosettanta chili, è alta un metro e quaranta al garrese per quattro metri di lunghezza» (257). La Bestia riesce a fuggire dalla porcilaia e nella sua libertà «sente l’odore degli uomini lontano e come dissolto attraverso gli anni, stranamente rassicurante. Sgombera un angolo e si sdraia contro un muro. Tiene l’occhio aperto e scruta la notte» (408).
Il regno umano -naturale e mostruoso- trova un riscatto nell’altro da sé, nella differenza, in una quercia immobile, in un maiale in fuga. Il regno umano narrato in modo esatto, interiore e distante.