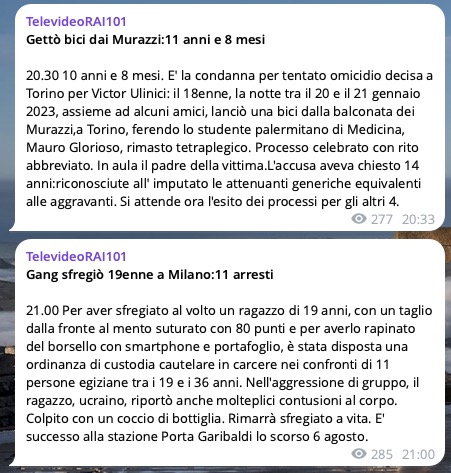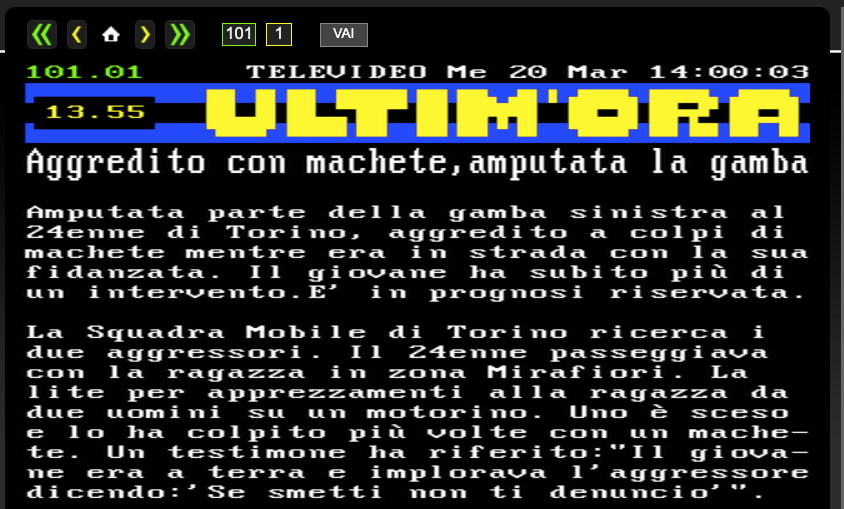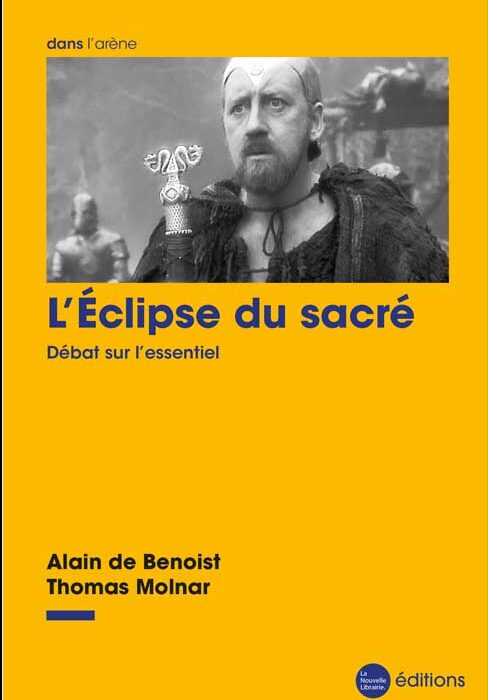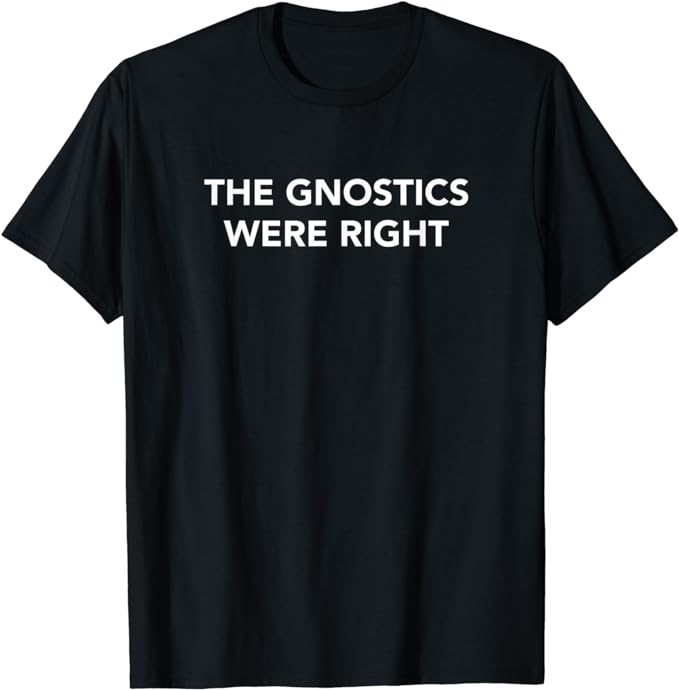
Tre notizie da Televideo Rai (19-20 marzo 2024), notizie tra le tante, notizie come sempre, notizie da millenni, notizie che mostrano e confermano con la chiarezza della sintesi che cosa l’umano sia, che cosa sia davvero.
L’umano è in gran parte – non del tutto, certo, ma appunto in gran parte – un grumo di profonda, istintiva, pura malvagità. L’umano è un animale non soltanto feroce ma di una ferocia anche sadica, vale a dire che gode, sinceramente gode, dei dolori che infligge e che vede. L’umano è un terrificante sterminatore di ogni altra specie animale; e infatti gli altri animali hanno ben imparato a guardarsi dall’essere umano: appena passiamo vicino a un gatto o a un cane randagio o a un uccello, questi subito si allontanano. L’umano è un’intelligenza posta in gran parte al servizio della guerra, della distruzione e della morte. L’umano, in sintesi, è non soltanto una nullità ontologica nel cosmo ma è anche un errore politico nella storia. L’umano è probabilmente una linea deviata e sbagliata dell’evoluzione animale, è un vicolo cieco.
L’umano è soprattutto la presunzione, l’arroganza e la ὕβρις di ritenersi, nonostante questa sua tenebrosa natura, «l’essere libero nel mondo della necessità, l’eterno taumaturgo, sia che agisca bene, sia che agisca male, la sorprendente eccezione, il super-animale, il quasi-Dio, il senso della creazione, il non pensabile come inesistente, la parola risolutiva dell’enigma cosmico, il grande dominatore della natura e dispregiatore di essa, l’essere che chiama la sua storia storia del mondo!» (Nietzsche, Umano, troppo umano II. Il viandante e la sua ombra, in «Opere», IV/3, af. 12, p. 141).
Le tre religioni del Libro – ebraismo, cristianesimo e islam – costituiscono l’espressione parossistica di tale pretesa. Esse ritengono che l’umano sia l’immagine di Dio e persino che Dio stesso sia diventato un uomo e sia stato torturato e ucciso per lui, un’idea francamente sconcertante. In sintesi, esse ritengono che l’essere umano sia un’espressione del sacro, pretesa che è una bestemmia e un sacrilegio. Ritenere entità sacre quelle che sono capaci di compiere azioni di gratuita, totale e inemendabile ferocia come quelle da cui sono partito e milioni di altre azioni analoghe delle quali la vicenda umana è costellata, ritenere davvero che i miliardi di essere umani transitati nella storia siano tutti figli di Dio e per questo sacri, è un’affermazione la cui tracotanza, narcisismo e stupidità appaiono palesi a ogni sguardo razionale, umilmente razionale, ontologicamente antropodecentrico.
In realtà alcuni, pochi, essere umani sono una luce per sé e per gli altri. La più parte costituisce una struttura ontologica miserabile e perduta. Questa è una delle verità della Gnosi, una tesi antropologica che mostra ogni giorno e ovunque la sua plausibilità.
È anche partendo da qui che uno gnostico contemporaneo ha potuto scrivere che la morale cristiana, e religiosa in genere, così come la morale kantiana sono in realtà un’immensa fatica «per non essere semplicemente, profondamente se stessi, cioè immondi, atroci, assurdi», una fatica volta a nascondere la radicale malvagità degli umani, la loro «sporca anima eroica e fannullona», una fatica volta a non capire «fino a qual punto gli uomini sono carogne», gli uomini, queste «bestie verticali» (Céline, Viaggio al termine della notte, Corbaccio 1995, pp. 459, 21, 33 e 159). Sono fatti, eventi e circostanze come quelli ricordati sopra, il cui numero è incalcolabile, a darne costante conferma.
L’umano è un orrore che l’intera storia della specie attesta e mostra. Due recenti testimonianze (tra le innumerevoli che sarebbe possibile addurre), sono un video di denuncia realizzato dalla LAV – Lega Antivivisezione che documenta l’inaudita crudeltà di due esseri umani contro un gregge di pecore e una come sempre pacata e implacabile riflessione di David Benatar dal titolo Un argomento misantropico per l’antinatalismo (testo pubblicato sul numero 29 di Vita pensata).
Ripeto: che una religione o un’etica possano definire i membri di una specie siffatta come tutti sacri o perché figli di un Dio o in quanto semplicemente esseri umani, è qualcosa che a uno sguardo disincantato e razionale appare non soltanto privo di ogni fondamento ma anche perverso.