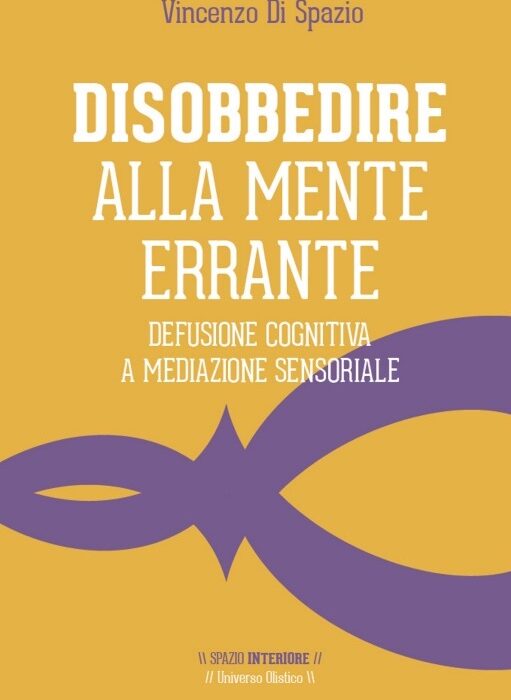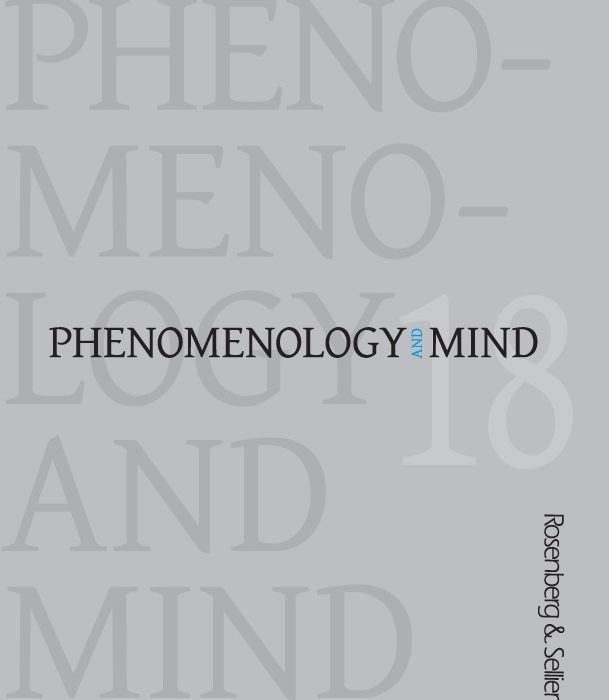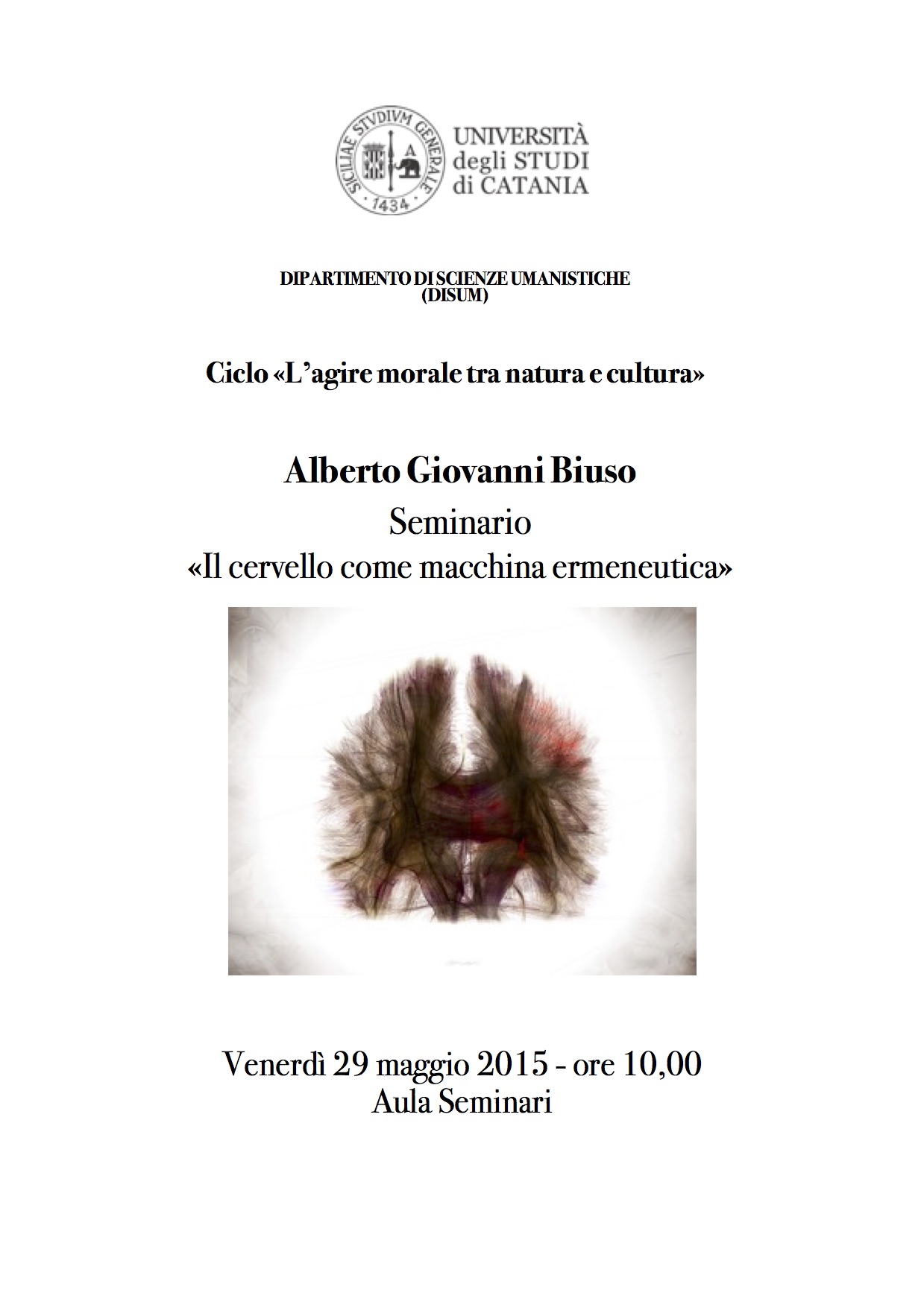Synecdoche, New York
di Charlie Kaufman
USA, 2008 (distribuito in Italia nel 2014)
Con Philip Seymour Hoffman (Caden Cotard), Samantha Morton (Hazel), Catherine Keener (Adele Lack), Michelle Williams (Claire Keen), Tom Noonan (Sammy Barnathan), Emily Watson (Tammy), Hope Davis (Madeleine Gravis), Dianne Wiest (Ellen Bascomb/Millicent Weems)
Trailer del film
 La sineddoche -insieme alla metonimia- è una delle figure retoriche più importanti, che utilizziamo di continuo nel nostro parlare. Consiste infatti nella sostituzione di un termine con un altro che abbia in comune con il primo elementi quali il genere, la quantità, l’estensione, come quando ad esempio si dice ‘molte braccia’ per indicare ‘molti lavoratori’, ‘due ruote’ per indicare una motocicletta oppure ‘l’italiano è estroverso’ per dire che a esserlo sono gli italiani. La parte per il tutto. Un singolo essere umano per l’intera specie.
La sineddoche -insieme alla metonimia- è una delle figure retoriche più importanti, che utilizziamo di continuo nel nostro parlare. Consiste infatti nella sostituzione di un termine con un altro che abbia in comune con il primo elementi quali il genere, la quantità, l’estensione, come quando ad esempio si dice ‘molte braccia’ per indicare ‘molti lavoratori’, ‘due ruote’ per indicare una motocicletta oppure ‘l’italiano è estroverso’ per dire che a esserlo sono gli italiani. La parte per il tutto. Un singolo essere umano per l’intera specie.
Ciascuno, in realtà, pensa a se stesso come all’esempio e all’incarnazione universale dell’umanità. Così, quando il regista Caden Cotard comincia a percepire nel proprio corpomente i sintomi della decadenza, della malattia, della depressione e della morte, è l’intero mondo che muta. Un premio ricevuto per la sua attività artistica gli consente di progettare, provare, realizzare l’opera totale: una messa in scena della propria vita mentre essa accade. Centinaia di attori, spazi enormi, scenografie che si moltiplicano perché dovrebbero rappresentare un intero mondo. Le identità/differenze tra gli attori, i personaggi, gli attori che interpretano gli attori del suo spettacolo mentre lo recitano, si confondono sino ad annullarsi. Nel senso che lo spettatore del film non riesce più a comprendere davvero chi sia chi, se si stia recitando il film o se si stia recitando dentro il film. I piani spaziali e temporali si confondono anch’essi, si dilatano, toccano il trascorrere di anni in pochi minuti e poche scene, mentre una sola giornata si allunga.
Sino a un certo momento tutto questo è tenuto sotto controllo. Poi, da quando la moglie di Cotard si trasferisce a Berlino con la propria amante e la bambina -gettando nella disperazione il marito-, l’intreccio di esistenza, teatro, eventi, incontri, repliche degli incontri, attori, sosia degli attori, diventa uno straordinario e lucido delirio identitario e spaziotemporale, la cui spiegazione è però incisa in due nomi: Capgras e Cotard.
Il nome di Capgras compare sul citofono dell’appartamento affittato dalla moglie del regista. Mentre gli altri nomi sono quasi illeggibili, questo viene messo in evidenza con dell’adesivo. Un cognome non certo casuale. I soggetti colpiti dalla sindrome di Capgras sono infatti convinti che familiari e amici siano in realtà dei sosia, degli attori che hanno preso il posto dei loro cari allo scopo di ingannare, far del male, distruggere la persona.
Il regista si chiama Caden Cotard. La sindrome di Cotard è ancora più grave, forse la più grave patologia psichiatrica che sia concepibile. Nella sua forma estrema il soggetto è convinto di essere morto. Nessuna persona, nessun ragionamento, nessuna prova possono smuoverlo da tale convinzione. La spiegazione più plausibile di questa tragedia della psiche sta nel fatto che a causa di lesioni organiche o di processi degenerativi i centri sensoriali non interagiscono più con le aree emotive dell’encefalo. Il cervello però cerca disperatamente di dare un significato al deserto emozionale che ne consegue. La spiegazione più logica è che chi non prova nessuna emozione deve in realtà essere già morto.
In una delle battute il regista afferma esplicitamente che «non è uno spettacolo solo sulla morte». Certo. Perché è a partire dal nostro essere finiti che la vita si declina secondo tutte le sue strutture. Il morire non è una parte dell’esistere ma costituisce il suo tutto, la sua sineddoche.
«Non è che l’esserci riempia con le fasi delle sue realtà effettuali istantanee una pista o un segmento sottomano “della vita”, ma estende se stesso, sì che il suo esser proprio è fin dapprincipio costituito come estensione. Nell’essere dell’esserci sta già il “tra” riferito a nascita e morte. […] L’esserci fattizio esiste per nascita, e per nascita muore anche proprio nel senso dell’essere-alla-morte. Entrambi i “capi” e il loro “tra” sono, finché l’esserci fattiziamente esiste, ed essi sono in quel modo che unicamente è possibile sulla base dell’essere dell’esserci come cura. Nascita e morte si “con-nettono”, nel modo che è proprio dell’esserci, nell’unità di dejezione e sfuggente o precorrente essere-alla-morte. In quanto cura, l’esserci è il “tra”» (Martin Heidegger, Essere e tempo, trad. di A. Marini, Mondadori 2006, § 72, p. 1051).
Capolavori. Sia il libro di Heidegger sia il film di Kaufman.